A cura di Andrea Turi
Il Centro Studi Eurasia e Mediterraneo ha intervistato Albert Ettinger sui fatti che hanno animato le regioni dello Xinjiang, del Tibet e di Hong Kong ma anche sulla situazione internazionale e sui rapporti tra Repubblica Popolare Cinese e Stati Uniti.
Signor Ettinger intanto la ringrazio per la sua disponibilità.
La nostra “intervista” sarà inserita nel Focus che il Centro di Studi Eurasia e Mediterraneo sta conducendo sullo Xinjiang. Prima di passare a parlare di questa regione autonoma della Cina, vorrei approfittare della sua conoscenza approfondita di un’altra regione autonoma della Repubblica popolare cinese, il Tibet.
Si parla molto meno del Tibet oggi che in passato. Cosa è successo nel frattempo e, soprattutto, perché l’hype mediatico si è calmato? Il Tibet è tenuto a “bagnomaria” ma la questione tornerà presto ad occupare un posto nella propaganda anti-cinese promossa dall’Occidente?
L’impressione che nella propaganda anti-cinese dei nostri principali media occidentali il Tibet sia stato messo da parte a favore dello Xinjiang non è certamente falsa. Ci sono diverse cause per questo.
Primo, c’è l’evoluzione nel Tibet stesso. Gli ultimi disordini orchestrati da Washington e Dharamsala dove risiede il “governo tibetano in esilio” risalgono ormai al 2008. Lo spettacolare boom economico in Tibet, dovuto ai massicci aiuti e alle grandi opere infrastrutturali da parte dello Stato cinese, ha fatto sì che sia diventato sempre più difficile descrivere il Tibet come “l’inferno in terra”. Poi la narrazione di “1,2 milioni di morti tibetane”, “genocidio” ed “etnocidio” è stata seriamente messa in discussione anche all’interno della cerchia dei sostenitori della “causa tibetana”.
Ma soprattutto il Tibet è meno importante dello Xinjiang da un punto di vista geostrategico: più ricco e popoloso, quest’ultima regione svolge un ruolo essenziale nel grande progetto cinese della “Nuova Via della Seta”. Il movimento separatista uiguro ha il vantaggio di avere stretti legami con l’islamismo politico, il jihadismo internazionale, il panturchismo e l’estremismo di destra turco (i “Lupi grigi”). Il suo potenziale di danno e, quindi, le possibilità di destabilizzare lo Xinjiang sono molto più alte rispetto alla situazione in Tibet.
Ciò non significa che la “questione tibetana” non abbia più alcun ruolo.
Il Tibet può sempre tornare al centro dell’interferenza statunitense negli affari interni della Cina. Questo sarà certamente il caso quando l’attuale Dalai Lama morirà e quando sarà necessario nominare un nuovo leader spirituale lamaista. Fino a poco tempo fa, gli Stati Uniti hanno preso iniziative su questo argomento che hanno ricevuto un po’ di copertura mediatica. Alla fine del 2019, Sam Brownback nominato “Ambasciatore di buona volontà degli Stati Uniti per la libertà religiosa nel mondo” da Donald Trump, ha dichiarato che “gli Stati Uniti vogliono che l’ONU venga coinvolta rapidamente nella scelta del prossimo Dalai-Lama per impedire alla Cina di influenzare il processo di designazione.”
Alla fine del 2020 il Senato degli Stati Uniti ha adottato una legge che prevede sanzioni contro qualsiasi funzionario cinese che cerca di identificare e installare un Dalai Lama approvato dal Governo cinese. Questo Tibetan Policy and Support Act del 2020 (TPSA) prevede inoltre di vietare alla Cina qualsiasi nuova apertura di un consolato negli Stati Uniti fino a quando gli Stati Uniti non avranno ricevuto l’autorizzazione ad aprire una missione diplomatica a Lhasa, in Tibet.
Quanto è stato importante e quale ruolo ha giocato il Tibet nella strategia egemonica delle forze occidentali nella regione?
Il Tibet è stato oggetto di quello che gli storici chiamano il Grande Gioco nel XIX e all’inizio del XX secolo. L’Impero britannico e la Russia zarista si scontrarono in una lotta per espandere le rispettive sfere di influenza in Asia centrale. Per quanto riguarda il Tibet, regione sotto la sovranità cinese ma il cui controllo è gradualmente sfuggito a una Cina imperiale in pieno declino e attaccata da tutte le parti da potenze straniere imperialiste, sono stati gli inglesi ad avere la meglio. Dalla loro colonia indiana, essi lanciarono un’invasione militare nel 1903/1904 che portò alla presa di Lhasa.
Il 1911 vide la caduta della dinastia Manciù in Cina, seguita da un periodo di disordini interni e guerre civili e, in particolare, l’invasione giapponese. Per circa 40 anni, quindi, il Tibet ha avuto quella che in Occidente veniva chiamata “indipendenza de facto”. Tuttavia, nessun Paese lo ha mai riconosciuto come indipendente, nemmeno i suoi capi britannici. E quando il governo tibetano di Lhasa iniziò a “flirtare” con il Giappone militarista e la Germania nazista (che stabilì contatti amichevoli con i circoli dirigenti di Lhasa attraverso una spedizione delle SS nel 1939), anche i Paesi del patto anti-Comintern che, ad esempio, avevano riconosciuto ufficialmente lo Stato fantoccio di Manchoukuo, non gli concessero questo favore.
L’interesse degli Stati Uniti per il Tibet risale agli anni ‘40. Ma fu solo dopo la vittoria comunista nella guerra civile cinese che gli americani intervennero direttamente, prima sul piano diplomatico (già nel 1950, chiesero al Dalai Lama di lasciare il Tibet e di rifugiarsi in Sri Lanka o negli Stati Uniti), poi dal 1956, quando iniziarono a formare militarmente combattenti tibetani anticomunisti, prima nell’isola di Saipan nelle Isole Marianne, poi a Camp Hale, in Colorado, così come ad inviare paracadutisti, attrezzature militari e rifornimenti ai ribelli. Nel 1959, la CIA svolse un ruolo importante nella fuga del Dalai Lama in India e nell’instaurazione di un “governo in esilio”.
La CIA ha quindi istituito un campo terroristico in Nepal nella regione del Mustang che è esistito fino agli anni ’70, ma ha smesso di sostenere i combattenti anticomunisti tibetani dopo la normalizzazione delle relazioni sino-americane avviata da Nixon. Ciò mostra chiaramente che il sostegno dato al separatismo tibetano dagli Stati Uniti dipende dalla situazione politica internazionale e solo dagli interessi americani.
Washington non si è mai veramente preoccupata del destino dei suoi mercenari stranieri.
Lei ha pubblicato un libro in italiano “Tibet libero? Rapporti sociali e ideologia nel paese del lamaismo reale” in cui, mi passi il termine, ribalta completamente le verità dogmatiche di disinformazione veicolate dai media su questa regione autonoma? D’altra parte, può indicare le interpretazioni al pubblico che vuole districarsi da una storia mediatica – e politica – venata di forti tinte di propaganda anti-cinese?
Il libro che citi è il primo di due libri complementari che originariamente dovevano formare un unico volume. Purtroppo “Tibet libero?” è l’unico dei due ad essere stato tradotto in italiano.
Lì ho esaminato ciò che si sa dell’antico Tibet sulla base delle testimonianze di viaggiatori ed esploratori stranieri, sulla base degli studi di autorevoli studiosi occidentali, come il professore americano Melvyn C. Goldstein, e sulla base di fatti ammessi da personalità dell’esilio tibetano: il Dalai Lama, suo fratello maggiore Thubten Norbu, il suo ex medico personale, ecc.
La mia conclusione è stata, in poche parole, che l’antico Tibet viveva sotto un regime feudale che manteneva la stragrande maggioranza dei tibetani in uno stato di disagio e servitù difficilmente immaginabile, con un’aspettativa di vita di circa 30 anni, un bilancio delle vittime estremo infantile, 95 per cento di analfabetismo… e una piccola classe dirigente che viveva nel lusso osceno e aveva diritto di vita e di morte sui propri sudditi.
Inoltre, per quanto riguarda la disinformazione in Occidente, basta confrontare le edizioni francese o inglese del famoso libro di Heinrich Harrer sui suoi “Sette anni in Tibet” con l’originale tedesco per vedere che interi passaggi ne sono stati cancellati in per nascondere al lettore tutto ciò che non si adatta all’immagine positiva che vorremmo dare del Tibet sotto i Dalai Lama.
Il secondo libro è più “politico”, poiché ripercorre la storia del Tibet nel XX secolo e affronta temi come il sostegno americano ai controrivoluzionari tibetani, gli eventi del 1959 con la fuga del Dalai Lama, il cosiddetto colonialismo cinese e il presunto genocidio dei tibetani.
Ho iniziato parlando del Tibet perché vorrei chiedere se secondo Lei c’è un filo conduttore che lega gli eventi che hanno “animato” il Tibet, Hong Kong e Xinjiang. Quanto sono importanti queste altre due regioni, quanto sono importanti queste altre due regioni, quali forze operano lì e per quale scopo?
Il riavvicinamento che fai tra Tibet e Xinjiang è molto rilevante. Stiamo assistendo a una politica degli Stati Uniti nei confronti della Cina che è sia la continuazione della loro politica anticomunista nel secolo scorso, sia una ripresa delle politiche delle ex potenze coloniali.
Va ricordato che gli Stati Uniti hanno sostenuto e armato in modo schiacciante il Partito Nazionalista Cinese (Kuomintang) durante la guerra civile che ha condotto contro i comunisti; se sono intervenuti militarmente in Corea, è stato anche per contenere la “Cina rossa”. Lo stesso vale per la guerra in Vietnam, Laos e Cambogia.
Hanno finanziato, armato e addestrato i terroristi tibetani della Chushi Gangdrug. Non c’è da stupirsi, quindi, che sostengano i separatisti uiguri del WUC e che abbiano rimosso i jihadisti dell’ETIM/TIP dalla loro lista ufficiale di organizzazioni terroristiche.
Per combattere la Cina gli USA stanno alimentando il separatismo di alcune minoranze etniche e il particolarismo unito alla xenofobia anti-cinese di una parte della popolazione di Hong Kong.
Riassumono così la strategia degli imperialisti giapponesi degli anni ’30 che mirava a smembrare la Cina presentandosi come il difensore dei gruppi etnici che vivevano alla sua periferia: Manchus in “Manchoukouo”, Mongols in Inner Mongolia (“Mengjiang”) e infine i tibetani in Tibet.
Nello Xinjiang, la strategia americana di destabilizzazione può approfittare del fatto che lì esistono da tempo tendenze separatiste, come testimoniano le due effimere repubbliche del “Turkestan orientale”: la “Repubblica islamica turca del Turkestan orientale” del 1933 limitata nelle vicinanze di Kashgar e della seconda “Repubblica del Turkestan orientale” sotto l’influenza sovietica nel nord (fine 1944-1949).
In entrambi i casi, solo una piccola parte del territorio dello Xinjiang era controllata dalle forze separatiste.
La Repubblica Popolare Cinese ha creato la Regione Autonoma Uigura dello Xinjiang proprio per tenere conto delle peculiarità di questa terra abitata principalmente da minoranze etniche. Ricordo che queste minoranze e i loro diritti sono sanciti dalla costituzione cinese, e hanno anche potuto godere (e godono ancora) di importanti privilegi rispetto al gruppo etnico maggioritario, gli Han. Le loro lingue sono state privilegiate nell’istruzione, non sono state soggette alla politica del “figlio unico” imposta alla popolazione Han, hanno beneficiato e beneficiano ancora della “discriminazione positiva” negli esami nazionali, che sono così importanti come parte del sistema meritocratico cinese.
Tuttavia, il rapido sviluppo economico della Cina, iniziato nelle zone costiere, ha tardato a raggiungere le regioni periferiche come il Tibet e lo Xinjiang, in particolare le aree rurali. Il sottosviluppo economico era ovviamente causa di malcontento. A ciò si aggiungono il rifiuto della forte immigrazione Han nello Xinjiang dal 1949 e la sensazione di mancanza di opportunità economiche a causa della scarsa conoscenza del mandarino. Questa è una conseguenza quasi inevitabile della priorità data alla lingua minoritaria nel sistema educativo. Questo è il motivo per cui il Governo cinese ha insistito ultimamente affinchè tutti i cittadini cinesi, compresi quelli delle minoranze, imparino (meglio) la lingua nazionale.
Altri fattori di sottosviluppo tra le popolazioni musulmane dello Xinjiang sono la condizione tradizionale delle donne e delle famiglie numerose. Il Governo cinese ha iniziato ad affrontare questi problemi, promuovendo le attività salariate delle donne e diffondendo il controllo delle nascite e la pianificazione familiare – misure che gli sono valse accuse di “lavoro forzato”, “genocidio culturale” e “genocidio” per “sterilizzazioni forzate”.
I tentativi degli Stati Uniti di destabilizzare lo Xinjiang potrebbero trarre ulteriore vantaggio dall’esistenza delle diaspore uigure e kazaka. Come nel caso del Tibet, i membri di questi gruppi etnici sono fuggiti dalla Cina durante la vittoria della rivoluzione comunista.
È qui che troviamo le radici del WUC: il padre fondatore di questo movimento separatista, Isa Yusuf Alptekin, si rifugiò in Turchia dove stabilì stretti contatti con estremisti di destra seguaci dell’ideologia pan-turca (“lupi grigi”).
Suo figlio, Erkin Alptekin, fondò la WUC con il sostegno di Washington e ne fu il primo presidente. La Turchia è stata anche direttamente coinvolta nel terrorismo uiguro in Cina e all’estero. I terroristi uiguri catturati nel sud-est asiatico avevano in possesso passaporti turchi, ma soprattutto: le migliaia di jihadisti ETIM/TIP che combattono in Siria non avrebbero potuto accalcarsi lì senza la complicità delle autorità turche.
Prima della Siria, un’altra generazione di terroristi uiguri è stata addestrata in Afghanistan da Al Qaeda durante la guerra contro l’esercito sovietico.
Sappiamo chi ha sostenuto e armato i “mujahedin” afghani e chi ha poi usato il jihadismo per distruggere la Libia e cercare di abbattere Assad in Siria. Il terrorismo nello Xinjiang è iniziato con il ritorno a casa dei jihadisti sostenuti dagli Stati Uniti dall’Afghanistan.
Per quanto riguarda Hong Kong, che è un importante centro finanziario, quello che ci è stato presentato come un movimento pacifico per la “democrazia” è stato, almeno nelle sue componenti più radicali, un movimento fascista e violento alimentato e teleguidato da Washington.
I nostri media non hanno insistito né sulla xenofobia della stampa di Hong Kong di un Jimmy Lai che ha prontamente descritto i connazionali del continente come locuste pronte a invadere e devastare la città, né sui danni materiali provocati dai rivoltosi che hanno sistematicamente distrutto le infrastrutture (mettendo fuoco alle stazioni della metropolitana, devastando parlamento e università tecnica, ecc.), né sulle aggressioni fisiche, con armi letali, contro oppositori politici, interni cinesi e polizia, né sulle loro minacce contro i familiari di poliziotti o oppositori.
L’ingerenza di Washington negli affari di Hong Kong (e quindi cinesi) è stata palese: contatti sia clandestini che ufficiali tra diplomatici o politici americani e capi delle rivolte, incoraggiamento dei rivoltosi, bandiere americane e britanniche sventolate da loro, ecc.
Il NED (New Endowment for Democracy) ha iniettato decine di milioni di dollari nella formazione e nel sostegno materiale ai separatisti.
Il terreno di Hong Kong era favorevole a un tentativo di destabilizzazione: il suo peso economico è caduto a favore della vicina città di Shenzhen, e per questo ha dovuto affrontare crescenti difficoltà economiche. I giovani hanno difficoltà a trovare un lavoro o un alloggio dignitosi. A queste difficoltà si aggiunge un sentimento di superiorità nei confronti dei cinesi del continente e un particolarismo che deriva dal fatto che non si condivide realmente né la stessa lingua (il “cinese” è diviso in otto grandi gruppi dialettali e il cantonese parlato a Hong Kong è molto diverso dalla lingua cinese ufficiale, Putonghua o mandarino), né dalla stessa storia recente (dovuta alla colonizzazione britannica).
I giovani di Hong Kong sono stati educati in un sistema scolastico diverso e in uno spirito più “occidentale”. E poi, non dimentichiamo che Hong Kong è stata a lungo una roccaforte anticomunista e un covo di spie. Le sue triadi (crimine organizzato) hanno svolto un ruolo importante nell’esfiltrazione, da parte dei servizi segreti occidentali, dei leader del movimento di protesta da piazza Tienanmen nel 1989.
“La Cina non ha mai cercato di colonizzare il resto del mondo; al contrario, è stata vittima del colonialismo. Vuole riconquistare il posto che le spetta in un mondo multipolare, ma non cerca il dominio e l’egemonia del mondo”
Lei ha seguito da vicino la campagna di propaganda iniziata qualche anno fa, con un primo picco nell’espulsione dalla Cina della “giornalista” francese Ursula Gauthier. I media oggi parlano ancora dello Xinjiang. Cosa sta succedendo con lo Xinjiang? Cosa ha acceso il recente e forte interesse dell’Occidente per questa regione autonoma della Cina? Siamo di fronte a due prospettive diverse, è ovvio. Di cosa parla Pechino quando parla dello Xinjiang? Di cosa parla Washington quando parla dello Xinjiang?
Alla giornalista francese di cui parli non è stato prorogato il visto perché aveva ferito i sentimenti di centinaia di milioni di cinesi negando apertamente l’esistenza del terrorismo uiguro. Ha banalizzato e giustificato la violenza terroristica, definendola resistenza e una normale reazione all’”oppressione cinese”. In effetti, il terrorismo jihadista ha ucciso e ferito più nello Xinjiang e in Cina che in Francia.
Ho già accennato all’importanza dello Xinjiang per il progetto “Nuova Via della Seta”. È un progetto visto da Washington come una seria minaccia all’egemonia americana. Si devono quindi usare tutti i mezzi per contrastarlo.
Pechino ha, soprattutto nell’ultimo decennio, compiuto uno sforzo spettacolare nello sviluppo dello Xinjiang, attraverso massicci investimenti nelle infrastrutture e nello sviluppo economico in generale. La regione è collegata al resto della Cina tramite autostrada e treno ad alta velocità. Nell’ambito del programma nazionale di riduzione della povertà, si è riusciti a migliorare notevolmente la sorte delle popolazioni più povere nelle aree rurali dello Xinjiang meridionale. Far uscire le persone dalla povertà è un obiettivo che non si ottiene tramite doni o sussidi, ma fornendo loro una migliore formazione professionale, una migliore istruzione, posti di lavoro nell’industria o nel settore dei servizi.
In Occidente, la propaganda anti-cinese dipinge questo sviluppo e tutte queste misure in modo caricaturale. Per quasi 40 anni, le nostre grandi multinazionali e classi dirigenti hanno tratto grande profitto dalla manodopera cinese a basso costo, dai lavoratori migranti delle aree rurali che si sono riversati nei centri urbani industrializzati e nelle aree costiere. Sappiamo che le loro condizioni di vita e di lavoro erano tutt’altro che invidiabili. Ora, quando la Cina cerca di dare lavori relativamente ben retribuiti a persone oziose provenienti dalle aree povere dello Xinjiang, c’è un grido di “lavoro forzato”. Gli sforzi per migliorare l’assistenza sanitaria, la promozione della pianificazione familiare, le misure per migliorare la condizione delle donne musulmane sono denunciati come parte di una politica di “genocidio culturale o anche fisico” delle popolazioni musulmane.
Allo stesso tempo, il Governo cinese si è visto costretto a compiere passi sostanziali per combattere il terrorismo e il separatismo e per garantire la sicurezza dei suoi cittadini. Una ragione in più per l’Occidente per gridare alla repressione, alla sorveglianza diffusa e alle violazioni dei diritti umani. Tendiamo a dimenticare che il più grande, generale, sofisticato e costoso sistema di sorveglianza e spionaggio è praticato su scala globale dai servizi segreti americani come la NSA, in collaborazione con società statunitensi come Google.
Nei suoi articoli recenti, Lei parla apertamente di una nuova guerra fredda scatenata dall’amministrazione Trump contro la Cina, che si presta sia alla pandemia che alla “repressione” cinese a Hong Kong e nello Xinjiang. Fino a che punto si spingerà Washington e quali iniziative prenderà Pechino?
Al momento, la “guerra fredda” condotta dagli Stati Uniti e dai suoi satelliti riguarda principalmente la propaganda e l’economia. Facendo pressione sui loro “alleati” europei, gli Stati Uniti sono riusciti ad escludere Huawei dall’installazione di reti 5G in Gran Bretagna, Francia e Germania, ad esempio. Vogliono danneggiare l’economia cinese colpendo le ammiraglie della sua industria high-tech.
Il loro obiettivo proclamato è soprattutto quello di “disaccoppiare” le economie dei Paesi occidentali dalla Cina. Gli stretti legami economici che esistono in un’economia ampiamente globalizzata impediscono o almeno ostacolano misure di guerra economica più drastiche ed efficaci contro la Cina, poiché rischiano di estendersi alle economie occidentali.
Lo stesso vale per un possibile conflitto militare. Ma penso che sarà impossibile “disaccoppiare” le economie e isolare la Cina. Ciò che è stato realizzato con l’Unione Sovietica e il blocco orientale non può essere raggiunto con la Cina, la cui economia è molto più forte e i legami con l’economia mondiale molto più sviluppati. Le sanzioni occidentali avranno l’effetto opposto del previsto: la Cina sarà più indipendente nella sua economia, nel suo sviluppo tecnologico e nella sua ricerca scientifica.
L’Amministrazione Biden, non contenta delle continue politiche aggressive di Trump nei confronti della Cina, ha appena annunciato un programma di armamenti estremamente ambizioso e costoso. Ciò solleva il timore che la “guerra fredda” possa un giorno diventare “calda”.
E una guerra del genere, anche limitata, tra Occidente e Cina rischierebbe di sfociare in una terza guerra mondiale. Questa è una visione dell’orrore che difficilmente possiamo immaginare, ma non dobbiamo dimenticare che all’interno del Pentagono, gli strateghi del genere “Doctor Stranamore” ritratti nel famoso film di Stanley Kubrick non hanno mai fallito.
Nel libro “La logica di potenza. America, la guerra, il controllo del mondo”, John Mearsheimer, parlando delle possibili strategie messe in atto dalle potenze per ottenere l’egemonia regionale, ne indica una, quella del “dissanguamento”: in questa strategia uno Stato non agisce direttamente contro l’avversario ma si sforza di assicurare che la guerra in cui è impegnata sia prolungata e mortale.
Mearsheimer ha il merito di parlare apertamente delle riflessioni strategiche che circolano o si dibattono a Washington. La strategia di cui parli è quella applicata in Afghanistan negli anni ’80 e che ha largamente contribuito al crollo dell’Unione Sovietica. Ma la Cina non è l’Unione Sovietica, ed è improbabile che l’Occidente riesca ad attirarla in un conflitto paragonabile alla guerra sovietica in Afghanistan. Inoltre, questa strategia non ha avuto il successo sperato nemmeno in Russia, con le guerre cecene.
C’è stato un grave problema terroristico nello Xinjiang, ma la regione è stata stabilizzata e pacificata, e il pericolo di una recrudescenza del terrorismo sembra per il momento escluso, nonostante le migliaia di jihadisti uiguri combattenti in Siria che vorrebbero reintrodurre la loro “guerra santa” nello Xinjiang. I servizi di sicurezza cinesi, infatti, sembrano avere i mezzi e gli strumenti per prevenire l’infiltrazione di terroristi.
Inoltre, il miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni musulmane nello Xinjiang rende più difficile il reclutamento dei terroristi. Ecco perché l’attuale propaganda occidentale mira a provocare sanzioni economiche contro l’industria e l’agricoltura nella regione. Un peggioramento delle condizioni di vita delle popolazioni aumenterebbe le “possibilità” di reclutamento dell’ETIM/TIP e del WUC.
La strategia di accerchiamento della Cina è quasi dispiegata sul terreno, manca il fronte nord. La Mongolia Interna, dove ci sono già stati i primi segnali, potrebbe essere il prossimo focolaio di disordini organizzati contro il governo di Pechino?
A mio parere, la Mongolia interna difficilmente può diventare un nuovo focolaio di terroristi. A differenza dello Xinjiang, non ha confini con Paesi come Afghanistan, Tagikistan, Kirghizistan e Kazakistan. C’erano sì tendenze separatiste, ma non abbiamo a che fare con forze internazionali come l’islamismo politico e il movimento panturco e neo-ottomano. Inoltre, l’etnia mongola costituisce solo il 17% della popolazione, mentre l’80% è Han.
Di recente mi sono occupato di Hong Kong e ho scritto una serie di articoli sull’ingerenza straniera negli affari interni della Cina rilevando che è essenziale comprendere le dinamiche che muovono gli eventi per capire che c’è sempre una dinamica burattinaio-burattinaio legata a un flusso di finanziamenti da fuori. Il modello “follow the money” può essere applicato anche allo Xinjiang per capire meglio cosa sta succedendo in questa regione autonoma cinese? Chi lavora davvero sul campo nello Xinjiang, quali organizzazioni?
Ho citato il World Uyghur Congress (WUC) che funziona come un’organizzazione ombrello di varie organizzazioni separatiste uigure all’estero. Ufficialmente, la sua sede è in Germania, ma le sue organizzazioni secondarie più attive sono negli Stati Uniti. Il WUC e le sue organizzazioni affiliate come la Uyghur American Association (UAA) e l’Uyghur Human Rights Project sono finanziate dal Dipartimento di Stato degli USA attraverso il New Endowment for Democracy.
Come ha rivelato il giornalista canadese Ajit Singh, la “UAA ha ricevuto milioni di dollari in finanziamenti” dal NED, l’agenzia statunitense per il cambio di regime che funge da braccio “legale” della CIA. Nelle parole di Nury Turkel, l’ex presidente della UAA, il NED ha “fornito un supporto eccezionale”, “preziosi consigli e assistenza” e “finanziamenti essenziali” a questa organizzazione.
Inoltre, l’UAA “lavora a stretto contatto con il Governo degli Stati Uniti”, in particolare il Dipartimento di Stato, il Comitato esecutivo del Congresso sulla Cina (CCCB) e la Commissione per i diritti umani del Congresso. Secondo la ricerca di Ajit Singh, le organizzazioni uigure negli Stati Uniti sono gestite da “operatori dello Stato di sicurezza nazionale degli Stati Uniti, inclusi dipendenti del governo degli Stati Uniti, di Radio Free Asia e del complesso industriale militare”.
I combattenti ETIM/TIP fanno parte del movimento internazionale islamo-terrorista noto come Al-Qaeda e DAECH (IS). Nel contesto della guerra in Siria, avevano (e hanno tuttora) il sostegno della Turchia, un paese membro della NATO. E sappiamo come Washington abbia saputo usare i jihadisti come mercenari contro i suoi avversari, dalla guerra contro l’esercito sovietico in Afghanistan, la guerra in Bosnia, la guerra in Libia…
Nello Xinjiang il terrorismo eterofinanziato è un mezzo di destabilizzazione abbandonato o potrebbe ripresentarsi in caso di necessità?
Non vedo come sarebbe stato abbandonato. Terroristi stranieri e mercenari al suo soldo sono stati usati dall’imperialismo USA per più di mezzo secolo. Ricorda i mercenari cubani della Baia dei Porci, i combattenti Hmong reclutati dalla CIA in Laos, i Contras del Nicaragua, ecc.
Lei è impegnato nell’analisi delle informazioni al fine di evidenziare la disinformazione che ti viene trasmessa. Le chiedo, tra i giornalisti, c’è più ignoranza, pregiudizio o volontà di manipolare?
Ammetto che faccio fatica a credere all’onestà intellettuale della maggior parte dei nostri giornalisti. La professione promuove o meglio richiede conformismo politico e una forte propensione ad allinearsi con l’ideologia dominante. Detto questo, il pregiudizio e l’ignoranza sono probabilmente prevalenti tra i giornalisti come tra le altre professioni.
Ma permettimi di citare qualcuno più esperto di me per rispondere alla tua domanda. Si tratta proprio di una giornalista che si è ribellata alla “schiavitù mediatica” francese (e che ha visto la sua carriera andare in frantumi a causa della sua testardaggine nel voler mantenere la sua libertà intellettuale e la sua onestà). Racconta: “Una volta un collega di Le Monde mi disse che non una volta, sul giornale dove lavorava da quasi un quarto di secolo, una delle sue carte era stata ideologicamente corretta, non più di quanto non gli fosse stato ordinato di non divulgare tali informazioni o ritirare tale sentenza di colpevolezza. Rimasi sbalordito, perché la mia esperienza, e quella di molti giornalisti a me noti, era esattamente l’opposto. Ne dedusse che nella nostra professione regnava una vera libertà. Piuttosto, ho concluso che il suo cervello era come una giostra dove, dalla notte dei tempi, gira un cavallo cieco, incapace di vedere la minima apertura su ciò che è sconosciuto.» (Aude Lancelin, “Le Monde Libre”).
Siamo di fronte a quella che il portavoce del ministero degli Esteri cinese Zhao Lijian ha detto essere la menzogna del secolo inventata dalle forze anti-cinesi appoggiate dagli Stati Uniti nello Xinjiang?
Forse, ma bisogna ricordare che ci sono già state altre menzogne che potrebbero rivendicare questo titolo, e non è un caso che provengano dalle stesse fonti: le “armi di distruzione di massa” di Saddam”, il suo coinvolgimento negli attacchi dell’11 settembre, la sua complicità con Al-Qaeda, gli stupri organizzati dell’esercito di Gheddafi facilitati dalla distribuzione del viagra alle truppe, e così via. Queste bugie del 21° secolo non hanno nulla da invidiare a quelle del 20°. Basti pensare alle bugie degli incubatori in Kuwait, al presunto “massacro di Timisoara”, al presunto “piano a ferro di cavallo” serbo in Kosovo, e così via.
Il livello delle accuse contro Pechino è aumentato: da accuse di violazione dei diritti umani del popolo uiguro ad accuse di vero e proprio genocidio.
Cosa cercano gli Stati Uniti – perché, diciamocelo, l’Occidente sta giocando un gioco che solo Washington ha interesse a giocare – con questa strategia?
Gli Stati Uniti vogliono fermare l’ascesa della Cina per mantenere la loro egemonia globale, che è stata completa dopo la caduta dell’Unione Sovietica. Per molto tempo questa egemonia non è stata contestata da nessuna potenza rivale.
Sotto Biden, chiedono (o spingono) ai loro “alleati” di formare sotto la loro guida un fronte comune contro la Cina percepita come la più grande minaccia alla sostenibilità del loro dominio globale. Gli europei sono quindi invitati a difendere l’egemonia americana e l’”ordine” internazionale definito dal loro capo oltreoceano. È nel loro interesse?
A tal proposito, nell’ultimo libro di Maxime Vivas c’è una frase che ad una prima lettura può risultare anonima ma che è un riassunto di quanto sta accadendo attualmente riguardo allo Xinjiang: “questa battaglia degli americani non è nostra”.
I paesi europei hanno davvero abbandonato ogni prospettiva di autonomia e di difesa dei loro diritti per inginocchiarsi al volere del padre-padrone americano? Fino a che punto l’Occidente è disposto a seguire un declino che sembra inarrestabile e soprattutto quando se ne rende conto?
Dopotutto, il mondo raccontato dagli occidentali non esiste più.
Purtroppo gli Stati Uniti hanno una tale influenza in Europa che spesso riescono a farla agire contro i propri interessi. Un esempio è l’accordo nucleare con l’Iran. Quando l’amministrazione Trump lo ha unilateralmente distrutto, i principali Paesi europei avrebbero voluto salvarlo e salvaguardare i loro legami economici con l’Iran. Non ci sono riusciti. Quando più di recente Germania e Francia hanno proposto un incontro al vertice con il Presidente russo Putin, alcuni Paesi sono riusciti a far rifiutare la proposta. Attualmente, le forze più “atlantiste” stanno cercando di sabotare il Comprehensive Investment Agreement (AGI) tra Unione Europea e Cina. Il Parlamento europeo ha bloccato la sua ratifica.
Ci sono molti altri esempi che potrebbero essere citati, come l’affare dell’oleodotto Nordstream 2 e le pressioni di Washington affinché i Paesi europei aumentino i loro budget militari già sovradimensionati.
Come nota Frédéric Pierucci, l’ex boss di una delle filiali di Alstom preso in ostaggio nell’aprile 2013 dagli USA per costringere questo colosso dell’industria francese a pagare una multa gigantesca e vendersi alla concorrenza, i Paesi europei hanno accettato di sottomettersi alla ‘pax americana‘ (…) Da quasi vent’anni l’Europa si lascia tenere in ostaggio. Le più grandi aziende in Germania, Francia, Italia, Svezia, Olanda, Belgio, Inghilterra sono state condannate una dopo l’altra per corruzione o per reati bancari, o per mancato rispetto di un embargo. E decine di miliardi di multe sono finite così nelle mani del Tesoro Usa. Nell’epilogo del suo libro “La trappola americana”, cita l’ex presidente francese François Mitterrand che, al tramonto del suo mandato, (…) aveva ragione con questa frase premonitrice: “La Francia non lo sa, ma siamo in guerra con l’America. Sì, una guerra permanente, una guerra vitale, una guerra economica, una guerra apparentemente senza morte e tuttavia una guerra all’ultimo sangue”.
Non ci resta che sostituire “la Francia” con “Europa” o, meglio ancora, “il resto del mondo” per avere una visione più globale e più giusta di questa “guerra”.
C’è un fatto bizzarro in tutta la recente vicenda dello Xinjiang: gli Stati Uniti inseguono la Cina ma analizzando i dati dell’export, vediamo che i due Paesi continuano a fare affari tra loro, l’altro a scapito dell’Europa che, al contrario, con le sanzioni volute da Washington – che ovviamente sta attento a non applicare – sta perdendo terreno e soprattutto benefici economici. Come possiamo spiegarlo?
Ciò conferma che l’impero americano agisce nell’interesse dell’impero americano. I produttori tedeschi, francesi, giapponesi e italiani sono i suoi concorrenti. Basti ricordare lo spionaggio industriale statunitense e la pressione statunitense contro compagnie come Airbus, il principale concorrente di Boeing.
De Gaulle ha detto: “La Cina è una cosa enorme. Lei è lì. Vivere come se non esistesse è essere ciechi, soprattutto perché esiste sempre di più”. Il proclama è ancora valido?
Il peso non solo della Cina, ma di quelli che vengono chiamati “Paesi emergenti” è aumentato vertiginosamente.
Il mondo sta cambiando radicalmente. La Cina sta svolgendo un ruolo sempre più importante nelle relazioni internazionali. Non parlo solo del suo peso economico.
Quello che viene chiamato l’Occidente – Europa e Nord America – non è più il baricentro del pianeta. La politica estera europea dovrebbe tenerne conto invece di ripiegare su una visione del mondo che risale alla Guerra Fredda contro l’URSS.
La Cina non è una minaccia per l’Europa, non aspira all’egemonia globale e non cerca di imporre il suo sistema al resto del mondo come fanno gli altri. È certamente un competitor, ma allo stesso tempo un partner economico di primaria importanza.
Cosa non può capire o non riesce a capire l’Occidente della Cina?
Forse la Cina è solo diversa. Ha un’altra storia, un’altra civiltà, altre tradizioni, un’altra filosofia. La Cina non sono gli Stati Uniti, non la Germania, non la Gran Bretagna, non la Francia o l’Italia.
Forse la Cina è solo diversa. Ha un’altra storia, un’altra civiltà, altre tradizioni, un’altra filosofia. La Cina non sono gli Stati Uniti, non la Germania, non la Gran Bretagna, non la Francia o l’Italia.
Ho l’impressione che in Occidente generalmente pensiamo che la Cina sia come noi, solo peggio. Le potenze europee colonizzarono il resto del mondo, combatterono guerre infinite per la conquista di nuovi territori, inventarono l’ideologia della superiorità della civiltà “cristiana” occidentale, poi il “razzismo scientifico” per giustificare la schiavitù e lo sfruttamento coloniale.
La Cina non ha mai cercato di colonizzare il resto del mondo; al contrario, è stata vittima del colonialismo. Vuole riconquistare il posto che le spetta in un mondo multipolare, ma non cerca il dominio e l’egemonia del mondo.
Le potenze occidentali incolpano prontamente la Cina per quelle che sono state le loro colpe per secoli. Furono loro a praticare il colonialismo, la schiavitù e il lavoro forzato, il genocidio, la conversione e l’assimilazione forzate, la distruzione di civiltà e culture straniere. Ho l’impressione che, guardando alla Cina, molti occidentali vedano solo il proprio autoritratto.
Come sta l’Occidente? C’è ancora spazio per il pensiero unipolare americano o stiamo vivendo negli ultimi giorni dell’impero?
L’Occidente sta andando piuttosto male. Lo testimoniano la crisi economica e finanziaria e la crisi sanitaria del Covid 19 che non è in grado di controllare.
A livello globale, il suo peso economico e la sua influenza politica e ideologica stanno rapidamente diminuendo. L’elezione di Trump alla presidenza ha messo in luce lo stato pietoso in cui si trovano la “democrazia” e le istituzioni americane, e ha aperto gli occhi a molti sull’enorme divario che esiste tra la realtà e il “sogno americano”. I “Democratici” con Biden hanno presentato programmi ambiziosi, ma la loro realizzazione rischia di scontrarsi con le carenze del sistema economico e politico americano. Vedremo cosa riusciranno a realizzare.
Quanto a un’Europa disunita, vittima di un allargamento prematuro e avventato, conosce crisi politica dopo crisi e non è in grado di risolvere i mali che l’hanno colpita per lungo tempo, ad esempio il divario che si è allargato tra le economie del nord e dell’Europa meridionale, o una disoccupazione giovanile particolarmente grave nei Paesi mediterranei. La gestione catastrofica della crisi del Covid 19 da parte della maggior parte dei governi non ha aiutato le cose.
Il declino dell’Occidente è difficile da contestare, ma è relativo e avviene nel tempo. Salvo imprevisti che possono precipitare il corso della Storia (come è stata anche l’attuale crisi sanitaria con le sue ricadute economiche e politiche), si tratta di un’evoluzione che durerà ancora qualche decina di anni. Le classi dirigenti degli Stati Uniti e dei loro alleati europei credono ancora di poter cambiare le sorti della storia. Da qui il pericolo di un’intensificazione della guerra fredda che è già in corso e che potrebbe sfociare in conflitti armati.
Quali sviluppi si aspetta nel prossimo futuro – nei rapporti tra Cina e Stati Uniti – e quali, invece, si augura?
Non ho la sfera di cristallo e non credo di poter prevedere il futuro, nemmeno il prossimo futuro. Ma senza dubbio ci si può aspettare un’intensificazione dei conflitti e delle rivalità. Spero che l’Europa non leghi il suo destino indefinitamente a quello dell’Impero americano e che accetti e trovi il suo posto nel nuovo ordine mondiale multipolare che si sta affermando.
ALBERT ETTINGER è nato nel 1952 a Differdonge, nell’alveo dello produzione siderurgica lussemburghese. Ha studiato storia, germanistica e filologia romanza e dopo il primo esame di Stato ha lavorato come assistente di ricerca presso l’Università di Treviri, dove si è laurealo a pieni voti con una tesi su Thomas Mann. In seguito ha insegnato presso licei e scuole superiori in Lussemburgo. Si occupa da molti anni del tema del Tibet.

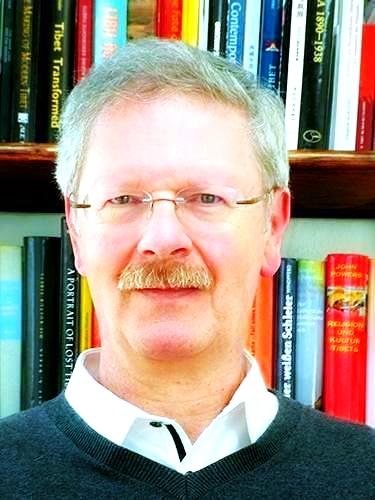
















Il CeSE-M sui social