Di Stefano Vernole
Lo “storico” incontro tenutosi tra Donald Trump e Vladimir Putin in Alaska a Ferragosto lascia in sospeso molti degli interrogativi che ci hanno accompagnato durante questi anni in cui la Russia, a partire dal 24 febbraio 2022, è stata considerata dall’asse euroatlantico un paria internazionale e il suo presidente un criminale da arrestare e trascinare all’Aja per un processo esemplare.
*L’articolo è la versione integrale di quello pubblicato su “Il Faro di Roma” il 25 agosto 2025: https://www.farodiroma.it/alaska-e-dintorni-vincitori-e-vinti-stefano-vernole/
Già questa premessa, però, consente di stabilire un primo bilancio. Non solo il capo del Cremlino è stato accolto con tutti gli onori e applaudito dall’attuale boss dell’Occidente collettivo ma è riuscito pure ad eludere quello che era il principale punto all’ordine del giorno e cioè un cessate il fuoco in Ucraina, invocato a gran voce dalla NATO e da Kiev per frenare il lento ma inesorabile cammino dell’esercito russo verso la liberazione dei territori contesi.
In attesa di capire che cosa verrà deciso nelle prossime settimane – un possibile accordo complessivo oppure un inasprimento del conflitto – possiamo dare per acquisiti alcuni punti1.
Anche per la Casa Bianca, infatti, la vittoria è stata solo tattica. Raggiunto l’obiettivo minimo di staccare l’Unione Europea dalla Federazione Russa, ufficializzando a tutti gli effetti il vassallaggio di Bruxelles nei confronti di Washington (ricordiamo tuttavia che già dal 2014 i rapporti euro-russi erano fortemente compromessi), il conflitto innescato dagli USA in Ucraina ha però favorito lo scivolamento ancora più profondo di Mosca verso Pechino: un asse eurasiatico difficilmente incrinabile, almeno finchè Putin e Xi Jinping rimarranno al potere, e che addirittura rischia di estendersi all’India, realizzando quel triangolo strategico auspicato fin dagli anni Novanta da Evgenij Primakov e incubo di tutti i pensatori geopolitici angloamericani.
In attesa di capire questa evoluzione, abbiamo sicuramente due parti sconfitte: l’Ucraina e l’Europa.
La prima si appresta a perdere ufficialmente tra il 20 e il 25% del proprio territorio, oltre all’incredibile numero di morti e dispersi – 1,7 milioni di soldati secondo i dati trafugati e pubblicati da alcuni hacker russi – con una crisi demografica devastante e un debito estero inestinguibile, specialmente dopo aver ceduto alla Russia i giacimenti di materie prime più importanti2. Se poi la Russia dovesse continuare la propria offensiva portando le proprie truppe sulla linea del Dnepr, diverrà inevitabile che la Polonia avanzi nei territori occidentali e che le minoranze ungheresi e romene finiscano per gravitare verso la Madrepatria: l’Ucraina diverrebbe a tutti gli effetti uno “Stato fallito”.
L’Unione Europea ha completamente abbandonato ogni velleità di autonomia strategica, trovandosi ora totalmente dipendente dagli Stati Uniti non solo dal punto di vista militare ma anche economico, al punto che durante il vertice dei “volenterosi” a Washington Ursula Von der Leyen è arrivata a chiedere garanzie non solo per Kiev ma anche per Bruxelles.
Non molto meglio se la passa la NATO, comandata dai Generali americani ma gestita attualmente dagli inglesi (cioè da due potenze extraeuropee), perché la vittoria russa in Ucraina (seppur tattica) ne ha compromesso la credibilità e messo a nudo i limiti di deterrenza.
Ucraina ed Europa: un binomio sostenibile?
Il 4 luglio 2025 ha preso forma un nuovo accordo di libero scambio UE-Ucraina, che regolerà i flussi commerciali tra le due economie.
La versione originaria del patto – nome tecnico Deep and comprehensive free trade agreement (Dcfta) – fu stipulata nel 2014 come uno dei pilastri dell’accordo di associazione UE-Ucraina ed entrò in vigore nel 2016. Dal febbraio 2022, era stata sostituita da un quadro provvisorio noto con l’acronimo Atm, che sta per Autonomous trade measures. Le Atm hanno sostanzialmente sospeso i dazi e le barriere tariffarie pre-esistenti sulle esportazioni agricole ucraine verso l’Unione Europea, aprendo a Kiev le porte del mercato unico per cereali, mais, uova, pollame, zucchero, prodotti caseari e quant’altro. La revisione del testo, che secondo i tecnici europei introduce una prospettiva di lungo termine, segna due novità. Da un lato, l’Ucraina si impegna ad allineare gradualmente i propri standard di produzioni agricola a quelli dell’UE in una serie di ambiti (inclusi il benessere animale e l’uso di pesticidi) entro il 2028, sottoponendosi a revisioni annuali. Un meccanismo che, peraltro, rinforza il percorso di Kiev verso l’adesione al club a dodici stelle, garantendo che il Paese candidato segua le stesse regole degli Stati membri. D’altra parte, accanto a questa condizionalità l’accordo prevede dei meccanismi di salvaguardia a tutela dei mercati europei, da attivare nel caso in cui dovessero manifestarsi delle gravi perturbazioni a livello comunitario o nazionale. Sarà la Commissione a proporre formalmente l’attivazione di tali salvaguardie su richiesta delle cancellerie3.
Tutto bene, quindi? Non proprio.Come spiegavano le associazioni di categoria prima che Bruxelles intraprendesse questo accordo: “L’eventuale inclusione dell’Ucraina in UE pone un grande interrogativo rispetto al futuro della Politica Agricola Comune. L’Unione Europea si è finora impegnata nel sostegno a questo Paese, nel conflitto in corso con la Russia dal febbraio 2022. E ha prospettato il suo possibile ingresso nell’Unione stessa, senza tuttavia considerare né le implicazioni che il conflitto ha avuto sull’economia e la società del Paese, né l’impatto sulla Politica Agricola Comune (PAC). Molti economisti agricoli affermano che esistano ragioni sufficienti per eliminare virtualmente i pagamenti per ettaro e applicare i sussidi agli agricoltori sulla sola base delle condizioni ecologiche e sociali, per adattare le pratiche agricole ai cambiamenti climatici e agli sviluppi del mercato. Le priorità geopolitiche potrebbero così esacerbare le pressioni per rivedere la PAC in una direzione il cui possibile impatto merita approfondimenti dei quali tuttora non si ha notizia.4”
Sono almeno sette le criticità rilevate dagli esperti del settore:
il tessuto produttivo agricolo ucraino rimane molto variegato; negli ultimi 4 anni, si sono registrati arruolamenti coatti e conseguenti emigrazioni, oltre a centinaia di migliaia di uomini in età lavorativa caduti o resi invalidi al lavoro;
le Corporation agroindustriali ucraine – Kernel o MHP, UCAB – siedono assieme alle filiali nazionali dei colossi dell’agrochimica (come Bayer-Monsanto, BASF) e altri grandi gruppi, tra i quali le industrie USA dei trattori (New Holland, John Deere) presso l’Ukrainian Agribusiness Club (UCAB), un’organizzazione con uffici a Kiev e a Bruxelles. Le società madri dei conglomerati ucraini, tra l’altro, hanno spesso sede in paradisi fiscali. Così ad esempio, il gigante dei cereali Kernel (che gestiva 507.611 ettari di terreni agricoli in Ucraina nel 2020) è registrato in Lussemburgo; Ukrlandfarming (531.306 ettari), la società di investimento americana NCH Capital (350.400 ettari) e il magnate del pollo MHP (349.321 ettari) sono tutti domiciliati a Cipro;
l’ingresso dell’Ucraina in UE comporterebbe il trasferimento di centinaia di milioni di euro di contributi della Politica Agricola Comune dagli attuali beneficiari a favore dei suoi colossi agroindustriali. Una recente inchiesta pubblicata su The Guardian, del resto, ha rivelato che tra i primi beneficiari finali dei sussidi per ettaro figuravano l’ex Primo Ministro ceco Andrej Babiš, il colosso tedesco della carne Tönnies e, prima della Brexit, il magnate britannico Sir James Dyson. Già gli attuali oligarchi dell’Occidente drenano dunque le risorse della Politica Agricola Comune distribuite sulla base della superficie, a spese delle piccole aziende agricole che ne hanno bisogno per sopravvivere;
in caso di adesione dell’Ucraina all’UE, essendo di gran lunga il Paese più povero, molti degli attuali Stati membri dovrebbero versare più denaro nel bilancio comunitario e riceverne meno a loro volta, senza dimenticare il necessario cambiamento della PAC;
ogni cambiamento della PAC richiede negoziati complessi ed estenuanti. I negoziati agricoli sono tra i più difficili, in qualsiasi processo di adesione, poiché incidono in misura significativa sul bilancio europeo e comportano la redistribuzione di risorse ingenti tra vecchi e nuovi Stati membri;
seguendo il modello per l’attuazione della PAC, i finanziamenti verrebbero quindi assegnati sulla base dei piani nazionali elaborati dagli Stati membri in base alle proprie esigenze e priorità economiche e politiche. Con un impatto negativo sul potere regionale e la coesione che gli approcci e i programmi da LIFE a LEADER, tra le molte altre iniziative, apportano allo spazio rurale;
in sintesi, gli agricoltori degli attuali 27 Stati membri UE temono di venire completamente cancellati dalla concorrenza dei giga-conglomerati ucraini che dominano il mercato. Nella stessa Ucraina, i piccoli agricoltori hanno lanciato l’allarme sulla crescente influenza delle oligarchie agroindustriali e sul loro accesso prioritario ai finanziamenti; in secondo luogo, la politica dei dazi USA potrebbe anche avere un impatto importante sulla direzione che prenderanno la riforma della PAC e i relativi accordi commerciali tra l’UE, i suoi singoli Stati membri e gli Stati Uniti.
Non a caso, subito dopo l’accordo di libero scambio, le principali organizzazioni agricole italiane si sono mosse per denunciare i pericoli di un ingresso dell’Ucraina nella UE; le loro dichiarazioni dimostrano che le preoccupazioni sono ampie e condivise da vari Paesi, non solo da Polonia, Ungheria Repubblica Ceca, che da mesi denunciano come il grano ucraino a prezzi troppo bassi stia avendo gravi ripercussioni sui loro mercati interni. I danni per i produttori europei sarebbero aggravati da un calendario a tappe forzate, fissato per accelerare l’ingresso dell’Ucraina nel blocco degli Stati membri senza le necessarie precauzioni5. I mercati agricoli negli scorsi anni sono stati “scossi” dalla guerra, prima per l’assenza improvvisa delle forniture di grano e oli vegetali dall’Ucraina, poi dall’ingresso via terra di questi prodotti grazie ai corridoi di solidarietà, che hanno però causato danni ai produttori europei. Le aziende italiane in oltre tre anni di guerra hanno visto aumentare del 21% i loro costi complessivi per far fronte ai propri consumi intermedi, secondo un’analisi del Centro Studi Divulga. I consumi energetici e dei concimi rappresentano oggi in media un quarto dei consumi intermedi di un’azienda agricola italiana, mentre prima della guerra il loro peso era di un quinto; mentre il costo per l’energia è cresciuto del 66%, ad incrinare ulteriormente la capacità di generare redditi di molte imprese agricole e ad aggravare la propria sostenibilità economica, è arrivato l’aumento dei costi per mangimi e spese per il bestiame (+11% in termini monetari) e per i fitosanitari (circa l’8% in più rispetto al 2021) che rappresentano una voce di spesa importante per il settore agricolo italiano.
Con le attuali novità, per i prodotti considerati sensibili – come uova, carne di pollame, zucchero, grano, miele e mais – ci sarà un leggero aumento dei contingenti tariffari. La Commissione Europea non ha ancora svelato l’entità esatta di questo incremento, ma si vocifera che non supererà il 25% dei contingenti del 2026. Sarà interessante vedere i dati definitivi, attesi a breve. Per i prodotti meno sensibili, come avena, semole, burro e glutine, i contingenti tariffari raggiungeranno i livelli massimi di importazione visti negli anni passati, anche se rimangono su volumi piuttosto contenuti (ad esempio, 7.000 tonnellate di avena nel 2023 o 6.000 tonnellate di burro nel 2022). Prodotti come i funghi o il latte in polvere saranno completamente liberalizzati. Sul fronte opposto, l’UE vedrà un accesso rafforzato al mercato ucraino per prodotti come formaggio, carne suina, carne di pollame e zucchero. L’accordo prevede anche una clausola di revisione futura, per tenere conto dell’integrazione economica dell’Ucraina e dei progressi nel raggiungimento degli standard europei.
Dietro la notizia di questo accordo si muove un’ombra di preoccupazione dovuta alla mancanza di trasparenza sui dettagli specifici, un’incertezza che sta creando non poca agitazione, con molti Paesi che attendono maggiori chiarimenti. Il primo a muoversi è stato Viktor Orban che a fine luglio al Consiglio Europeo ha presentato agli altri 26 leader dell’UE i risultati di una sorta di referendum tenutosi in Ungheria il 20 giugno 2025, in cui si chiedeva ai cittadini se fossero favorevoli all’avvio dei negoziati di adesione con l’Ucraina. Su 2.278.000 voti validi, il 95% si è detto contrario e il 5% favorevole; la consultazione non è giuridicamente vincolante ma sarà utilizzata come un vero e proprio messaggio politico: “Per avviare i negoziati è necessaria una decisione all’unanimità, e questa unanimità non c’è”, ha affermato Orbán, sottolineandone le conseguenze per l’UE.
Un coro unanime di allarme è arrivato da una coalizione di otto importanti associazioni agricole a livello europeo, tra cui il Copa-Cogeca, che hanno ribadito con forza la necessità di certezza, prevedibilità e condizioni di parità per i settori agricoli dell’UE. Il loro appello è chiaro: pubblicare immediatamente tutti i dettagli, preoccupati soprattutto per la protezione dei settori più sensibili come pollame, zucchero, cereali e miele.
Anche l’UCAB (la principale associazione agroalimentare ucraina) ha espresso le sue riserve, arrivando a definire l’accordo un “passo indietro”. La preoccupazione comune è che questo patto rischi di non contribuire alla resilienza economica dell’Ucraina, messa a dura prova dalla guerra. Si sono evidenziate le possibili perdite nette per i produttori agricoli ucraini e si è manifestata sorpresa per la richiesta di un rapido allineamento agli standard UE senza un pieno accesso al mercato interno, che gli agricoltori ritengono logico in un contesto di preadesione. L’UCAB ha anche espresso preoccupazione per l’ampiezza delle clausole di salvaguardia, auspicando che siano basate su valutazioni d’impatto rigorose e non su decisioni arbitrarie.
La ricostruzione dell’Ucraina subisce un evidente ridimensionamento
Il 10 e 11 luglio 2025 l’Italia ha ospitato a Roma la “Ukraine Recovery Conference”, che ha dato continuità al lavoro avviato nei precedenti appuntamenti di Lugano (2022), Londra (2023) e Berlino (2024), confermando le Quattro Dimensioni di Berlino come pilastri fondamentali per il processo di ripresa, modernizzazione e riforme dell’Ucraina: la Dimensione imprenditoriale, la Dimensione umana, la Dimensione locale e regionale e la Dimensione UE.
Secondo gli organizzatori, all’interno della sede della conferenza si è inserito il Recovery Forum, una piattaforma interattiva che favorisce il dialogo, il networking e la condivisione di esperienze tra rappresentanti ucraini, italiani e internazionali, autorità locali, istituzioni finanziarie e banche per lo sviluppo. Parte integrante dell’evento è stata una Fiera imprenditoriale, per permettere a imprese ucraine, italiane e internazionali, piccole e medie imprese, grandi aziende e rappresentanti di enti locali di costruire collaborazioni nel quadro della ricostruzione dell’Ucraina. Durante i giorni della conferenza erano previsti numerosi eventi paralleli su argomenti specifici come l’efficienza energetica, la formazione, la ricostruzione verde, le politiche per il capitale umano, la difesa e lo sviluppo industriale6.
A dir la verità, l’evento non era iniziato sotto i migliori auspici, dato che BlackRock, il colosso mondiale della finanza, ha deciso di sospendere ogni attività relativa al fondo di ricostruzione dell’Ucraina. Il fondo, che avrebbe dovuto raccogliere oltre 15 miliardi di dollari tra istituzioni pubbliche e private, era stato presentato come il motore finanziario della rinascita ucraina. L’Italia, insieme a Germania e Polonia, era pronta a sostenere la prima tranche di finanziamenti, mentre già a gennaio 2025 BlackRock aveva interrotto le trattative con gli investitori istituzionali, citando una “mancanza di interesse” e, soprattutto, l’assenza di un sostegno concreto da parte degli Stati Uniti. Il progetto, che doveva essere svelato in pompa magna alla Ukraine Recovery Conference di Roma, si è dissolto prima ancora di vedere la luce7.
Nemmeno questi intoppi hanno frenato la volontà europea di continuare ad investire nel “buco nero” ucraino; secondo i resoconti dei media, a Roma sarebbero stati firmati 200 accordi, più di 10 miliardi di euro mobilitati, 6.000 delegati da 70 Paesi e 45 organizzazioni internazionali. La Commissione Europea ha ufficializzato il lancio del Fondo europeo per la ricostruzione dell’Ucraina, il più ambizioso fondo di equity pubblico-privato mai concepito in Europa, al quale hanno già aderito Italia, Francia, Germania, Polonia e la Banca europea per gli investimenti. L’obiettivo è mobilitare capitali nei settori dell’energia, dei trasporti, della sanità, del digitale, delle materie prime critiche e dell’industria a duplice uso. A questo si affianca un pacchetto da 2,3 miliardi di euro annunciato nell’ambito dell’Ukraine Investment Framework. Il presidente Volodymyr Zelensky ha chiesto un rafforzamento della produzione di droni e batterie antimissili, invocando una coalizione industriale a sostegno dell’autonomia difensiva del Paese. Berlino ha risposto immediatamente: acquisterà sistemi Patriot dagli Stati Uniti per fornirli a Kiev. L’Italia ha confermato nuovi progetti di cooperazione tra le industrie della difesa. È stata poi lanciata BraveTech Eu, piattaforma congiunta tra Bruxelles e Kiev che integra il know-how ucraino, sviluppato sul campo in tre anni e mezzo di guerra, nei programmi europei di innovazione militare. L’iniziativa, finanziata con 100 milioni di euro (50 dell’UE, 50 ucraini), prevede hackathon, acceleratori, test su tecnologie difensive e accesso delle aziende ucraine ai fondi europei per la difesa, mentre il coordinamento viene affidato all’Eu Defence Innovation Office con sede a Kiev. Il Ministero dei Veterani dell’Ucraina ha proposto la creazione di una coalizione internazionale per sostenere le politiche di reinserimento degli ex combattenti, con un fabbisogno stimato tra i 50 e i 60 milioni di dollari: con Canada, Francia e Regno Unito sono già stati avviati programmi di formazione, assistenza psicologica, digitalizzazione dei servizi e scambio di esperienze tra veterani.
Ciò che sorprende è l’ingenuità di queste iniziative.
Il Governo ucraino ha posto con forza la questione dei “territori occupati”: “La ricostruzione deve includere anche la linea del fronte”, ha dichiarato il vicepremier Oleksii Kuleba. Si parla di scuole sotterranee, ospedali mobili, case temporanee, infrastrutture minime per chi vive ancora sotto i bombardamenti. A Mariupol – controllata e ricostruita dai russi – è in corso un piano per l’assegnazione di abitazioni a prezzo calmierato a Bila Tserkva; a Bakhmut – conquistata da anni dalla Wagner e dai paracadutisti russi – si progetta la “clonazione” urbanistica di interi quartieri in zone più sicure del Paese”. Due progetti di edilizia sociale nella Transcarpazia (rivendicata dall’Ungheria), realizzati con la Croce Rossa, hanno attirato l’interesse di aziende tedesche, americane e turche.
L’Italia, che nel piano iniziale avrebbe dovuto occuparsi della ricostruzione della zona di Donetsk, ora si ritrova a promettere quella di Odessa … nella speranza che il conflitto si fermi sull’attuale linea del fronte e non costringa Roma ad un nuovo dietro-front.Secondo la Banca mondiale, un piano decennale di ricostruzione e ripresa dell’Ucraina, da realizzare tra il 2025 e 2035, richiederà investimenti per almeno 524 miliardi di dollari e la maggior parte dell’onere dovrebbe essere sostenuto dall’Europa, soprattutto se – come sembra – l’impegno degli Stati Uniti rimane in bilico. L’UE è attualmente il principale donatore dell’Ucraina e si è impegnata a fornire un sostegno finanziario regolare e prevedibile, ma tale vincolo richiede una mobilitazione di fondi ben oltre la capacità dei Governi europei8.
Dimenticando peraltro che grazie all’accordo intergovernativo sull’istituzione del Fondo di investimento per la ricostruzione tra Stati Uniti e Ucraina, firmato il 30 aprile 2025 a Washington, Trump cercherà di vietare la concessione di diritti di prelievo a soggetti con sede in giurisdizioni che gli USA considerano ostili ai propri interessi geopolitici9.
Inoltre, a partire dal 28 agosto 2025, l’Ucraina abolirà cinque tipologie obsolete di entità giuridiche nell’ambito dei suoi sforzi per modernizzare e allinearsi agli standard aziendali internazionali. Saranno vietate le nuove registrazioni di società nelle forme giuridiche abolite e le società esistenti saranno soggette alla legge sulle LLC (Limited Liability Company) dopo un periodo di transizione di tre anni che terminerà il 28 agosto 2028. Tuttavia, le aziende che mantengono strutture obsolete potrebbero trovarsi ad affrontare crescenti sfide legali e operative, anche nei rapporti con banche e controparti, nonché complicazioni nella governance aziendale.
Il suicidio europeo di fronte al bullismo a stelle e strisce
Innanzitutto bisogna rilevare il fallimento della strategia energetica europea: nonostante il mancato rinnovo dell’accordo di transito per l’Ucraina con la rete Uregony-Pomary-Uzhorod, avvenuto il primo gennaio 2025, nel febbraio di quest’anno l’Unione Europea ha ricevuto 56 milioni di metri cubi al giorno di gas russo attraverso il gasdotto TurkStream, con un aumento mensile dell’11%. In totale, le importazioni di combustibili fossili russi da parte dei 27 hanno raggiunto 21,9 miliardi di euro nel 2024, superando i 18,7 miliardi di euro di aiuti finanziari forniti all’Ucraina. Nel 2025, il prezzo di riferimento del gas in Europa, il TTF (Title Transfer Facility), è circa il doppio rispetto ai livelli pre-crisi. Solo nel 2024 è aumentato del 59%, passando da 30 a 48 euro megawattora. Questo ha a sua volta spinto i prezzi dell’energia elettrica in Europa, con l’industria del vecchio Continente che – come messo nero su bianco nel rapporto Draghi – paga il doppio rispetto a Stati Uniti e Cina10.
La situazione non è cambiata nemmeno nell’anno in corso; nel primo semestre del 2025 l’UE ha importato gas naturale liquefatto (GNL) dalla Russia per un valore di circa 4,48 miliardi di euro, 1 miliardo in più rispetto all’anno prima. Non solo. Secondo quanto riportato dal sito d’informazione azero Caliber, anche l’Ucraina acquista “sicuramente” gas russo che viene fornito all’Europa tramite il gasdotto TurkStream, come ha affermato il primo Vicepresidente della commissione per l’energia del Parlamento ucraino, Oleksiy Kucherenko: “L’Ucraina ha bisogno di assicurarsi circa 4,5-6 miliardi di metri cubi (bcm) di gas sul mercato europeo per superare la prossima stagione di riscaldamento, con una parte di queste forniture inevitabilmente proveniente dalla Russia”. Come opportunamente rilevato: “Pertanto, nonostante le dichiarazioni di un completo rifiuto del carburante russo, l’Ucraina continua a dipendere da esso, acquistandolo tramite intermediari a prezzi gonfiati. Costi che, considerando la stretta dipendenza dell’economia dell’Ucraina (di fatto uno Stato fallito), dagli aiuti finanziari dell’Occidente, ricadono indirettamente sui Paesi donatori11”. Cioè sugli europei.
La vicenda viene confermata dal giornale online ucraino Strana, che riferisce come nel mese di luglio di quest’anno l’Ucraina abbia aumentato del 13% le importazioni di gas dall’Ungheria (raggiungendo i 300 milioni di metri cubi) e del 140% dalla Slovacchia (268 milioni di metri cubi). Le due nazioni europee importano a loro volta il gas russo attraverso il gasdotto TurkStream ma sono state entrambe pesantemente criticate dall’Unione Europea per non aver rinunciato all’energia russa … Secondo i dati citati da Strana, i 568 milioni di metri cubi di gas russo acquistati dall’Ucraina in Slovacchia e Ungheria corrispondono a quasi il 70% delle importazioni totali di gas dell’Ucraina. Strana aggiunge che “l’Ucraina ha acquistato gas per l’inverno a credito, utilizzando prestiti miliardari”. Prestiti che difficilmente Kiev, con la sua economia in bancarotta, potrai mai restituire agli europei12.
Europei che, nonostante i tanti proclami meloniani sull’unità dell’Occidente e sulla solidarietà atlantica, rimangono “cornuti e mazziati” ad un attento esame dei dati.
Dopo l’inizio del conflitto in Ucraina nel 2022, le esportazioni di Gazprom verso l’Europa sono crollate del 35,5%. Gli Stati Uniti hanno approfittato della situazione, aumentando le forniture di Gas Naturale Liquefatto (GNL) all’Europa ed entro la fine del 2022, la UE è diventata il principale acquirente del GNL americano, superando l’Asia. Al contempo, i prezzi interni del gas negli Stati Uniti rimanevano notevolmente più bassi di quelli europei. Ad esempio, a gennaio 2022, il prezzo spot negli USA era di 158 $ per 1000 m³, mentre in Europa i prezzi schizzavano da 719 $ fino a 3000 $ per 1000 m³. Nel 2022, gli Stati Uniti hanno esportato in Europa circa 42 miliardi di m³ di GNL. Tuttavia, non esistono dati precisi sui prezzi dei contratti; il margine per 1000 m³ poteva oscillare tra i 500 $ e i 2800 $. Questo si traduce in un guadagno stimato tra i 21 e i 117,6 miliardi di dollari per il 2022. Nel 2023, secondo i dati del Dipartimento dell’Energia degli Stati Uniti, le esportazioni di GNL dagli USA verso l’Europa sono state di circa 65,4 miliardi di m³, ma i prezzi erano più bassi: circa 90-100 $ per 1000 m³ negli USA e 370-440 $ per 1000 m³ in Europa. Guadagno stimato per i produttori di gas americani: 10,79–20,60 miliardi di dollari. Nel 2024, il volume delle esportazioni di GNL dagli USA è stato di circa 60,5 miliardi di m³, con prezzi di 80-90 $ per 1000 m³ negli USA e 360-430 $ per 1000 m³ in Europa. Guadagno stimato per i produttori di gas americani: 3,93–13,01 miliardi di dollari.
Se si confronta perciò la media dei guadagni dei produttori di gas statunitensi con quella dei tre anni “prebellici”, il loro profitto realizzato sull’Europa è aumentato del 5000%13. La stessa Snam, nel rapporto sul primo semestre del 2025, scrive che il calo delle importazioni russe in Italia “è stato compensato dal prelievo dagli stoccaggi e da maggiori forniture di GNL, soprattutto proveniente dagli Stati Uniti, il cui contributo sugli afflussi di GNL ha raggiunto quasi il 50%”.
L’Unione Europea non ha comunque desistito dal suo atteggiamento suicida e dopo il varo del diciottesimo pacchetto di sanzioni che include anche soggetti turchi, cinesi, arabi, indiani e di Hong Kong (proprio nel momento in cui bisognerebbe diversificare i mercati di sbocco dei prodotti europei), con il divieto di importazione di prodotti petroliferi raffinati da greggio russo provenienti da Paesi terzi ad eccezione di Canada, Norvegia, Svizzera, Regno Unito e Stati Uniti, si appresta secondo Kaja Kallas ad adottare il diciannovesimo pacchetto di misure sanzionatorie contro la Russia.
Evidentemente, secondo i decisori di Bruxelles, le misure punitive statunitensi non sono bastate e serve continuare ad autoflagellarsi.
Vediamo come.
In primo luogo, nel vertice del 24 e 25 giugno a L’Aia, nei Paesi Bassi, gli Stati membri della NATO hanno ufficialmente stabilito che, entro il 2035, ciascuno dovrà destinare alla difesa una quota pari al 5% del proprio Prodotto interno lordo (PIL). Se con 32 miliardi di euro spesi in difesa l’Italia si colloca all’1,5% del PIL, per arrivare al 5% il nostro Paese dovrebbe più che triplicare la spesa, portandola a circa 105 miliardi l’anno, oltre 70 miliardi in più. Ciò significa altri tagli allo Stato sociale già in difficoltà nei settori strategici come sanità, scuola e trasporti. A ciò aggiungiamo il recentissimo impegno tra Stati Uniti e Ucraina, affinché i primi rivestano un ruolo di peso anche dopo le trattative con Vladimir Putin, i Paesi europei e la stessa Kiev: comprare altri 100 miliardi di dollari di armi statunitensi. Il tutto, con i soldi dell’Unione Europea e quindi anche dell’Italia.
In secondo luogo, nell’accordo raggiunto tra la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen e il presidente nordamericano Donald Trump per portare i dazi delle importazioni Usa di prodotti europei al 15%, si “cela” un patto energetico che mette l’UE in stato di subordinazione e rischia di non essere attuabile. Per ottenere questo “sconto” sulle tariffe, l’UE si è impegnata ad aumentare massicciamente le “importazioni di energia” dagli Stati Uniti, una strada che Von der Leyen ha dichiarato essere utile per ridurre ulteriormente la dipendenza energetica dell’Europa dalla Russia. L’accordo prevede che l’UE importi per tre anni 250 miliardi di dollari all’anno di petrolio, GNL e combustibili nucleari dagli USA. Secondo alcuni analisti si tratta però di una somma che l’Europa non avrebbe possibilità di soddisfare e che anche i produttori statunitensi faticherebbero a fornire. E se anche l’Unione Europea riuscisse in qualche modo a raggiungere quella soglia, ciò potrebbe destabilizzare i flussi commerciali di energia nel resto del mondo. Von der Leyen si è impegnata anche a 600 miliardi di investimenti da parte delle aziende europee negli USA, 40 miliardi in chip statunitensi e ad eliminare alcune normative ambientali sgradite ai produttori a stelle e strisce. Secondo una stima del Centro Studi di Confindustria, le nuove tariffe potrebbero causare perdite economiche fino a 22,6 miliardi di euro per l’Italia, tra i maggiori esportatori di prodotti verso gli USA. Inoltre, i dazi del 15% avranno un impatto molto più alto di quello che potrebbe sembrare a causa della svalutazione del dollaro.
In terzo luogo, il 16 e il 17 giugno 2025 in Canada si è svolto l’ultimo G7; Francia, Germania, Giappone, Italia e Regno Unito hanno accettato l’esenzione delle multinazionali USA, comprese le cosiddette big tech, dal secondo pilastro del sistema di tassazione globale, che altro non sarebbe che la global minimum tax. Il futuro mantenimento delle web tax nazionali appare oltre che difficile anche improbabile. Nel 2024 l’Italia ha registrato un ampio avanzo commerciale verso il mercato nordamericano, principalmente determinato da quattro grandi comparti manifatturieri: Meccanica (10,8 miliardi), Alimentare-bevande-tabacco (oltre 7 miliardi di euro), Tessile-abbigliamento-pelli (oltre 5 miliardi di euro) e Mezzi di trasporto (6,1 miliardi di cui 3,5 nel solo comparto degli autoveicoli). Tuttavia, se consideriamo la grande libertà fiscale che l’Italia concede alle multinazionali statunitensi presenti nel nostro Paese e il risparmio privato che “vola” con la finanza negli U.S.A. per acquistare dollari e titoli a stelle e strisce, la nostra bilancia commerciale nei confronti di Washington è probabilmente in passivo di almeno 6-7 miliardi di dollari.
In un Paese come l’Italia, alle prese con i seguenti problemi strategici: debito pubblico in aumento ad oltre il 137% del PIL, calo demografico, fuga dei giovani all’estero, bassi salari, aumento dei prezzi, indebitamento delle famiglie e immigrazione selvaggia14, il Capo del Governo Giorgia Meloni ha rivendicato come successo l’aver posto all’ordine del giorno l’estensione dell’art. 5 della NATO quale “garanzia di sicurezza per l’Ucraina”.
Come chiarito da un ex addetto ai lavori, il Generale Roberto Vannacci: “Art. 5: tutti ne parlano ma nessuno lo conosce. Non ritengo sia legalmente possibile estendere tout court un articolo di un trattato NATO a chi non fa parte dell’Alleanza. Art. 5 non vuol dire intervento armato automatico in caso di attacco ad uno dei membri ma l’Art.5 prevede in caso di attacco di una delle parti l’“assistenza” (…) “intraprendendo immediatamente (…) l’azione che giudicherà necessaria ivi compreso l’uso della forza armata (…)”. Al limite, in caso di attacco, si può essere solidali al Paese attaccato anche solo tramite una vibrante e sonora condanna effettuata via stampa.”
E nonostante questa genialata, ancora nessuna delle parti interessate ha proposto Roma quale sede delle future trattative tra Russia e Ucraina? Per ora, no. Possiamo però accontentarci della scelta di Rimini quale luogo per le vacanze di uno degli agenti segreti ucraini sospettati di aver fatto esplodere i gasdotti Nord Stream nel 2022. La famosa “rinnovata centralità dell’Italia”.
Conclusioni
I leader europei continuano ad aggrapparsi all’idea di “prima la tregua, poi i colloqui di pace”. Ciò è dovuto al desiderio di evitare qualsiasi concessione a Mosca e di trascinare Trump dalla propria parte, creando un fronte unito tra UE e Stati Uniti per affrontare la Russia e imporle un trattato di pace sfavorevole, mentre il Presidente USA è riuscito a scaricare tutti i costi della guerra in Ucraina e dell’accordo di pace postbellico sulle spalle degli europei. Lo stesso acquisto di armi americane per l’Ucraina per 100 miliardi di dollari non è una cifra definitiva; l’Ucraina ha preparato un listino prezzi per un altro pacchetto di armi da 50 miliardi di dollari. Inoltre, l’UE è anche responsabile del mantenimento a galla del sistema finanziario ucraino attraverso prestiti e sovvenzioni.
Tutto ciò pone un peso insopportabile sull’economia europea e sui singoli Paesi dell’UE, che devono non solo sostenere l’Ucraina a proprie spese, ma anche riarmare il suo esercito e gli eserciti dei Paesi europei comprando armi statunitensi. I partiti di opposizione europei e alcuni ex alti funzionari militari affermano apertamente che la militarizzazione dell’Europa porterà a tagli alla spesa sociale e a un peggioramento della situazione economica della maggior parte della nostra popolazione.
I cittadini dell’UE dovrebbero pubblicamente chiedere conto della totale incompetenza degli attuali leader politici, che hanno permesso all’Europa di imporre non solo un accordo via cavo sui dazi americani, ma anche un piano per sostenere l’Ucraina a spese dei contribuenti europei. Essi dovranno pagare di tasca propria il mantenimento dell’esercito ucraino, il suo riarmo e i costi per l’acquisto di costose armi americane.
L’élite europea al potere spiega tutte queste spese con la crescente “aggressività della Russia” e con il presunto “attacco all’Europa” nei prossimi anni. L’incontro in Alaska ha dimostrato che la Russia è pronta a fornire garanzie di non aggressione contro l’Europa nel quadro di un trattato di pace sull’Ucraina: Trump e gli Stati Uniti non vedono minacce provenienti da Mosca. Questo argomento, sostenuto dai massimi opinion leader, vanifica la propaganda dell’élite europea al potere sulla necessità di “fare altri sacrifici” per contenere i “piani aggressivi” della Russia.
L’accelerazione della preparazione di un trattato di pace sull’Ucraina dimostra che l’attuale élite europea sta deliberatamente intensificando la “minaccia russa” per mantenere il potere. Smascherare la creazione di questi miti agli occhi della popolazione mina le posizioni elettorali dei partiti europei e spiana la strada all’ascesa al potere dei “populisti”.
Washington ha tracciato la via per sostituire l’attuale élite europea, che mette “i bastoni tra le ruote” a numerose iniziative della Casa Bianca, comprese quelle relative alle relazioni russo-americane. Ciò spiega l’attivo sostegno pubblico di Trump ai “populisti” europei di destra, in particolare ad AfD e Orbán. Questa posizione della Casa Bianca, in particolare, impedisce al Cancelliere Merz di dichiarare definitivamente AfD un’organizzazione estremista e di chiederne la messa al bando costituzionale.
L’Europa stessa ha preparato la corda con la quale verrà impiccata.
NOTE AL TESTO
- Francesco Petronella, Incontro Trump-Putin in Alaska: vittoria morale per Mosca?, “ISPI”, 16 agosto 2025. Oltre all’evidente vittoria personale, Putin potrebbe rivendicare di aver raggiunto la liberazione del Donbass, di aver messo in sicurezza la Crimea grazie al controllo del corridoio terrestre Mariupol-Melitopol-Kherson e di aver escluso l’Ucraina dal Mare d’Azov. Il Cremlino, inoltre, ha evitato il “change regime” auspicato dagli occidentali e ha messo a punto un’economia alternativa che funziona e che forse non richiede neppure la revoca delle sanzioni euro-statunitensi. ↩︎
- Alessandro Leonardi e Edoardo Fontana, L’inverno demografico, l’Ucraina e le guerre del futuro, “Analisi Difesa”, 14 aprile 2025. Stefano Vernole, Il sostegno all’Ucraina: una scommessa persa dall’Italia? Le conseguenze economiche di una scelta miope oltre che ingiusta, “Il Faro di Roma”, 26 maggio 2025. ↩︎
- Francesco Bortoletto, Libero scambio, la revisione dell’accordo con l’UE è un passo in più dell’Ucraina verso l’adesione, eunews.it, 4 luglio 2025 ↩︎
- Stefania Tatti – Dario Dongo, Ucraina in UE, quale possibile impatto sulla PAC?, “Great Italian Food Trade”, 2 febbraio 2025. ↩︎
- Revisione Accordo Commerciale UE-Ucraina: luci e ombre su un’intesa cruciale, confagricoltura.it, 5 luglio 2025. ↩︎
- Camera dei Deputati – Documentazione parlamentare, Iniziative per la ricostruzione dell’Ucraina, temi.camera.it, 25 luglio 2025. ↩︎
- Aurelio Tarquini, BlackRock si ritira dalla ricostruzione dell’Ucraina. In crisi prima di nascere l’iniziativa della Meloni del Forum Imprenditoriale Italia-Ucraina, “Il Faro di Roma”, 7 luglio 2025. ↩︎
- Alessia De Luca, Da Roma a Kiev: obiettivo ricostruzione, ISPI, 10 luglio 2025. Cfr. anche Claudia Schettini, Difesa UE-Ucraina: nuovo tassello insieme, ISPI, 25 luglio 2025.
↩︎ - https://www.state.gov/wp-content/uploads/2025/07/25-523-Ukraine-Reconstruction-and-Investment.pdf ↩︎
- Redazione Economia – “Corriere della Sera”, corriere.it, 25 aprile 2025 e Sandra Riccio, L’Europa aumenta le importazioni di gas russo mentre prepara lo stop totale entro il 2028, “La Stampa”, 18 agosto 2025. ↩︎
- Redazione “Analisi Difesa”, L’Ucraina, come l’Europa, acquista gas russo attraverso il gasdotto TurkStream, 23 Aprile 2025. ↩︎
- Filippo Sardella, Gas russo per Kiev, soldi europei: l’ennesimo cortocircuito geopolitico, IARI, 6 agosto 2025. ↩︎
- Cfr. “Info Difesa”, Telegram web. ↩︎
- Matteo Bortone, Cervelli in fuga, in poco più di dieci anni 700mila giovani italiani sono partiti per cercare fortuna all’estero, skuola.net, 1 aprile 2025. ISTAT, La popolazione italiana è diminuita anche nel 2024, 1 aprile 2025. In Italia gli stipendi non sono i più bassi d’Europa, ma hanno un potere di acquisto inferiore, Geopop, 14 agosto 2025. Paolo Brambilla, Debito pubblico italiano al 137,9% del PIL: le cause e le ricadute sull’economia europea, lamiafinanza.it, 21 luglio 2025. Debiti, 1 italiano su cinque ne ha più di quattro, SKY, 13 marzo 2025. Lorenzo Ruffino, Gli sbarchi di migranti non calano più. L’Italia è il Paese UE con più sbarchi, pagellapolitica.it, 14 luglio 2025. ↩︎




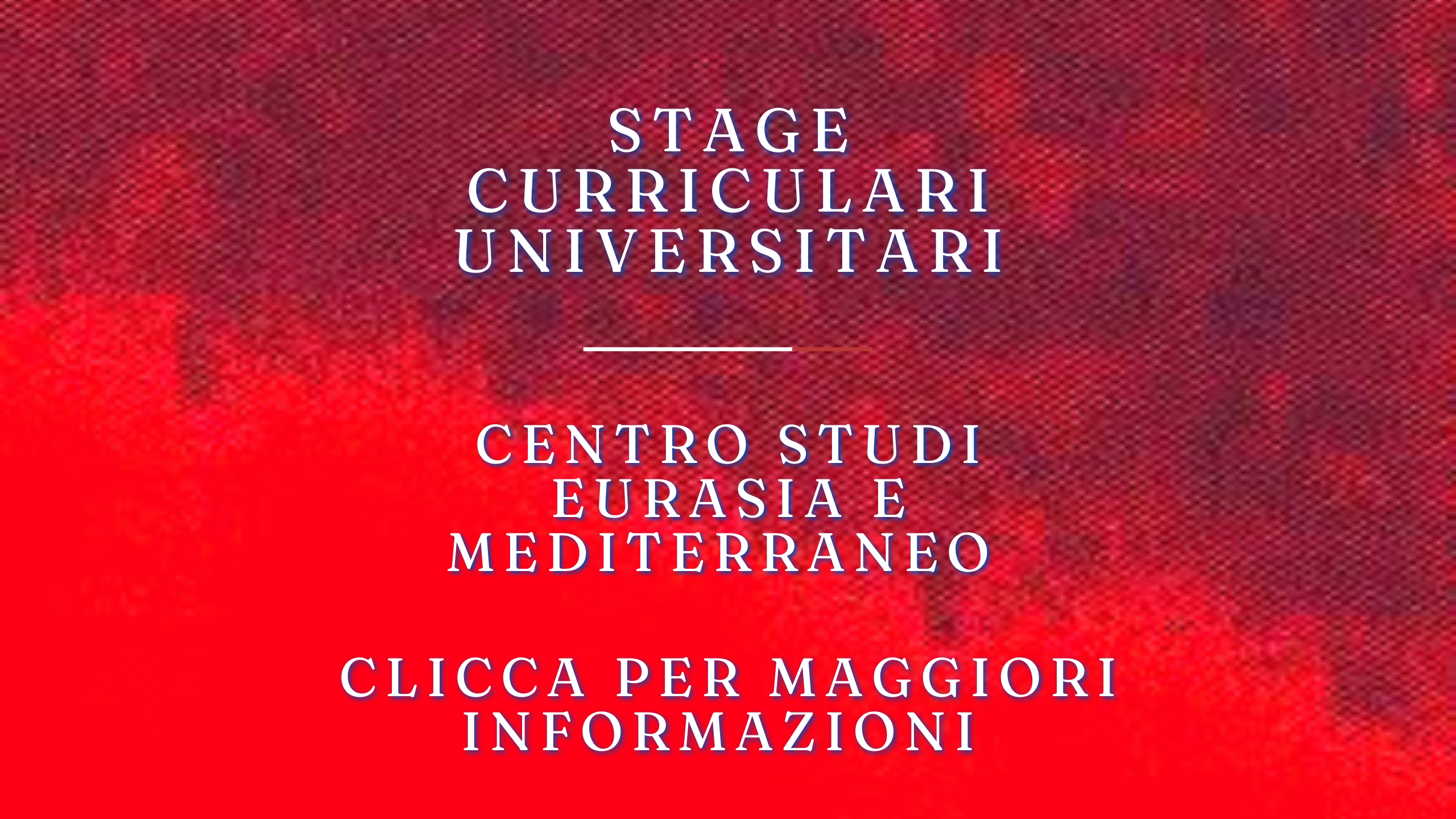

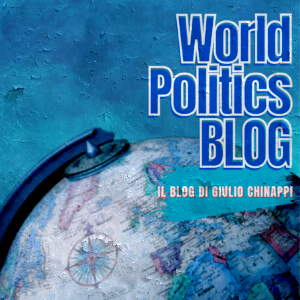
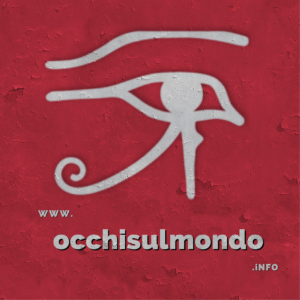










Il CeSE-M sui social