a cura di Alessandro Marini
Nel contesto attuale delle relazioni internazionali, le sanzioni economiche rappresentano uno degli strumenti più discussi e controversi della diplomazia globale. Utilizzate per esercitare pressione su Stati che abbiano agito in violazione del diritto internazionale o dei diritti umani, le sanzioni sollevano interrogativi cruciali sulla loro efficacia, legittimità e impatto sulle popolazioni civili. In questo articolo, attraverso un’intervista esclusiva con Matteo Fulgenzi, esperto della materia, analizziamo il ruolo delle sanzioni nella geopolitica contemporanea e nei più recenti contesti di crisi.
Matteo Fulgenzi, classe ’82, è dottore di ricerca in “Innovazione e gestione delle risorse pubbliche” (XXXIV ciclo, curriculum “Governo e relazioni internazionali”) e professore a contratto di diritto internazionale presso l’Università degli studi di Verona.
Laureato con Lode in Giurisprudenza presso l’Università del Salento e in Management Internazionale presso l’ICN Business School – Grande École de Management di Nancy (Francia) e l’Università MGIMO di Mosca per le Relazioni Internazionali (Federazione Russa), ha ricoperto per anni il ruolo di Export-manager nell’organigramma di prestigiose aziende del Made in Italy.
Qual è lo scopo principale delle sanzioni nella politica internazionale?
Riguardo lo scopo principale delle sanzioni è bene sapere che l’istituto delle sanzioni è concepito dai singoli Stati, dalle organizzazioni regionali e dall’ONU secondo diverse accezioni talvolta contrastanti sul piano logico e giuridico. Nell’ambito del diritto internazionale si possono distinguere tre principali visioni interpretative: la prima insiste sullo scopo obiettivamente perseguito attraverso l’imposizione di misure sanzionatorie come atti posti in essere da parte di Stati e altre organizzazioni, in reazione a una violazione delle regole consuetudinarie accettate come fondamento vincolante della comunità di Stati; una seconda interpretazione si rivolge all’individuazione della fonte di carattere istituzionale da dove possano emergere tali misure, concentrandosi sulle differenti tipologie di provvedimenti sanzionatori che possono essere indirizzate nei confronti di singoli Stati membri trasgressori; un terzo orientamento mira a formulare un’appropriata qualificazione giuridica delle sanzioni internazionali sulla base di concrete tipologie di provvedimenti dove le sanzioni possono essere tradotte. Quindi tale approccio interpreta queste misure restrittive come provvedimenti di azione esterna con carattere economico-commerciale, adottati dagli Stati al fine di interrompere le consuete relazioni commerciali e finanziarie di tali Stati con altri Stati.
Queste misure (sull’esempio dell’articolo 41 della Carta dell’ONU) possono riguardare sia il blocco generalizzato o settoriale dei traffici commerciali internazionali con un determinato Stato e l’imposizione di restrizioni di vario grado all’importazione o esportazione di specifici beni provenienti dal paese colpito sia il congelamento di beni o la limitazione di alcune libertà.
Secondo lei, quanto sono efficaci le sanzioni nel raggiungere gli obbiettivi politici desiderati?
Riguardo l’efficacia, possiamo dire che dipende da diversi fattori infatti la loro efficacia non è sempre garantita. Le sanzioni tendono ad essere più efficaci quando gli obbiettivi politici sono chiari e misurabili. Se l’obbiettivo è chiaro, è più facile valutare se hanno avuto successo o meno. L’efficacia dipende anche dal paese che subisce le sanzioni, se il paese è molto dipendente dal commercio internazionale, dalle esportazioni di materie prime o dagli investimenti esteri, le sanzioni economiche possono essere più forti.
Inoltre, le sanzioni hanno una maggior probabilità di successo quando sono applicate da organizzazioni internazionali quindi da un ampio gruppo di paesi. La durata delle sanzioni è un altro importante aspetto che può determinare l’impatto. L’efficacia può dipendere anche da come vengono gestite le condizioni interne del paese sanzionato. Se la popolazione è già insoddisfatta del governo, le sanzioni potrebbero contribuire ad aumentare pressione interna. Le sanzioni spesso non sono sufficienti da sole a modificare il comportamento di un paese, in quanto questo potrebbe cercare di aggirarle attraverso alleanze alternative, mercati paralleli o politiche interne di resilienza. Ad esempio la Russia e l’Iran hanno sviluppato modi per bypassare le sanzioni stabilendo nuovi accordi economici con altri paesi non allineati con le sanzioni internazionali.
Quali sono alcune conseguenze non intenzionali delle sanzioni, specialmente sulle popolazioni civili?
Al giorno d’oggi, in un mondo globalizzato, caratterizzato da elevati livelli di interdipendenza economica tra i vari membri della comunità internazionale, le operazioni di assedio non si attuano più bloccando, tramite l’esercito, gli approvvigionamenti delle città o impedendo l’accesso di navi e velivoli a porti ed aeroporti. Infatti è sufficiente interrompere i flussi di merci e capitali in entrata e in uscita dal paese da punire, ricorrendo alla propria capacità di controllo e condizionamento del sistema del commercio e delle transazioni finanziarie internazionali.
Pertanto basta poco perché uno Stato sia unilateralmente tagliato fuori dal mondo e non possa più assolvere al fabbisogno materiale delle proprie strutture organiche nonché di garantire diritti e livelli minimi di sussistenza alla propria popolazione. In questa prospettiva le sanzioni economiche manifestano una natura punitiva rivelando il proprio ruolo di “mano armata” di una globalizzazione dove la crescente interdipendenza economica potrebbe degenerare da grande opportunità a strumento di ricatto nell’arsenale delle potenze più forti.
Si possono aprire degli scenari dove uno Stato non risulti nelle condizioni di poter opporre agli aggressori un’adeguata risposta a livello economico-finanziario e che quindi la sua risposta può rischiare di sfociare alla rappresaglia militare o addirittura all’uso dell’arma atomica in qualità di estrema contromisura. Di vitale importanza è sapere che secondo il diritto internazionale e ancor più nello specifico per il diritto umanitario, le sanzioni dovrebbero essere rivolte esclusivamente nei confronti dei soggetti- persone fisiche e giuridiche- effettivamente identificati come responsabili decisionali o autori materiali dei comportamenti giudicati internazionalmente riprovevoli, escludendo l’ipotesi che dalla contestazione di tali condotte a singole persone possa scaturire l’imposizione di sanzioni nei confronti di uno Stato nella sua interezza.
Tutti gli Stati e gli organismi internazionali sono vincolati dalle norme universali sui diritti umani e dal diritto umanitario. Ma contrariamente a ciò, le sanzioni economiche imposte in tempo di guerra violano il divieto di affamare la popolazione civile. Infatti qualunque sia il fine politico o strategico delle misure imposte, è proibito far morire di fame i civili come metodo di guerra, poiché i civili non possono essere privati dell’accesso ai beni indispensabili per la loro sopravvivenza e non può comunque essere loro impedito di ricevere la necessaria assistenza umanitaria.
Può fare l’esempio di un caso in cui le sanzioni hanno avuto un impatto significativo, positivo o negativo?
Legando la risposta alla precedente, nel riprendere il tema del diritto umanitario scarsamente rispettato da alcuni Stati nel punirne altri con sanzioni, possiamo ricordare il numero di bambini morti in Iraq nei soli anni 90, per una cifra che si aggira tra i 670 000 e gli 880 000 o il paralizzante blocco inflitto a Cuba dagli Usa (solo per il fatto di esistere) con una perdita complessiva per l’economia dell’isola caraibica che già nel 2007 avrebbe sfiorato i 90 miliardi di dollari.
Quale ruolo giocano le Nazioni Unite e altre organizzazioni internazionali nell’imposizione e gestione delle sanzioni?
L’ONU ha un ruolo di centralità nell’ambito della sicurezza collettiva, incentrato sul ruolo concertativo del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, come unico organo multilaterale competente in merito all’individuazione di minacce o violazioni della pace e della sicurezza internazionale, nonché come il solo organismo legittimato sulla base del diritto internazionale all’imposizione di misure coercitive, implicanti o meno l’uso della forza nei confronti degli Stati ritenuti responsabili di tali minacce o violazioni. Legando il discorso al caso specifico della Russia risultano interessanti le argomentazioni di Mosca in materia di diritto internazionale del commercio, nello specifico riguardo l’attivazione da parte dell’OMC delle Security Exceptions, per capire la centralità del ruolo di questa organizzazione, concepita proprio allo scopo di de-politicizzare il commercio e impedirne l’uso come “arma”.
Secondo la Russia la liceità dell’imposizione di queste sanzioni economiche da parte dell’Occidente sono prive di fondamento. Infatti Mosca riconosce al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite il ruolo di unica autorità mondiale investita della prerogativa di disciplinare l’uso della forza anche economica –sanzioni-, in reazione a eventuali minacce o violazioni nei confronti della pace e della sicurezza della comunità internazionale.
Come reagiscono solitamente gli Stati sanzionati e quali strategie adottano per mitigare gli effetti delle sanzioni?
Per rispondere a questa domanda prendiamo sempre in esempio il caso della Russia che nell’agosto del 2014 introdusse in risposta alle sanzioni delle proprie contro-sanzioni sviluppate in un ampio embargo selettivo riguardante alcune tipologie di materie prime, prodotti agricoli e generi alimentari provenienti dai paesi sanzionanti. Le misure imposte da Mosca sono state introdotte dal Cremlino sulla base della legge federale “sulle speciali misure economiche e misure coercitive” poi rinnovate ed estese in reazione al progressivo inasprimento dell’offensiva sanzionatoria unilaterale condotta dall’Occidente. Con una nuova legge del 2018 è stata garantita al Presidente della Federazione Russa la facoltà di imporre provvedimenti restrittivi di natura economico-sociale nei confronti di paesi, individui e entità straniere classificate come ostili. Altro esempio importante riguarda le sanzioni statunitensi che colpiscono Stati terzi (c.d. sanzioni extraterritoriali) e le attività dei loro operatori economici che sono incorse in severe critiche da parte dell’ONU e di vari Stati, i quali hanno contestato la loro legittimità ai sensi del diritto internazionale.
Le sanzioni contro un paese possono avere ripercussioni sull’economia globale? Se sì, in che modo?
Sì, le sanzioni contro un paese possono avere ripercussioni sull’economia globale, esse possono influenzare i mercati globali, il commercio internazionale e le dinamiche economiche di altri paesi. Le sanzioni imposte ad un paese possono interrompere la produzione e la distribuzione di beni chiave in particolare se il paese sanzionato è un importante fornitore di materie prime. Se un paese è un grande produttore di petrolio, le sanzioni potrebbero ridurre la disponibilità di queste risorse. Se il paese sanzionato è un importante esportatore di materie prime, le restrizioni sulle esportazioni possono ridurre l’offerta di tali beni, provocando aumenti dei prezzi a livello globale.
Le sanzioni possono anche obbligare le imprese a rivedere le loro rotte commerciali e i flussi di investimento. Alcuni paesi potrebbero cercare di sostituire il paese sanzionato con altri fornitori o partner commerciali, modificando gli equilibri economici. Le sanzioni possono influire sulla politica economica di paesi alleati o neutrali. Se un paese terzo è costretto a scegliere se aderire o meno alle sanzioni ciò può portare a un cambiamento nei suoi rapporti economici internazionali, alterando equilibri economici già consolidati. Le sanzioni possono anche influenzare le alleanze internazionali e la cooperazione economica tra paesi.
Quali sono state le principali motivazioni alla base delle sanzioni imposte alla Russia negli ultimi anni?
La motivazione principale alla base delle sanzioni imposte alla Russia è sicuramente la violazione dell’integrità territoriale dell’Ucraina, a partire dal 2014, in violazione dell’articolo 2.4 della carta ONU e dell’analoga regola di jus cogens che vieta l’uso della forza in violazione dell’indipendenza e integrità degli Stati sovrani.
Qual è stato l’impatto economico delle sanzioni sull’economia russa e come ha reagito il governo russo per mitigare questi effetti?
La risposta del governo russo per mitigare gli effetti delle sanzioni ha incluso l’adozione di un esteso programma nazionale di sostituzione dell’import e mirante, inoltre, al rinnovamento tecnologico del tessuto industriale e produttivo russo, nonché alla ripresa dell’economia del Paese. Un’altra conseguenza logica della situazione venutasi a creare per la Russia, è stata la necessità di reperire già nel breve termine nuovi investitori e fornitori al fine di sopperire all’improvvisa carenza di approvvigionamenti, ponendo così le basi per la progressiva integrazione del sistema economico della Federazione Russa con le infrastrutture finanziarie e logistico produttive di quei paesi – per lo più asiatici – non aderenti ai regimi sanzionatori dell’Occidente.
Si parla, così, del cosiddetto Pivot to Asia, di questo repentino riorientamento dell’economia russa verso l’Asia e di come questo abbia danneggiato molte aziende e produttori europei, in precedenza molto legati a Mosca.
A partire dal 2014, inoltre, la Russia ha progressivamente introdotto stringenti limitazioni alla partecipazione delle imprese straniere alle aste per le forniture pubbliche relative a moltissimi prodotti come le apparecchiature medicali o determinate tipologie di prodotti tessili.
Come hanno reagito altri paesi – sia alleati che non alleati – alle sanzioni imposte alla Russia? Ci sono stati casi di paesi che hanno cercato di eludere le sanzioni?
Le posizioni dei Paesi del mondo di fronte all’imposizione delle sanzioni nei confronti della Russia sono state distinte e diverse: riguardo l’Unione Europea, ad esempio, sono state adottate misure di sanzioni molto severe che hanno creato forti tensioni all’interno della stessa Unione, in particolare tra i paesi che dipendono fortemente dall’energia russa e dal commercio con Mosca come la Germania e l’Italia.
Gli Stati Uniti sono stati tra i principali promotori delle sanzioni contro la Russia, imponendo misure economiche e finanziarie anch’esse molto severe. Hanno anche fornito aiuto pratico inviando un grande quantitativo di armi e denaro a Kiev.
Il Regno Unito ha allineato le sue politiche sanzionatorie con quelle di Stati Uniti e UE ed ha cercato di ridurre la sua dipendenza dalle importazioni energetiche provenienti dalla Russia.
Tra i Paesi non allineati abbiamo la Cina che ha assunto una posizione più diplomatica, ha cercato di mantenere buone relazioni con Mosca, ha criticato le sanzioni occidentali ma ha mantenuto un atteggiamento cauto, evitando di sostenere completamente e apertamente l’invasione russa.
Ha, però, continuato ad approfondire i legami economici con la Russia, in particolare nel settore energetico e ha sostenuto il diritto della Russia a proteggere i suoi interessi nazionali.
L’India ha seguito una posizione simile a quella della Cina cercando di mantenere una posizione di equilibrio tra la sua alleanza strategica con gli Stati Uniti e la sua tradizionale relazione con la Russia, risalente, questa, ai tempi della guerra fredda. L’India ha, così, opposto un rifiuto alla richiesta di adesione alle sanzioni occidentali mentre ha continuato ad acquistare petrolio dalla Russia a prezzi scontati e vantaggiosi per la propria produzione industriale ed economia.
La Turchia ha adottato una posizione diplomatica pragmatica cercando di bilanciare i suoi “obblighi” verso l’alleanza NATO con i suoi legami economici e politici con la Russia. Ha resistito all’idea di sanzioni contro Mosca e ha continuato a intrattenere rapporti economici con Mosca, pur criticando l’invasione e, al contempo, offrendosi come mediatore tra le due parti.
Alcuni paesi del Golfo, come l’Arabia Saudita, hanno evitato di schierarsi apertamente contro la Russia, mantenendo una posizione di neutralità o sostegno indiretto. Sebbene abbiano cooperato con gli Stati Uniti su alcuni aspetti – tra cui la politica energetica – non hanno adottato sanzioni dirette contro Mosca ma, piuttosto, hanno continuato a collaborare nel settore energetico con la Russia.
Per i paesi dell’area dell’America Latina, la reazione è stata di solidarietà nei confronti della Russia con delle eccezioni come il Brasile che ha cercato di mantenere buoni rapporti con ambo i lati mentre paesi come Venezuela e Cuba hanno sostenuto apertamente la Russia.
Riguardo l’Africa, infine, molti paesi hanno adottato una posizione di neutralità o di non allineamento pur riconoscendo l’impatto delle sanzioni sulla loro economia.
Quali sono stati gli effetti delle sanzioni sulla popolazione civile russa e come sono stati gestiti dal governo?
Le sanzioni hanno avuto un impatto diretto sull’economia russa, con una serie di conseguenze che hanno condizionato la vita quotidiana della popolazione. C’è stata una spinta all’inflazione molto elevata, con aumento di prezzi di beni di consumo, cibo e servizi. Il rublo, almeno inizialmente, ha subito un forte deprezzamento rispetto alle valute straniere e questo ha reso più costosi i prodotti importati e ha aumentato il costo della vita. L’uscita di grandi aziende internazionali dalla Russia e il rallentamento delle attività commerciali hanno portato alla chiusura di molte imprese, con l’ovvia conseguenza di perdita di posti di lavoro. Così, in molte aree produttive, la disoccupazione è aumentata e i redditi si sono ridotti soprattutto per i ceti più bassi.
Il governo russo ha, però, adottato una serie di misure per cercare di alleviare gli effetti delle sanzioni sulla popolazione civile anche se molte hanno avuto effetti limitati o temporanei. C’è stato un controllo dei capitali e di restrizioni sui pagamenti, limitando i prelievi bancari e le transizioni in valuta estera. Inoltre il governo russo ha messo in atto una forte campagna di comunicazione per giustificare la guerra in Ucraina e minimizzare gli effetti delle sanzioni. In risposta alle difficoltà economiche, il Governo ha cercato di implementare alcune misure di sostegno alle famiglie più vulnerabili anche se queste non sono state sufficienti a compensare pienamente gli effetti negativi delle sanzioni.
In che modo le sanzioni hanno colpito il settore energetico russo, in particolare le esportazioni di gas e petrolio oppure questo si è orientato verso altre mete?
Le sanzioni progressivamente configurato il divieto di importazione di gas e petrolio da parte dei paesi dell’Unione Europea, Stati Uniti, Regno Unito e altri alleati occidentali. L’UE, in particolare, ha cercato di ridurre la sua dipendenza dal gas russo, elaborando piani per l’interruzione graduale delle importazioni.
Il settore del petrolio ha visto un impatto simile, con l’imposizione di restrizioni alle esportazioni di petrolio russo verso l’Europa. Nonostante le difficoltà, la Russia è riuscita a diversificare le sue esportazioni energetiche e spostarle verso altri mercati non soggetti alle sanzioni occidentali. In particolare, i flussi energetici si sono concentrati su paesi asiatici come la Cina e l’India, che hanno continuato a importare petrolio e gas russo, e in alcuni casi a prezzi scontati.
Il settore del gas ha subito le pressioni più forti a causa delle sanzioni, poiché l’Europa era tradizionalmente il principale mercato di esportazione. La Russia ha cercato, così, di rispondere a queste sfide riorientando le sue forniture di gas soprattutto verso l’Asia, ma questo non è stato un processo facile né veloce anche in virtù dello stato delle infrastrutture.
Come hanno influenzato le sanzioni le relazioni geopolitiche tra la Russia e altri paesi, in particolare quelli dell’Unione Europea e della NATO?
In generale, possiamo dire che le sanzioni contro la Russia hanno accelerato il deterioramento delle relazioni geopolitiche tra la Russia e l’Unione Europea e la NATO, contribuendo a creare un clima di ostilità sempre più crescente. Questa imposizione di restrizioni economiche ha fatto crescere la sfiducia reciproca alimentando una retorica di confronto, con la Russia che ha accusato l’Occidente di cercare di destabilizzare il suo sistema politico ed economico.
Mentre la Russia ha cercato di riorientare le sue alleanze verso altri paesi (come la Cina, l’India e altri Stati asiatici), l’Occidente ha reagito unendo le forze per isolare la Russia economicamente e politicamente, rafforzando al contempo il ruolo della NATO e cercando nuove soluzioni per la sicurezza globale in quanto si è trovato a dover affrontare un’ulteriore allineamento tra la Russia e le potenze non occidentali; soprattutto l’avvicinamento tra Mosca e Pechino è quel che preoccupa maggiormente le stanze del potere occidentale.
Questi sviluppi hanno cambiato profondamente le dinamiche geopolitiche, con un possibile ritorno alla guerra fredda e una polarizzazione crescente tra blocchi di potere globali, tra l’altro le sanzioni hanno ridotto la capacità della Russia di partecipare a forum internazionali e hanno limitato la sua influenza in diverse organizzazioni globali.
“La Guerra delle Sanzioni”. L’Unione Europea e la Federazione Russa nell’era dell’interdipendenza economica globale.
Questo studio indica il diritto internazionale come fattore-chiave per comprendere, affrontare e superare la crisi geopolitica in atto in Ucraina. La presente ricerca, infatti, analizza la natura giuridica e le effettive implicazioni delle misure economiche restrittive unilaterali adottate nell’ambito della “guerra delle sanzioni” tra l’Occidente e Mosca, identificando infine l’Omc come quadro giuridico e istituzionale per la possibile normalizzazione delle relazioni tra l’Ue e la Russia.


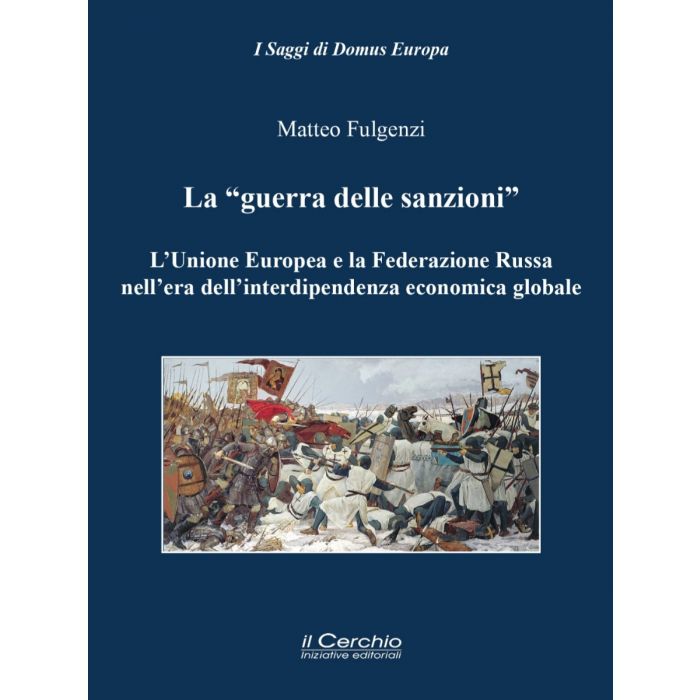


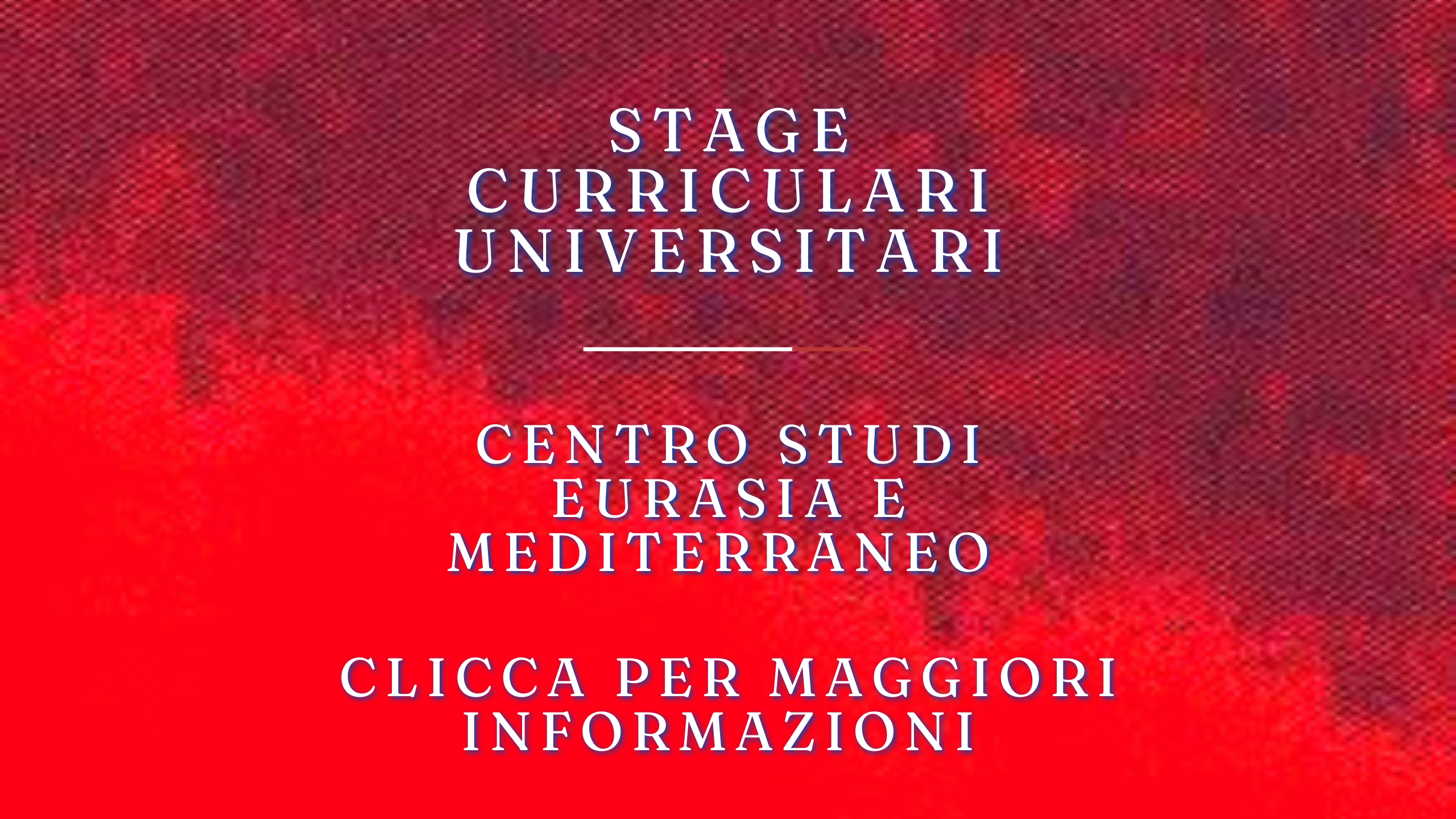

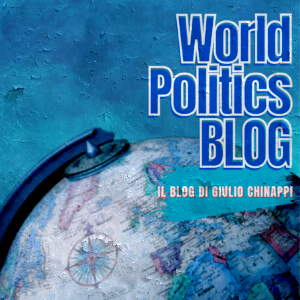
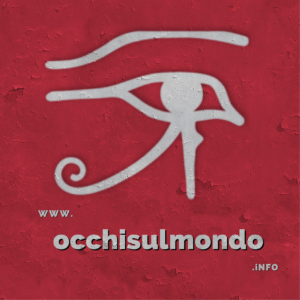










Il CeSE-M sui social