di Giulio Chinappi
In questo libro, Zhou Kun ricostruisce il lungo cammino politico ed economico che ha condotto la Cina verso la «società moderatamente prospera», confrontando i progetti e le pratiche dei leader che hanno guidato la Repubblica Popolare dalle origini alla «Nuova Era».
fONTE ARTICOLO: https://giuliochinappi.com/2025/09/23/recensione-il-percorso-verso-una-cina-moderatamente-prospera-di-zhou-kun/
Il percorso verso una Cina moderatamente prospera (Anteo Edizioni, 2025) di Zhou Kun offre un’ampia e organica ricostruzione della traiettoria storica che ha portato la Cina contemporanea all’obiettivo dichiarato della «società moderatamente prospera» (小康, Xiǎokāng). Il testo si pone come un racconto politico e teorico che attraversa l’esperienza dei cinque leader centrali della Nuova Cina — Mao Zedong, Deng Xiaoping, Jiang Zemin, Hu Jintao e Xi Jinping — individuando in ciascuno il contributo specifico alla costruzione del percorso, senza tacere le contraddizioni politiche ed economiche emergenti in ogni fase. La tesi centrale di Zhou è che il percorso è il frutto di correzioni successive, di aggiustamenti di obiettivi e di stili di governo, non di passaggi lineari né di meri accidenti contingenti; è dunque utile leggere il libro come uno studio della formazione di una politica nazionale pluridecennale, più che come un semplice vademecum di slogan.
L’analisi del periodo maoista che Zhou propone è attenta alle ricadute materiali delle scelte di politica economica. L’autore ricorda, con abbondanza di documenti e citazioni, come Mao avesse posto la modernizzazione come orizzonte già nelle fasi finali della guerra rivoluzionaria e nei primi anni della Repubblica, fissando le «quattro modernizzazioni» come obiettivo strategico della nazione (industria, agricoltura, trasporti, difesa). L’autore sottolinea inoltre come la stagione maoista abbia prodotto contemporaneamente fondamenta istituzionali — la base politica dello Stato socialista — e gravi fratture (Grande Balzo in Avanti, Rivoluzione Culturale) che interruppero i percorsi economici e intellettuali e ritardarono la modernizzazione effettiva. Il libro cita testualmente discorsi e documenti dell’epoca per mostrare la tensione tra obiettivo strategico e pratiche politiche.
La parte dedicata a Deng Xiaoping è la più analitica e forse la più importante per chi voglia capire il presente economico cinese. Zhou ricostruisce il passaggio dalla traumatica esperienza rivoluzionaria alla «apertura e riforma» come una scelta pragmatica e riflessiva, io quanto Deng comprese il divario tecnologico ed economico con il mondo avanzato, proponendo la cosiddetta «modernizzazione in stile cinese», cioè l’adattamento degli obiettivi alle condizioni nazionali, dando la priorità al recupero economico e al miglioramento del tenore di vita. Zhou cita con evidenza momenti-chiave — i viaggi di Deng all’estero nel 1978-1979, l’adozione di standard pratici come il famoso obiettivo dei «mille dollari pro capite» (e la formula «mangiare bene, vestirsi bene, vivere bene») — per mostrare come si sia trattato di una svolta culturale e strategica oltre che economica. L’autore spiega, inoltre, che le riforme denghiane hanno introdotto elementi di mercato nell’economia pianificata, hanno sperimentato zone speciali come Shenzhen e hanno rimodellato la natura stessa del partito-stato, aprendolo a una nuova relazione con le forze produttive.
L’era di Jiang Zemin è il periodo della sistematizzazione delle riforme e dell’estensione di un progetto di modernizzazione su scala nazionale. Le «Tre Rappresentanze» assumono qui un peso teorico e pratico rilevante, dimostrando come Jiang abbia cercato di ridefinire il legame tra partito e società estendendo la rappresentanza agli interessi delle forze produttive avanzate e giustificando così la presenza di nuovi soggetti (inclusi gli imprenditori) nello spazio politico. Allo stesso tempo, l’autore ricostruisce le politiche industriali e territoriali lanciate alla fine degli anni Novanta e nei primi anni Duemila — dalla strategia di sviluppo della Cina occidentale alle politiche per le imprese statali — come tentativi di collegare crescita, modernizzazione e coesione nazionale. Zhou sottolinea che la retorica di Jiang coniugava economia di mercato socialista e rafforzamento del ruolo statale, un equilibrio che egli interpreta come caratteristico della terza generazione dirigente.
La riflessione sulla leadership di Hu Jintao, invece, evidenzia un cambio di priorità. Zhou attribuisce a Hu la formulazione di un’agenda più attenta alla «coesione sociale» e alla stabilità. In questo contesto, la «società armoniosa» e la maggiore enfasi sul ruolo della scienza e della prevenzione dei rischi macroeconomici vennero promosse dal quarto leader della Nuova Cina come risposte alle disuguaglianze crescenti e alle vulnerabilità emerse nel decennio precedente. Nel capitolo dedicato, Zhou ricostruisce come Hu abbia posto il tema della crescita di qualità, della gestione dei rischi e della protezione sociale al centro dell’agenda statale, soprattutto per far fronte alla crisi globale del 2008, con il fine di sostenere l’economia interna. L’autore interpreta questa fase come una transizione da una crescita quantitativa a un tipo di sviluppo che cerca di combinare la crescita economica con politiche di benessere e stabilità politica.
Infine, Zhou dedica attenzione alla leadership di Xi Jinping e alla sua ridefinizione del progetto a scala ancora più ampia: l’«apertura della Nuova Era del Socialismo con Caratteristiche Cinesi» segna, infatti, un nuovo capitolo dove la centralità del partito, la strategicità dell’autonomia tecnologica e l’ambizione geopolitica si combinano. Zhou analizza i concetti-guida introdotti sotto Xi — la centralità della sicurezza nazionale, la lotta contro la povertà fino alla «vittoria decisiva», e l’enfasi sulla trasformazione ecologica e culturale — per mostrare come il discorso politico abbia ampliato la scala degli obiettivi: non più solo modernizzazione interna, ma anche capacità di influenza globale e resilienza strategica. Inoltre, sotto la leadership di Xi Jinping, la narrativa della «via cinese» diventa esplicitamente anche discorso sulla sovranità tecnologica e sulla leadership morale della civiltà cinese.
Dal punto di vista critico, il libro di Zhou è certamente efficace nel ricostruire linee e dispositivi politici, ma non evita i passaggi controversi, ammettendo gli errori del passato e presentando la traiettoria cinese come una serie di correzioni, di apprendimenti e di successi pianificati. Questo approccio risulta utile soprattutto per chi studia le strategie di stato e la continuità istituzionale, ma anche per il lettore che vuole comprendere meglio lo sviluppo della Repubblica Popolare Cinese negli ultimi 75 anni. In ogni caso, Zhou fornisce un patrimonio di fonti e riferimenti che rende il volume una risorsa notevole per il lettore italiano che voglia accostarsi al discorso accademico cinese sulla modernizzazione.
In conclusione, Il percorso verso una Cina moderatamente prospera di Zhou Kun è un’opera densa, ben documentata e coerente con le categorie interpretative usate nel dibattito politico cinese contemporaneo. Offre una mappa preziosa per capire come la leadership del PCC abbia ridefinito obiettivi e strumenti politici nel corso di sette decenni, mettendo in luce continuità teoriche (la centralità del partito, l’attenzione alla modernizzazione) e discontinuità pratiche (riforme di mercato, politiche sociali, strategie di posizionamento internazionale). Per il lettore interessato alla politica comparata o alla storia contemporanea della Cina, il libro rappresenta una buona sintesi di fonti primarie e di interpretazioni utili; per il lettore critico, la forza del volume rimane nella ricchezza documentale che permette di ripercorrere i nodi irrisolti e di riflettere sulle future traiettorie del gigante asiatico.
IL LIBRO
Questo libro espone il percorso che ha portato alla creazione di una società moderatamente prospera in Cina. Racconta la storia di come, sotto la guida del Partito Comunista Cinese, la nazione cinese, attraverso una continua esplorazione, abbia infine formato una teoria completa di “società moderatamente prospera” e abbia trovato la strada corretta del socialismo con caratteristiche cinesi per raggiungere la modernizzazione.
Aderendo e migliorando il sistema del socialismo con caratteristiche cinesi e promuovendo la modernizzazione del sistema di governo nazionale e della capacità di governo, sono stati raggiunti risultati storici nella costruzione di una società moderatamente prospera sotto tutti i punti di vista e il percorso del socialismo con caratteristiche cinesi è stato gradualmente tracciato.
Zhou Kun ha conseguito il dottorato di ricerca presso la Renmin University of China e la Tongji University. Attualmente è direttore del Primo Ufficio di Ricerca per la Teoria di Deng Xiaoping e la Storia del Periodo di Riforma e Apertura presso il Terzo Dipartimento di Ricerca dell’Istituto di Storia e Letteratura del Partito del Comitato Centrale del PCC, Segretario Generale dell’Associazione di Ricerca sul Pensiero e la Vita di Deng Xiaoping e membro del team centrale del National High-End Think Tank. Come sceneggiatore o scrittore, ha partecipato a oltre dieci opere cinematografiche e televisive. Ha pubblicato numerosi libri e più di 80 articoli teorici su giornali e riviste come il Quotidiano del Popolo e ha vinto più di dieci premi di ricerca scientifica a livello provinciale e ministeriale. Le sue opere hanno ricevuto riconoscimenti come il “Premio per le migliori opere”, il “Premio Flying Apsaras” e il “Premio Golden Eagle”.
ACQUISTA IL VOLUME “IL PERCORSO VERSO UNA CINA MODERATAMENTE PROSPERA”






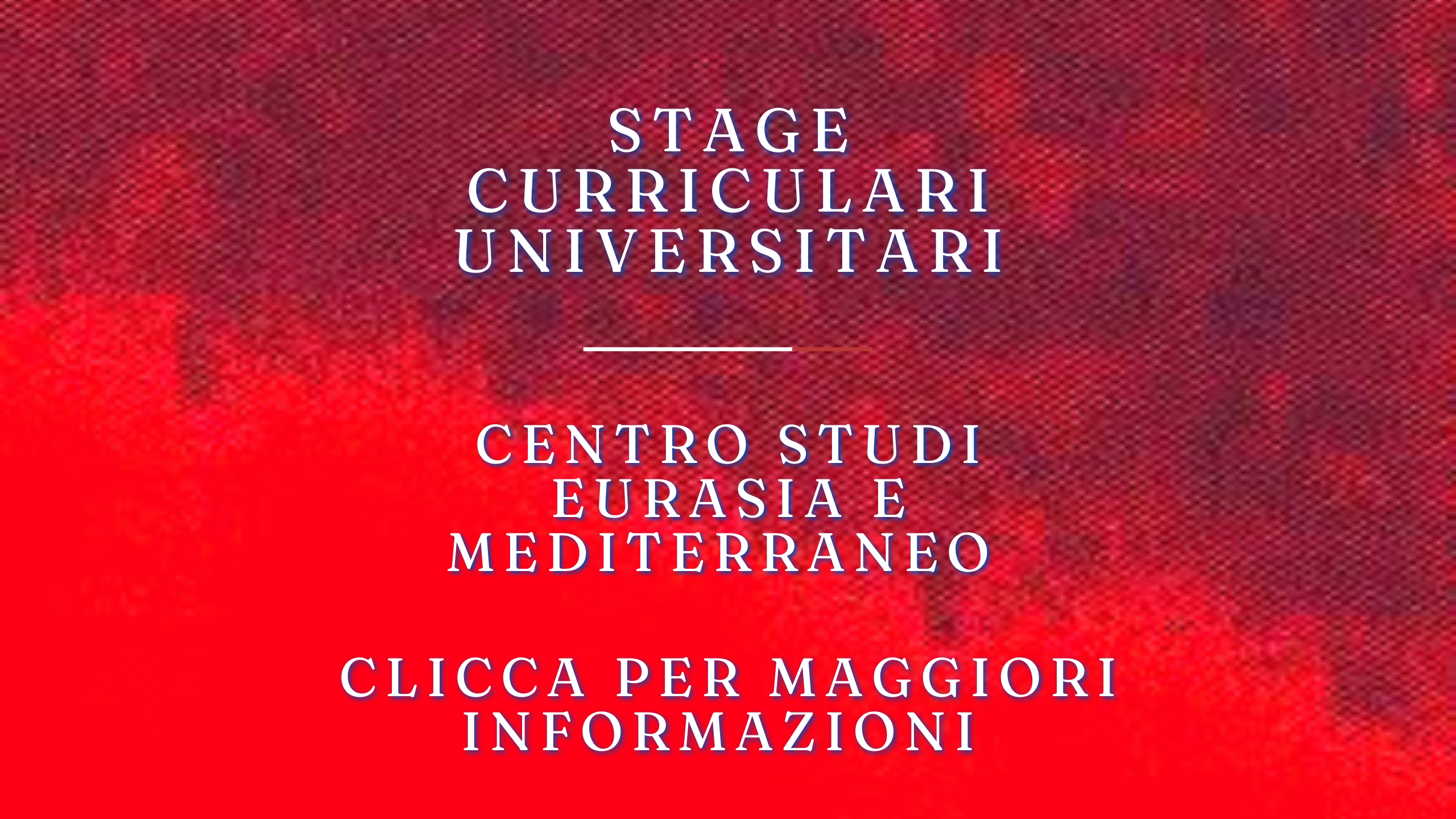

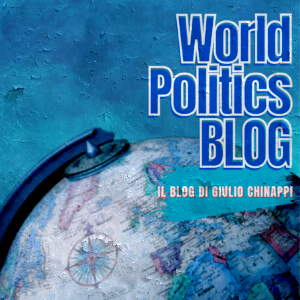
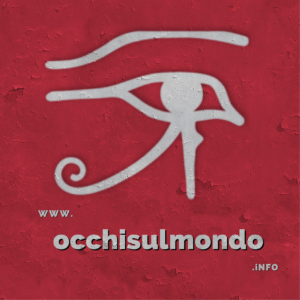









Il CeSE-M sui social