Di Luca Pingitore
11 settembre 2025, ore 20:49 (+5GMT), cosmodromo di Baikonur, Kazakhstan.
Il buio della sera viene squarciato da una fragorosa palla di fuoco che illumina il nostro orizzonte vicino. Veniamo pervasi da una forte non attesa emozione mentre il dardo infuocato si stacca dalla base della piattaforma di lancio e si staglia veloce verso l’universo. Uno strepito costante del gas che brucia accompagna la traiettoria del razzo che sempre più cerca di confondersi con le stelle incastonate nel cielo.
Il silenzio di noi decine di osservatori presenti dura nove minuti. Il tempo che intercorre dal momento esatto della partenza alla comunicazione ufficiale che segnala l’attraversamento dell’atmosfera terrestre da parte del veicolo, la parte più critica del suo lungo tragitto.
Urla di giubilo ed un lungo applauso accompagnano il puntino giallo fuoco andare fuori dalla visuale possibile ad occhio nudo. Il lancio è riuscito.
Dal nostro punto di osservazione situato a poco più di 2 km di distanza dalla base di lancio n. 31 “Vostok” del cosmodromo di Baikonur abbiamo appena assistito alla messa in orbita del veicolo spaziale Progress MS-32.
Una sonda che non prevede la presenza di cosmonauti a bordo trattandosi di una sorta di navicella cargo e per l’occasione caricata con circa tre tonnellate di cibo, carburante e rifornimenti diretti alla Stazione Spaziale Internazionale (ISS).
Il Progress, nelle sue varie versioni aggiornate, è utilizzato per questo tipo di trasporti sin dal 1978 e viene lanciato per mezzo di un razzo di tipo Soyuz. Il modello scagliato questa sera, un Soyuz-U 2.1, dopo due giorni di navigazione attraccherà tramite un sistema di ancoraggio automatico Kours al modulo di servizio Zvezda del segmento russo della ISS.
Questo di Baikonur, inaugurato nel 1957, è stato il primo cosmodromo al mondo.

Da qui il 12 aprile 1961 Yurij Gagarin partì a bordo del Vostok-1 per la sua pioneristica esperienza in orbita nello spazio all’epoca sconosciuto.
Il lancio avvenne dal Gagarin Start, la base di lancio rimasta attiva fino al 2019 e che continua a stagliarsi perentoria verso il cielo.
Un mostro di ferro, una sostanziale impalcatura semovibile dotata di scale ed ascensori collocata sopra una fossa profonda 45 metri larga 100 ed utilizzata per il convoglio del combustibile il quale, bruciando, imprime potenza alla navicella pronta al decollo.
Dal bunker sotterraneo della sala operativa, anche essa non più attiva, i lanci venivano monitorati da una serie di periscopi funzionanti tutt’oggi. La chiavetta di start che dava fuoco ai motori è anche essa ancora lì incorporata tra le varie apparecchiature elettroniche attinenti le operazioni. Diversi giornali di bordo e volumi con calcoli, progetti, annotazioni completano la scena dell’ambiente in cui ci troviamo.
La Roscosmos, l’agenzia governativa che gestisce il programma spaziale russo e detiene sostanzialmente l’amministrazione non solo del cosmodromo ma anche dell’attigua cittadina di Baikonur, concede ad un numero limitato di visitatori, dietro rilascio di un burocratico e costoso permesso, l’opportunità di visitare una parte dell’area.
Come lo sbalorditivo hangar dove sono ancora conservati due esemplari della navicella spaziale denominata Buran. Uno spazioplano che volò in assetto completo una sola volta nel 1988 una volta giunto quasi all’apice del suo programma di progettazione iniziato nei primi anni ‘80. La dissoluzione dell’Unione Sovietica causò il completo abbandono del progetto ed il Buran è rimasto parcheggiato nel proprio immenso e tecnologico capannone dove ancora oggi è possibile essere ammirato dai limitati fortunati visitatori.
I quali restano strabiliati anche al cospetto del lanciatore Energhia, alto circa 60 metri e conservato anch’esso in un maestoso hangar. Come il Buran anche l’Energhia volò un paio di volte a fine anni ‘80 per poi seguirne le stesse sorti e restare chiuso semidimenticato.

Quella dei progetti avveniristici già pronti ma costretti all’abbandono e all’oblio nel campo aeronautico, aereospaziale ed in numerosi altri ambiti è un fatto costante consequenziale alla caduta dell’Urss.
Sulla spiaggia di Arablyar, in Daghestan, ad esempio si trova abbandonato l’ekranoplano Lun, un gigantesco aeromobile capace di volare a pelo d’acqua a velocità estrema.
“Il cosmo inizia dalla terra” è un motto di origine sovietica che campeggia su un muro sgretolato di una costruzione situata nell’area del cosmodromo di Baikonur. E come noto è proprio con la creazione dello spaziodromo che iniziò la cosiddetta “conquista dello spazio”. Da qui furono infatti lanciati in orbita il primo essere vivente, la cagnetta Laika, ed in seguito il primo essere umano Yurij Gagarin. Eroe dell’Unione Sovietica ricordato e festeggiato ovunque nei paesi costituenti l’ex Urss ma solo qui nel cosmodromo è avvertita fortemente la sua presenza. Sono rimasti infatti intatti il cottage n.1 dove egli trascorse la notte prima di salpare verso l’infinito, il gazebo sul quale si svolse la cerimonia ufficiale con la quale venne attestato il suo primato universale (è il caso di dirlo…), il supposto punto al lato della strada dove espletò l’ultima funzione fisiologica prima di esser sbalzato nello spazio.
La costruzione di Baikonur che dalla sua nascita fino al 1995 si è chiamata Leninsk e del vicino cosmodromo iniziò nel 1955. Una distanza di circa sette chilometri separa la città dall’area del cosmodromo, grande più di seimila chilometri quadrati. Squadre di operai lavorarono alacremente ed in segreto. I lavori erano dediti ufficialmente alla costruzione di un aeroporto e di un sito di supporto ad una miniera. In realtà la vera Baikonur, un piccolo villaggio nella steppa, si trovava ad alcune centinaia di km di distanza ma, per mantenere il sito segreto, il governo centrale avallò la confusione tra la nuova Leninsk – Baikonur ed il vero villaggio minerario. La prima pietra posata per la costruzione dell’odierna Baikonur è esposta nelle pertinenze di quello che oggi è il locale Museo del Cosmodromo.
Delimitata nella sua estensione territoriale da una lunga recinzione perimetrale che la separa dal Kazakhstan vero e proprio, la città Baikonur, insieme alla adiacente distesa del cosmodromo, è tecnicamente una exclave russa in affitto dal governo di Astana. Il contratto in essere prevede il pagamento di un canone di 115 milioni di dollari annui fino alla sua scadenza fissata, salvo proroghe, al 2050.
Solo chi ha una motivazione plausibile e connessa con l’ambito aerospaziale o di servizi legati all’area può accedere al centro abitato. Ancor di più difficile è ovviamente entrare nel cosmodromo vero e proprio.
Un posto di frontiera gestito dalla Federazione Russa controlla chi abbia titolo ad entrare in città. Serve un permesso. Ancor più burocratico per i turisti che ne fanno regolare richiesta mesi prima con la speranza che gli venga concesso. Anche se negli ultimi tempi le maglie della burocrazia si sono leggermente attenuate e per mezzo di tour operator autorizzati la procedura leggermente semplificata.
L’amministrazione della cittadina a maggioranza russa presenta diversa particolarità. Il sindaco è espresso congiuntamente da Russia e Kazakhstan. Forze di polizia, uffici pubblici, tribunale, scuole sono a doppia giurisdizione, kazaka e russa. Anche le valute accettate sono due, il rublo ed il tenge.
Qui tutto o quasi rimanda al cosmo. Passeggiando per la città possono essere ammirati numerosi originali e copie di razzi e mezzi spaziali disseminati come monumenti.
Il nuovo museo all’aperto inaugurato meno di due anni fa è esso stesso un enorme parco cittadino. Come lo è anche quello in cui una stele commemorativa ricopre una fossa comune dove sono sepolti coloro che rimasero uccisi durante una esplosione avvenuta nel 1960, agli albori del sito spaziale. Tragedia che restò segreta per decenni e solo da pochi anni resa pubblica. Negli anni ’60 si era in piena guerra fredda ed un incidente con più di settanta morti poteva rappresentare un potente segnale di debolezza per l’avversario.
La maggior parte della popolazione di Baikonur è ovviamente connessa con il vicino cosmodromo ma non mancano i caffè, ristoranti, alberghi dai nomi legati all’ambiente spaziale che sembrano all’apparenza comunque esser rimasti ancorati ad un tempo oramai andato. Lo stesso Lenin immortalato in una statua nella sua classica espressione in movimento verso la Rivoluzione ed il Futuro ti accoglie nella piazza principale, non lontano dallo stadio del “Decennale” e dalla cattedrale ortodossa.
Visitare Baikonur ed il suo cosmodromo è un viaggio nel passato proiettati verso il futuro.




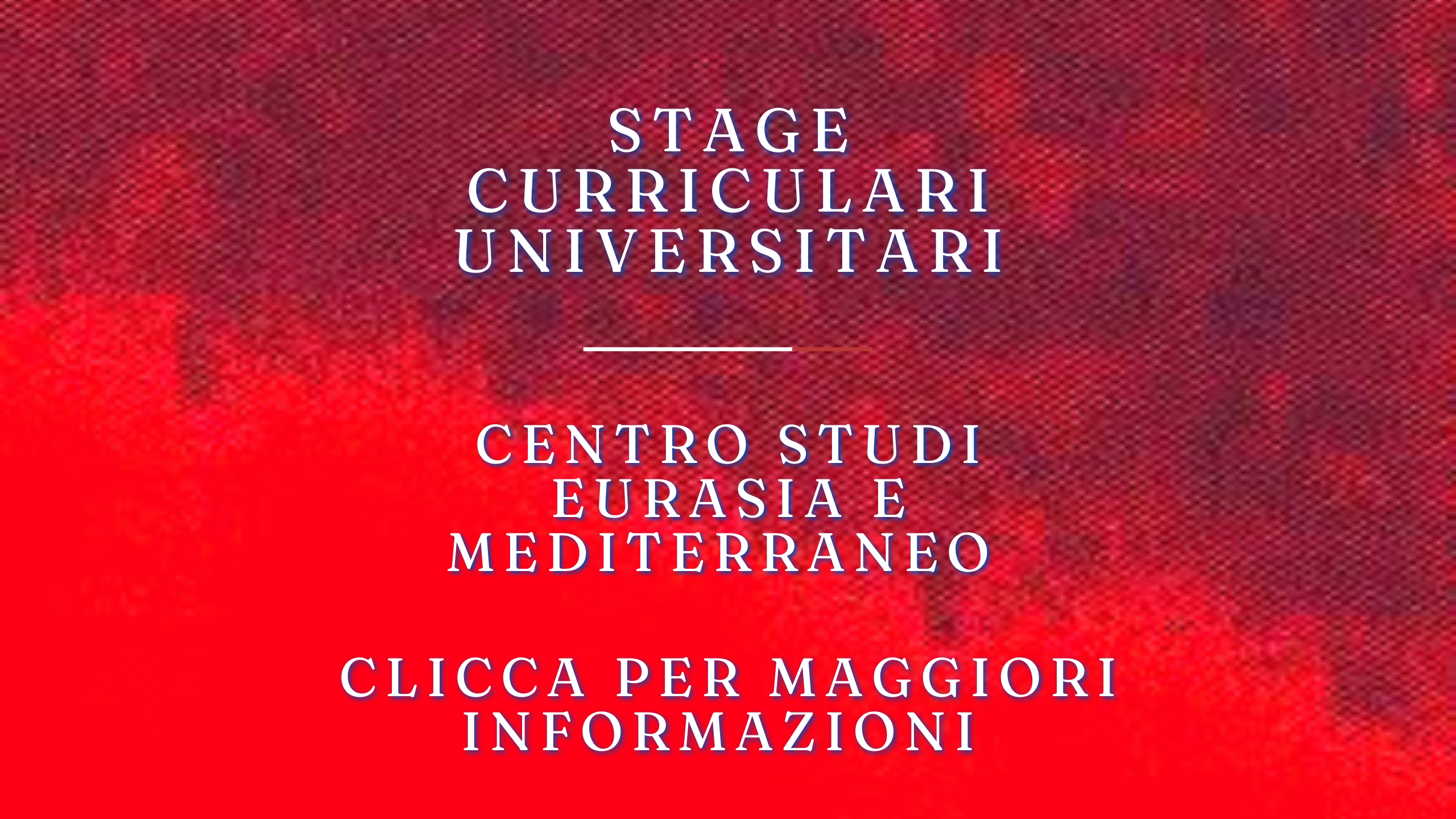

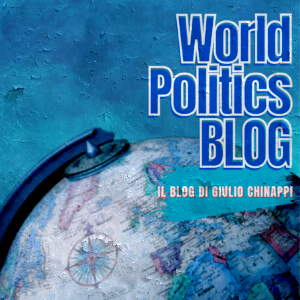
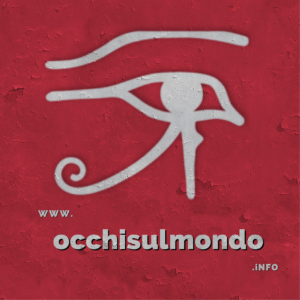









Il CeSE-M sui social