di Rosamaria Galatà
“Tutte le immagini della crudeltà sono arrivate al mondo senza filtri né esagerazioni,
ma il mondo si schiera sempre dalla parte del più forte.Non ci sono parole capaci di esprimere il terrore vissuto da donne, bambini e persone sotto le bombe. Non ci sono parole per raccontare i gemiti dei feriti e dei malati che non trovano nemmeno un antidolorifico.
Non ci sono parole per descrivere la sofferenza di anziani, donne e bambini costretti a lasciare le proprie case per dormire all’aperto.Non bastano le parole per raccontare la fame dei bambini, la frustrazione degli uomini, il terrore delle donne.Come può chi era abituato a vivere in una casa sicura sopportare di stare in una tenda di plastica, sotto il sole cocente o la pioggia?Sono dolori e tragedie che nemmeno i più lunghi articoli potrebbero rendere giustizia.” (rifugiata di Gaza)
Il conflitto tra Israele e Hamas sembra non conoscere tregua. La catastrofe umanitaria in corso a Gaza è sotto gli occhi del mondo: il 90% della popolazione è stata sfollata, priva di acqua, cibo, elettricità e assistenza medica. In questo scenario devastante, emergono le voci delle donne – madri, sorelle, figlie – che raccontano storie di dolore, coraggio e resilienza. Costrette ad abbandonare la propria terra, il proprio passato e spesso anche la propria famiglia, queste donne testimoniano un’esistenza sospesa, segnata dall’esilio, ma ancora attraversata dalla speranza.
Prima della guerra, la vita a Gaza scorreva con semplicità e calore umano. “Era semplice, ma piena di umanità”, raccontano. Samina aggiunge: “Ero felice a Gaza. La nostra vita era semplice, ma bella. L’occupazione ha distrutto i miei sogni in un minuto”. Una madre ricorda: “Conducevamo una vita stabile: mio marito lavorava, i bambini andavano a scuola. Era una vita degna”.
Poi, le bombe. Le scelte obbligate. La fuga. “Quando ho sentito gli scoppi intorno a casa, ho capito che non potevo più restare.” Un’altra donna racconta lo strazio di una scelta disumana: “Restare e vedere mia figlia morire senza cure, o partire lasciando gli altri miei cinque figli”. Non si tratta di scelte, ma di imposizioni. “Sono uscita da Gaza per curarmi. Non riesco ad accettare di aver dovuto fuggire dalla mia terra.”
A quel punto, inizia il viaggio. Un viaggio che non è salvezza, ma ulteriore trauma, paura. Le parole di una donna raccontano il momento della partenza con una lucidità straziante:
“Non ho salutato la mia famiglia, non ho visto mio padre e mia madre, non ho potuto baciargli le mani né riempirmi gli occhi della loro vista. La mia casa è stata bombardata nei primi giorni della guerra. Non c’era tempo per provare sentimenti, né per piangere. Missili e bombardamenti ovunque, colonne di fumo ovunque. Nel momento stesso della partenza Israele ha bombardato il valico da cui dovevamo partire: alcuni dei viaggiatori con noi sono stati feriti dalle schegge. L’unica sensazione era la paura, il grido di tutti e l’aggrapparsi a un filo di salvezza per attraversare il valico verso il lato egiziano.”Alla domanda su quale sia stato il momento più difficile, risponde: “Siamo usciti dal valico, portati da un autobus egiziano fino al centro del Cairo. Lì è stato il momento più difficile: il bus si è fermato e siamo scesi nel mezzo di una grande strada, palazzi alti, luci ovunque, traffico ovunque. Io e la mia famiglia eravamo in mezzo alla strada. In quel momento mi sono sentita orfana, come se mi avessero amputato le braccia, con la schiena spezzata, povera, stanca, confusa, sola, senza alcun potere, se non piangere per tutto.”
La separazione pesa quanto le perdite. “Mi sentivo persa. È stato come lasciare una parte di me”, racconta una rifugiata. Una madre condivide un momento straziante e sacro: “Mia figlia di tre anni piangeva mentre partivo. Poi mi ha detto: ‘Vai mamma, per curare mia sorella’. Era come se Dio parlasse”.
L’allontanamento dalla propria terra impone nuove sfide: adattamento, isolamento. “Mi sento più forte, ma la solitudine pesa”, afferma una donna. Alcune trovano accoglienza: “Quando sono arrivata in Italia, tante persone hanno ascoltato la mia voce”. Ma altre denunciano la situazione a Gaza a causa delle politiche umanitarie: “Ci trattano in base alle calorie, come numeri, senza considerare i bisogni umani”.
Tra le conseguenze meno visibili ma più profonde della guerra c’è la perdita di identità sociale. Per molte donne, l’allontanamento dalla propria terra non è solo uno sradicamento geografico, ma una cancellazione della loro storia pubblica, del loro ruolo nella comunità, della loro dignità costruita in anni di vita. Una testimonianza ci mostra questa frattura con intensità dolorosa:
“Nel mio Paese facevo parte di una famiglia rispettata e conosciuta. Una ragazza di nobili origini. Tutti sapevano chi ero io, chi era mio marito, i miei figli, la mia famiglia. Potevo avere ciò che volevo quando volevo. Quanto mi brucia la parola ‘rifugiata’. Soprattutto per i miei figli: dopo anni di fatica per renderli un esempio per i giovani, all’apice del successo e conosciuti per la loro buona educazione, ora sono rifugiati. Dio è sufficiente per noi. Vivevamo ad alti livelli in ogni senso. La mia casa era un rifugio per chi aveva bisogno, un conforto per chi era triste, un luogo di ospitalità per l’ospite, di calore per i familiari. Ora siamo rifugiati. Ringrazio Dio, ma abbiamo perso tutto. Non ci resta che rialzarci e sfidare le difficoltà della vita.”
La parola “rifugiata” diventa così il simbolo di una rottura esistenziale. Dietro quella definizione apparentemente neutra, si nasconde una perdita identitaria profonda, che coinvolge l’immagine di sé, la percezione pubblica e la memoria di ciò che si è stati.
A unire tutte queste esperienze è una paura profonda e condivisa: “Temo per la mia famiglia. Temo che questo genocidio continui”. Ma a questa si affianca la speranza. “Le donne di Gaza sono forti. Se avranno l’opportunità, faranno la differenza”. La fede, la memoria, la solidarietà e la famiglia diventano radici nel disorientamento dell’esilio. “La voce della verità è più forte della menzogna”. “Al momento, tutte le donne senza eccezione viviamo sentimenti di oppressione, abbandono e privazione. Molte di noi hanno perso mariti, figli, padri. Non c’è casa senza un’orfana, una vedova, una madre in lutto. Anche se la guerra finisse, chi restituirà alle donne il padre, il fratello, il marito, i figli? Le conseguenze negative di questa guerra ci accompagneranno per decenni.”
E una donna conclude:
“Siamo state, siamo e saremo sempre noi, donne palestinesi, simbolo di resistenza e generosità. Vorrei consigliare a tutti voi che vivete una vita normale, ma non sapete cosa possa riservarvi il futuro: godetevi i momenti con la vostra famiglia e i vostri amici, osservate bene i volti delle persone care, scattate tante foto con chi amate e ovunque. Godetevi la vita, per quanto semplice sia. Siate soddisfatti di ciò che Dio vi ha dato, anche se è poco. Fate tanto bene, aiutate gli altri, diffondete l’amore, amatevi, partecipate alle gioie degli altri, sorvolate sugli errori, perdonate.”
Le voci delle donne di Gaza raccolte in questo articolo non sono soltanto frammenti di dolore personale, ma veri e propri documenti politici. In un conflitto dove si tende a ridurre le persone a numeri, a danni collaterali, o a pedine strategiche, le parole di queste donne ci restituiscono un elemento essenziale: l’umanità. Attraverso le loro storie, emerge la dimensione intima e relazionale della guerra, quella che colpisce il corpo femminile, la maternità, la famiglia e il senso stesso di appartenenza a un luogo e a una comunità.
Queste testimonianze mostrano come le donne non siano solo vittime passive del conflitto, ma agenti di resilienza e resistenza. Nonostante lo sradicamento, la separazione e la perdita, esse continuano a esercitare una funzione sociale, simbolica e persino diplomatica: raccontando, trasmettendo, spiegando, testimoniano ciò che la narrazione ufficiale tende a omettere. In tal senso, la loro voce diventa uno strumento capace di rendere visibili le dimensioni umane e invisibili della guerra.
Infine, queste storie pongono interrogativi urgenti: qual è il ruolo del genere nei conflitti contemporanei? Come si può articolare una risposta politica e umanitaria che tenga conto delle specificità dell’esperienza femminile nei contesti di guerra e di esilio? E ancora: chi ha il potere di raccontare, e cosa significa davvero “dare voce” in un contesto di occupazione e disumanizzazione?




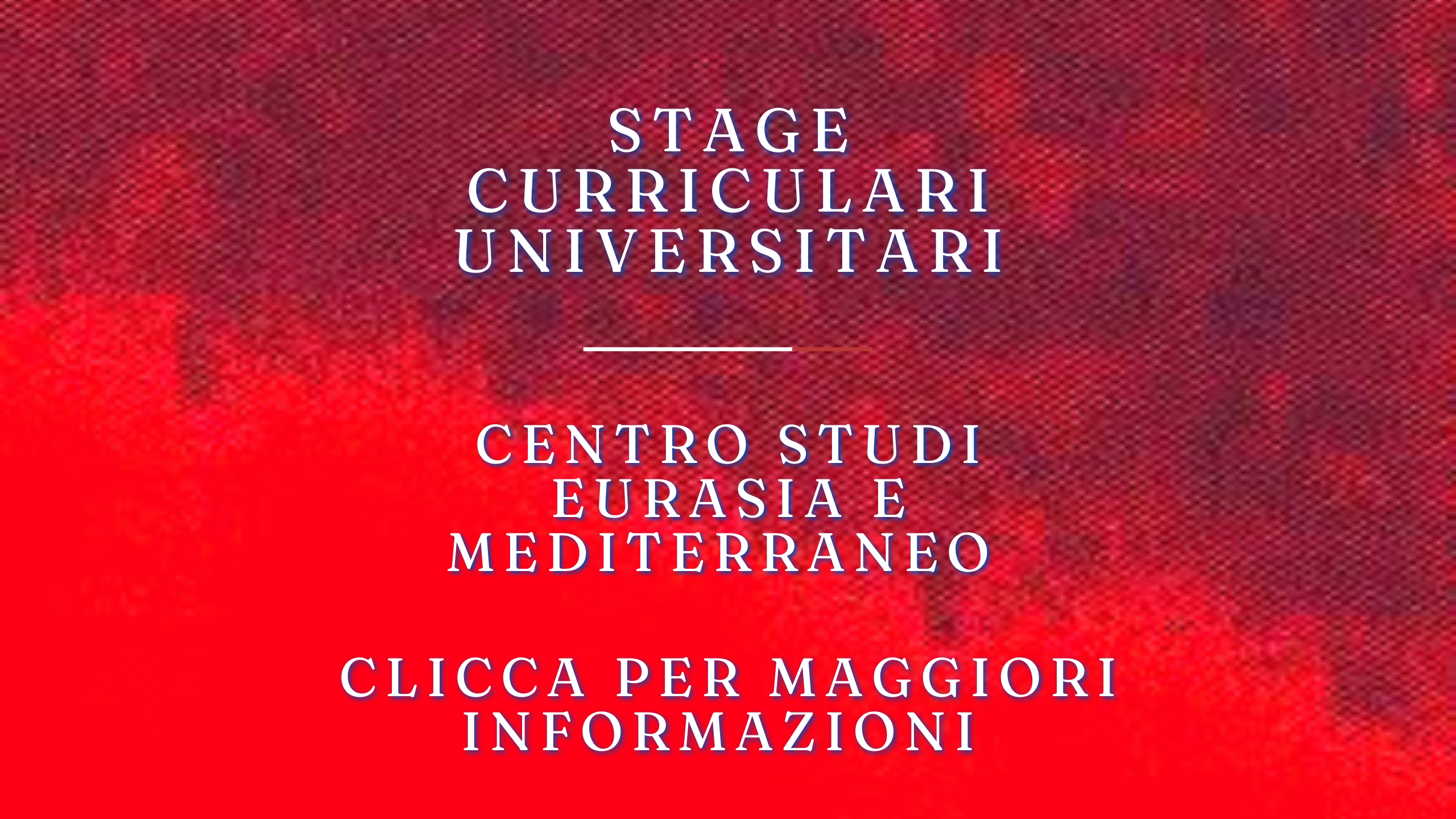

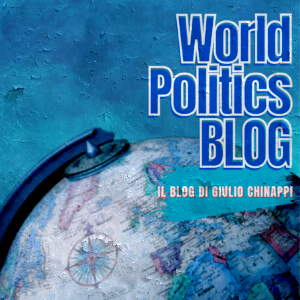
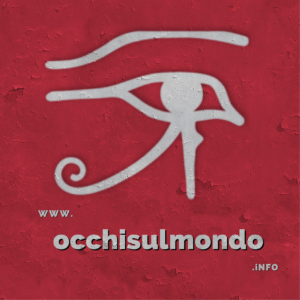





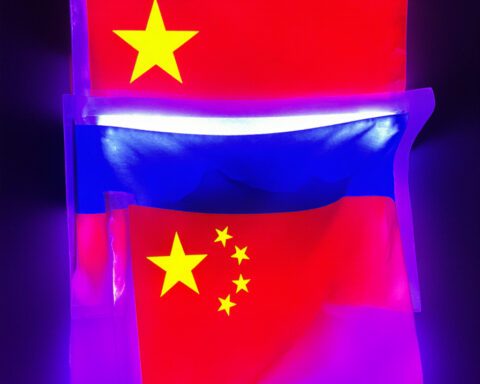



Il CeSE-M sui social