di Rosamaria Galatà
Le dinamiche culturali, politiche e storiche hanno portato dei cambiamenti alla società. Le donne, nel corso del tempo, hanno sempre cercato di affermare la propria indipendenza, mentre gli uomini hanno posto al centro della loro esistenza due elementi fondamentali: la guerra e l’affermazione della propria virilità.
Nonostante spesso si siano trovate a vivere ai margini della società, le donne hanno assunto un ruolo centrale, sia come leader attive dei cambiamenti, sia come vittime. Basti pensare alla guerra.
Tutto quello che conosciamo sulla guerra deriva da voci di ‘uomini’: soldati, militari, strategie, missioni ecc.. Prestando attenzione, gli stessi termini adottati sono ‘parole maschili’.
Ma cosa succederebbe se a parlare fossero le donne? E’ proprio questo che Svetlana Aleksievič cerca di mostrare in La guerra non ha un volto di donna, in cui ha deciso di raccontare un altro tipo di guerra, una guerra sconosciuta: la guerra femminile.
“I racconti femminili sono altri e parlano d’altro. La guerra al femminile ha i propri colori, odori, una sua interpretazione dei fatti ed estensione dei sentimenti. E anche parole sue. Dove non ci sono eroi, ma persone reali”.[1]
L’autrice cerca di darsi una risposta sul perché le donne abbiano taciuto a lungo sulla loro esperienza al fronte. Forse “le donne non hanno saputo far valere con altrettanta forza la propria storia? Le proprie parole e i propri sentimenti?”[2] E alla fine Svetlana Aleksievič giunge alla conclusione che “ non ci hanno creduto nemmeno loro, non abbastanza per poterci riuscire, tenendoci nascosto così tutto un mondo. La loro guerra è rimasta sconosciuta.”[3]
Quello che il libro vuole mostrare, a differenza di quanto si è soliti pensare, è il ruolo attivo che le donne hanno rivestito nei conflitti: “istruttrici sanitarie, tiratrici scelte oppure nei fucilieri mitragliatori, a capo di una batteria antiaerea o nel genio”.[4]
Attraverso un mosaico di testimonianze dirette, l’autrice ricostruisce la sofferenza, le difficoltà, il coraggio e la paura, provati da numerose giovani donne, che, come gli uomini, si sono impegnate in prima persona per la sicurezza e la difesa del loro Paese.
Marija Ivanova Morozova, caporale e tiratrice scelta racconta del suo arrivo al fronte:
“Ci hanno insegnato a sparare con il fucile d’assalto e a lanciare bombe a mano. All’inizio, lo ammetto avevo paura a prendere il fucile in mano, mi sentivo a disagio. Non riuscivo a immaginarmi mentre ammazzavo qualcuno…Abbiamo iniziato a montare e smontare il nostro fucile di precisione con gli occhi chiusi, stimare la velocità del vento, gli spostamenti dei possibili bersagli; a scavare le buche per appostarci, a strisciare ventre a terra incollate al suolo – tutte cose che presto siamo state in grado di fare”.[5]
Un’ex partigiana, invece, racconta di quando lei e il suo gruppo, composto da altri due ragazzi adolescenti, erano andati in esplorazione e avevano preso in ostaggio quattro soldati tedeschi:
“Erano capitati in una zona accerchiata e chiaramente non sarebbero riusciti a uscirne con l’impaccio dei prigionieri e lei aveva deciso di liberarsene uccidendoli. I ragazzi non ce l’avrebbero fatta ad ammazzarli…Lei se n’è subito resa conto. Dunque avrebbe dovuto farlo lei. E mi ha raccontato di come li ha ammazzati.”[6]
Ciò che si può intuire da queste testimonianze è quindi la battaglia interiore delle donne, la necessità di dover andare contro natura:
“La guerra femminile è più atroce di quella maschile. Gli uomini si arroccano dietro la storia, i fatti, si lasciano trascinare dall’azione e dalla contrapposizione delle idee e degli interessi contrastanti che muovono la guerra, mentre a dominare le donne sono sensi e sentimenti. E ancora: l’uomo viene cresciuto fin dall’infanzia nell’idea che forse un giorno gli toccherà sparare. Non così le donne. Non possono sopportare e accettare l’idea di poter morire. E ancora meno quella di dover uccidere. Perché la donna è colei che dà la vita. La dona. La custodisce a lungo dentro se stessa, la culla e l’accudisce. Ho capito che per le donne uccidere è più difficile.”[7]
Anche nei conflitti contemporanei, le donne hanno avuto un ruolo importante, si pensi al Medio Oriente. Fino al 1976 “donne con armi non se ne vedevano”[8].
In guerra le donne non hanno soltanto impugnato armi e ucciso, ma spesso hanno sacrificato la propria vita per proteggere e salvarne delle altre, come la storia di Tonja Bobkova:
“Ha fatto da scudo con il proprio corpo all’uomo che amava, quando era esplosa una mina.”[9]
O, come nel caso della bella attrice Sura Kiseleva, che ha preferito la morte piuttosto che abbandonare altre vite umane:
“E’ morta bruciata. Aveva nascosto dei feriti gravi da trasportare altrove dentro dei pagliai e quando sono iniziate delle sparatorie la paglia ha preso fuoco. Sura si sarebbe potuta salvare, ma solo abbandonando i feriti. E così è bruciata insieme a loro”.[10]
Questo non è qualcosa che riguarda solo il passato, oggi questa guerra torna ad avere un volto. La guerra combattuta in Ucraina vede in prima linea, per la difesa della patria, non solo uomini, ma anche donne:
“Roksovana ha 45 anni e non ha figli. Perché mi sono arruolata? Perché, dice, è il mio dovere civico e non voglio ritrovarmi a vivere in Russia. Dopo l’annessione della Crimea da parte della Russia Roksovana si è dimessa dal suo incarico di economista presso la Camera di commercio locale ed ha prestato servizio presso l’esercito per un anno come volontaria. Ora è al fronte da sei mesi e passa la maggior parte del suo tempo in una baracca scura e sporca, che divide con i commilitoni”.[11]
Anastasia Lenna, ex Miss Ucraina, ha abbandonato la passerella e “ha imbracciato un fucile finto esortando tutti a combattere in Ucraina”.[12]
Viktoria Apanasenko, candidata a rappresentare l’Ucraina a Miss Universo fa la volontaria, si occupa di “cucinare e servire cibo a bambinona anziani, famiglie sfollate e persone in difficoltà, oltre che per preparare le razioni per le truppe ucraine.”[13]
Olexabdra lavorava in una panetteria, ora fa la cecchino:
“Vedo il mio nemico, vedo l’occupante che è venuto nella nostra terra per distruggere il nostro Stato, il nostro popolo, niente di più” e attraverso le parole che pronuncia in un’intervista all’Euronews si evince come sussistano dei ‘pregiudizi’ legati al genere femminile sul campo di battaglia:
“Ogni donna nell’esercito deve dimostrare di essere degna di essere nella posizione di combattimento e di combattere alla pari di un uomo”.
Anche Elena, da impiegata a soldatessa in trincea con la fanteria, premiata per il suo coraggio dal presidente Zelensky:
“Mi hanno detto: vuoi davvero una posizione di combattimento? E’ difficile. E non tutti i comandanti accettano le ragazze in posizione di combattimento. Non importa quanto sia difficile, so per certo che posso farcela!”
Il documentario “Divided Ukraine: What Language Do You Express Love In?” offre una chiara e interessante testimonianza di quanto detto finora. Nonostante il docufilm non si focalizzi sulla questione di genere nello specifico, mostra come la guerra abbia modificato la vita di uomini, donne e bambini che vivono nell’area del Donetsk.
E’ possibile intravedere come le donne siano state protagoniste invisibili e le interviste raccolte nel documentario lo dimostrano. Donne combattenti nelle truppe d’assalto, donne cecchino, donne che lavorano nelle fabbriche di armamenti o alimentari, donne infermiere, donne medico, donne ballerine di teatro che hanno continuato a lavorare per cercare di lenire e alleviare le sofferenze causate dalla situazione attraverso l’arte.
Come disse Papa Francesco: “Quanto amore c’è negli occhi delle donne che mentre piangono sanno infondere motivi per sperare! Il loro sguardo è consapevole, senza illusioni, eppure al di là del dolore e dei problemi offre una prospettiva più ampia, quella della cura, dell’amore che rigenera speranza”. A tal proposito una donna in questo documentario dice “ Sono stata volontaria al fronte. Ho fatto un corso per stress-post-traumatico. Volevo creare un posto per aiutare i soldati che rientravano dal fronte di guerra. Per un certo periodo di tempo avevo pensato di aprire un centro di riabilitazione per veterani di guerra e mi ero anche impegnata a cercare uno spazio”.
Ma la guerra non si combatte solo con le armi. La vera battaglia è la sopravvivenza, che porta numerose donne a restare e combattere per i propri diritti e la propria libertà, mentre altre decidono di fuggire insieme ai propri figli nella speranza di una vita e un futuro migliore. Diventano così migranti, rifugiate, profughe.
Una donna bahà’ì spiega che il motivo che l’ha spinta ad andarsene dall’Iran, o come la donna preferisce chiamarlo, Persia, è stato “il cambiamento di regime politico. Il nuovo regime era integralista, dittatoriale, senza la minima libertà. La Persia prima della rivoluzione, era un paese moderno. Le donne potevano uscire vestite in maniera normale come in Occidente, chi voleva poteva praticare il suo credo religioso; poi il cambiamento di regime, la musica, i balli le feste, il divertirsi, la libertà divennero proibiti”.[14] “Io non volevo indossare il velo, volevo essere libera, così me ne sono andata”.[15]
Come accennato ad inizio trattazione spesso anche le dinamiche culturali provocano mutamenti alla società, ne è lun esempio la storia di una ragazza che, a seguito di uno stupro organizzato dal padre per un matrimonio forzato, ha deciso di abbandonare il Libano.
“Nel Libano generalmente le donne non godono delle stesse opportunità degli uomini; sono le stesse famiglie, tranne alcune eccezioni, a non considerare utile che le figlie femmine proseguano negli studi e, a non concedere loro la stessa libertà di movimento e di scelta che hanno i figli maschi”.[16] Questo è frutto “di una mentalità secondo la quale la donna è (forse è ancora) considerata un oggetto, che passa dalla tutela paterna a quella di un marito senza nessun potere decisionale”.[17]
Molte migrazioni, sono poi legate ai processi di modernizzazione della società, come nel caso della società africana. Una donna proveniente dal Ciad, ha raccontato le difficoltà affrontate dalle donne a africane a causa di emigrazione, colonialismo e discriminazione economica.
Nella società tradizionale africana i ruoli tra uomo-donna erano complementari “l’uomo si occupava dei terreni, dei lavori considerati più pesanti, come l’abbattimento degli alberi; le donne, invece avevano un ruolo fondamentale nel settore agricolo, si occupavano dell’ attività di semina, coltivazione e raccolta.”[18] La narratrice intende precisare come la donna in Africa non debba essere vista come “asservita e umiliata, o come una bestia da soma: nella società tradizionale non era così. Essa non era inferiore all’uomo, ma l’esatta metà”[19], sono state questioni religiose e di potere, quali islam e colonialismo a modificare la condizione femminile, costringendole a dover abbandonare la propria terra.
Dall’Europa all’Iran, dal Ciad al Libano, le donne continuano a far sentire la loro voce, a combattere, a sacrificarsi, a sfidare i cambiamenti sociali e politici. In un mondo che ancora fatica a riconoscere il loro ruolo e il loro valore, queste storie ci ricordano che il vero coraggio non è solo impugnare un’arma, ma anche scegliere di resistere, di raccontare e di non essere più invisibili.
NOTE AL TESTO
[1] Svetlana Aleksievič, La guerra non ha un volto di donna, Bompiani, 2015, p.11
[2] Ivi, p.12
[3] Ibidem
[4] Ibidem
[5] Svetlana Aleksievič, La guerra non ha un volto di donna, Bompiani, 2015, pp.39-41
[6] Ivi, p.24
[7] Ivi, pp.18-19
[8] Cfr. TOSI, Le Guerre delle Donne in Medio Oriente, 2016 disponibile su: https://www.limesonline.com/rubrica/le- guerre-delle-donne-in-medio-oriente
[9] Svetlana Aleksievič, La guerra non ha un volto di donna, Bompiani, 2015, p.112
[10] Ivi, p.112.
[11] https//www.eurozine.com/ucraina-le-donne-in-guerra/
[12] La Repubblica
[13] Vanity Fair
[14] Ornella Urpis, Le tante vite. Racconti di migrazioni nel tempo, Edizioni Università di Trieste, Trieste 2023, pp.175-176
[15] Ibidem
[16] Ivi, p. 79
[17] Ivi, p.80
[18]Ornella Urpis, Le tante vite. Racconti di migrazioni nel tempo, Edizioni Università di Trieste, Trieste 2023, p.93
[19] Ivi, p. 94




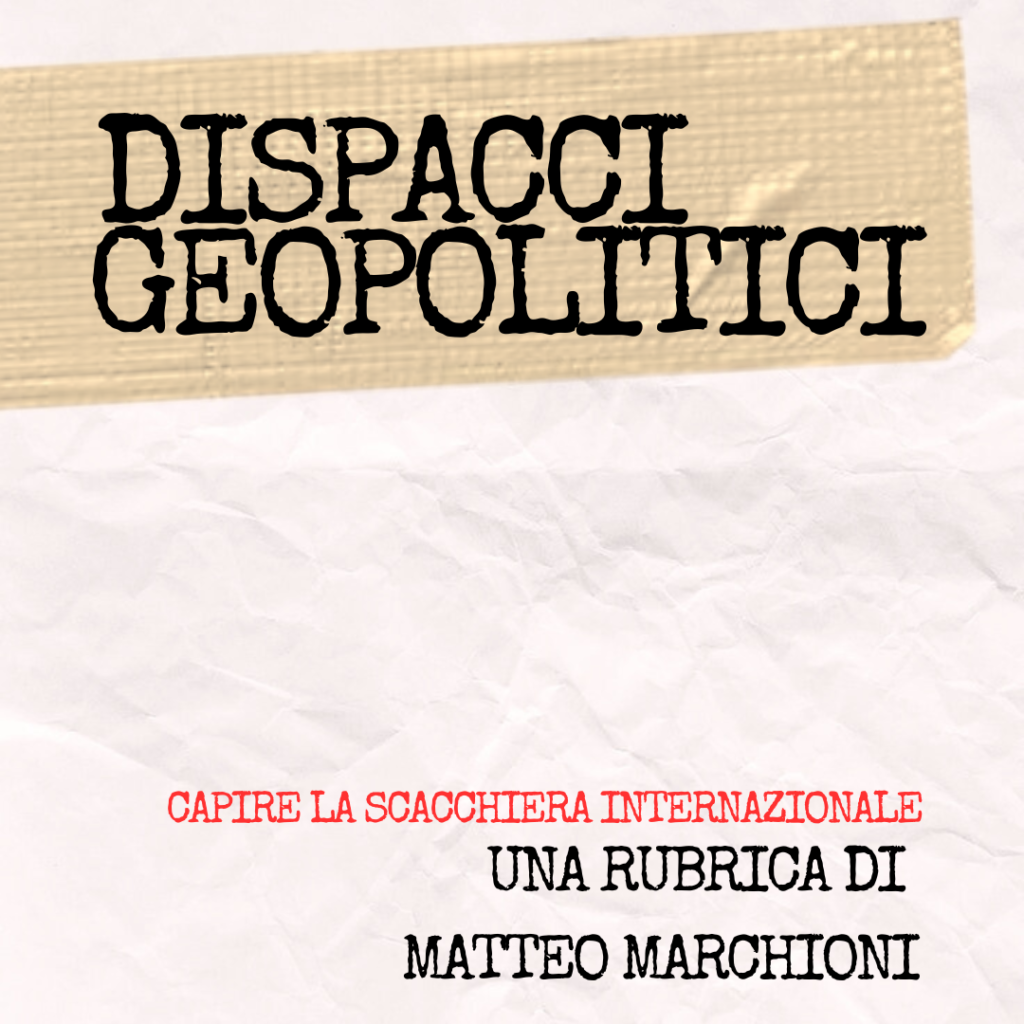
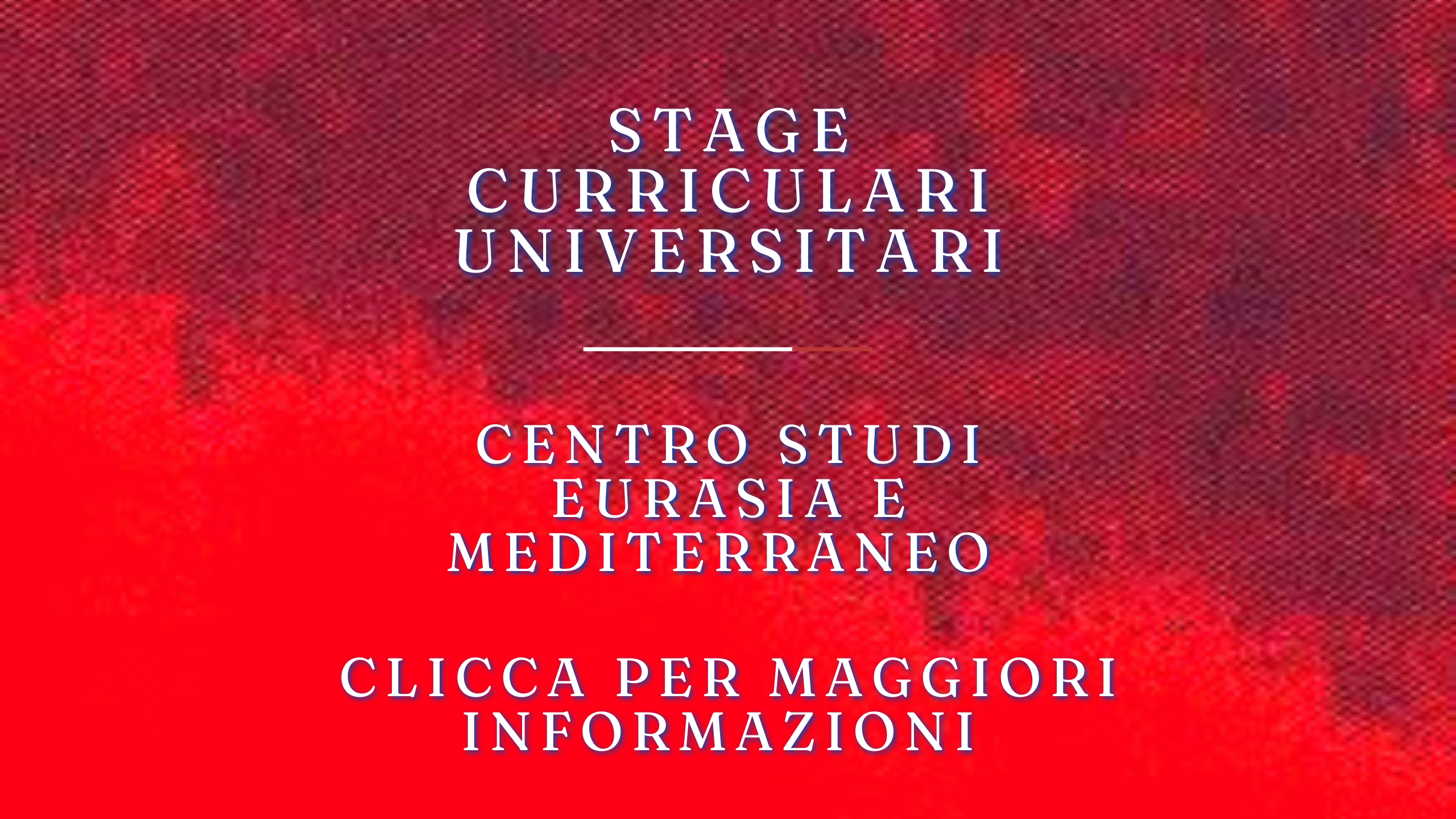

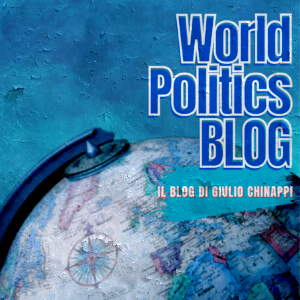
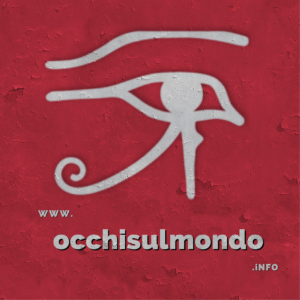









Il CeSE-M sui social