di Alessandro Marini
L’Unione Europea ha imposto sanzioni in risposta alle violazioni e agli abusi dei diritti umani in Russia nell’ambito di due regimi di sanzioni: il regime globale in materia di diritti umani e il regime di sanzioni specifico per paese, adottato il 27 maggio 2024.
Le misure restrittive hanno per oggetto i responsabili di gravi violazioni o abusi dei diritti umani, della repressione della società civile e dell’opposizione democratica e di azioni che compromettono la democrazia e lo Stato di diritto in Russia. Consistono nel divieto di viaggio nei confronti di persone, nel congelamento di beni nei confronti di persone e entità e nel divieto di mettere fondi e risorse economiche a disposizione dei soggetti inseriti in elenco. Il regime specifico per il paese, adottato nel maggio del 2024, consente all’UE di colpire anche coloro che forniscono sostegno finanziario, tecnico o materiale per violazioni o sono associati a persone ed entità che commettono tali violazioni. Questo regime introduce inoltre restrizioni commerciali per l’esportazione di materiale che potrebbe essere utilizzato a fini di repressione interna, nonché per il materiale, le tecnologie e i software destinati principalmente a essere usati per la sicurezza delle informazioni e per il controllo o l’intercettazione delle telecomunicazioni.
Dal marzo 2014 l’UE ha imposto gradualmente misure restrittive nei confronti della Russia in risposta: all’annessione illegale della Crimea del 2014, all’invasione su vasta scala dell’Ucraina e all’annessione illegale delle regioni ucraine di Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia e Kherson. Finora sono stati adottati 16 pacchetti di sanzioni. Le misure sono concepite per conseguire l’obbiettivo strategico dell’UE di porre fine alla guerra di aggressione della Russia contro l’Ucraina massimizzando la pressione sulla Russia e ricorrendo a tutti gli strumenti disponibili per ridurre la sua capacità di portare avanti la guerra. Le sanzioni dell’UE sono attentamente mirate e concepite per essere proporzionate e di carattere temporaneo. Ciò significa che sono riesaminate periodicamente e che l’UE può calibrarle, allentarle o porvi fine se si raggiungono gli obbiettivi prefissati dall’Unione oppure se si compiono passi significativi verso il loro conseguimento. L’UE inoltre ha adottato sanzioni nei confronti di Bielorussia, Iran e Corea del Nord in risposta al loro sostegno alla Russia. Le misure restrittive dell’UE relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina si applicano in totale circa a 2400 persone ed entità. Tra le figure più importanti sanzionate ricordiamo Vladimir Putin, Sergey Lavrov, Roman Abramovich, vari ministri, governatori e politici locali oltre ai membri della Duma di Stato russa, ai membri del Consiglio di sicurezza nazionale o alti funzionari e militari. Nell’elenco di entità sanzionate compaiono anche persone responsabili di alcuni atti come i cosiddetti referendum del 2022 e le cosiddette elezioni del 2023 nei territori ucraini, come le atrocità commesse a Mariupol e a Bucha, come gli attacchi missilistici contro civili e infrastrutture critiche, le deportazioni e adozioni forzate di minori ucraini, la rieducazione militare di bambini ucraini, il reclutamento di mercenari siriani per combattere in Ucraina, la fabbricazione e la fornitura di droni. Le misure restrittive comprendono sia il divieto di viaggio quindi le persone designate non possono entrare o transitare nei territori dell’UE, sia il congelamento dei beni e l’indisponibilità di fondi. Con l’adozione del terzo pacchetto di sanzioni nei confronti della Russia il 28 febbraio 2022, sono stati bloccati circa 210 miliardi di euro di beni della Banca centrale di Russia nell’UE. Nel maggio del 2024 il Consiglio ha adattato il quadro giuridico per garantire la possibilità che le entrate straordinarie generate dai beni russi della Banca centrale di Russia bloccati nell’Ue siano utilizzati a sostegno dell’Ucraina. Nel luglio 2024 l’Ue ha ricevuto il primo pagamento pari a 1,5 miliardi di euro, destinato per il 90% allo strumento europeo per la pace e per il 10% allo strumento per l’Ucraina. Nella primavera del 2025 si prevede che venga messo a disposizione un ulteriore importo pari a circa 2 miliardi di euro.
Nel 2014 l’Ue ha imposto sanzioni economiche riguardanti gli scambi con la Russia in settori economici specifici, in risposta all’annessione illegale della Crimea, in seguito nel marzo del 2015 i leader dell’UE hanno deciso di vincolare l’attuale regime di sanzioni alla piena attuazione degli accordi di Minsk, che avrebbe dovuto realizzarsi alla fine del dicembre del 2015. Visto che ciò non è avvenuto il Consiglio ha prorogato le sanzioni economiche fino al luglio 2016. Da quel periodo in poi le sanzioni economiche sono state prorogate di volta in volta per ulteriori periodi di sei mesi, attualmente sono prorogate fino al 31 luglio 2025. Ovviamente a seguito dell’invasione dell’Ucraina da parte della Russia nel 2022, l’Ue ha intensificato le misure nell’ambito di questo regime di sanzioni. Queste riguardano i settori finanziario, commerciale, energetico, dei trasporti, della tecnologia e della difesa della Russia, nonché i servizi forniti alla Russia o a cittadini russi. Riguardo la finanza, in questo settore le sanzioni comprendono restrizioni all’accesso della Russia ai mercati finanziari e dei capitali dell’UE e comprendono anche divieti riguardanti la fornitura di servizi di messaggistica finanziari specializzati a 23 banche russe, l’uso del sistema di trasmissione dei messaggi finanziari, operazioni con la Banca centrale russa e la Banca di sviluppo regionale russa e molte altre. Riguardo l’energia, le sanzioni comprendono un tetto sui prezzi relativo al trasporto marittimo del petrolio e dei prodotti petroliferi russi e divieti riguardanti importazioni dalla Russia di petrolio greggio, prodotti petroliferi e carbone, importazioni dalla Russia di gas di petrolio liquefatto, riesportazioni di gas naturale liquefatto russo negli impianti dell’Ue ed esportazioni verso la Russia di beni e tecnologie per l’industria dell’energia. Per i trasporti le sanzioni hanno riguardato la chiusura dello spazio aereo dell’Ue a tutti gli aeromobili di proprietà russa e dei porti dell’Ue alle navi russe e divieti riguardanti le esportazioni verso la Russia di beni e tecnologia nei settori aeronautico, marittimo e spaziale, esportazioni verso la Russia di tutti gli aeromobili, trasportatori su strada russi che trasportano merci nell’UE, la prestazione di servizi di riparazione, manutenzione e finanziari connessi ai trasporti. Riguardo la difesa e la tecnologia sono comprese restrizioni alle esportazioni per una serie di entità che sostengono direttamente il complesso militare e industriale russo, molte delle quali situate in paesi terzi e un divieto di esportazioni verso la Russia di beni e tecnologie a duplice uso per scopi militari, motori per droni, armi e armi da fuoco a uso civile, munizioni, veicoli militari e equipaggiamenti paramilitari, prodotti chimici, apparecchi fotografici e altri beni che potrebbero rafforzare i settori della difesa e della sicurezza della Russia. Le sanzioni nel settore commerciale comprendono il divieto di esportare verso la Russia beni di lusso, contingenti per le importazioni di cloruro di potassio e divieto di importare dalla Russia diversi materiali come acciaio, ferro, ghisa, cemento, legno, carta, diamanti, oro e altri beni che potrebbero rafforzare la capacità industriale della Russia.
Riguardo a misure concernenti cooperazione economica, nel 2014 la Banca Europea per la ricostruzione e lo sviluppo ha deciso che la Russia non sarebbe più stata un paese beneficiario e ha interrotto l’approvazione degli investimenti nel paese. Nello stesso anno la Banca europea per gli investimenti ha sospeso la firma di nuove operazioni di finanziamento in Russia. Sono stati riesaminati e sospesi programmi di cooperazione bilaterale e regionale dell’UE con la Russia. Inoltre, insieme ad altri membri dell’organizzazione mondiale del commercio, l’Ue ha convenuto di negare il trattamento della nazione più favorita ai prodotti e ai servizi russi sui propri mercati.
Altra operazione svolta dall’Unione Europea è stata quella di sospendere le trasmissioni e le licenze di vari organi di disinformazione sostenuti dal Cremlino. Tali emittenti sempre secondo l’UE sono state utilizzate dal governo russo come strumenti per manipolare le informazioni e promuovere la disinformazione sull’aggressione militare nei confronti dell’Ucraina, compresa la propaganda al fine di destabilizzare i paesi confinanti con la Russia ma anche la stessa UE e i suoi membri.
L’Unione Europea è arrivata alla conclusione che la Russia tenta costantemente di interferire con i processi democratici della stessa e tenta di minarne le fondamenta democratiche anche attraverso campagne di influenza e promozione di disinformazione. Perciò l’Ue ha deciso che i partiti politici e le fondazioni politiche, le organizzazioni non governative, i gruppi di riflessione e i fornitori di servizi di media nell’UE non saranno più autorizzati ad accettare finanziamenti provenienti dallo Stato Russo e dai suoi mandatari.
Altro punto importante riguarda il fatto che nel 2014 il vertice UE-Russia è stato annullato e gli stati membri dell’UE hanno deciso di non tenere più vertici bilaterali regolari con la Russia infatti da quel momento in poi non si è più tenuto il G8 ma è si è sempre svolto il G7. I paesi dell’Ue hanno inoltre appoggiato la sospensione di negoziati relativi all’adesione della Russia all’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico e all’Agenzia Internazionale per l’energia. Nel febbraio 2022 l’UE ha deciso che i diplomatici e altri funzionari e imprenditori russi non possono più beneficiare delle disposizioni sulla facilitazione del rilascio dei visti, che consentono un accesso privilegiato all’Ue. Nel settembre del 2022 il Consiglio ha adottato una decisone che sospende totalmente l’accordo di facilitazione del rilascio dei visti tra UE e Russia. L’8 dicembre 2022 il Consiglio ha adottato una decisione relativa alla non accettazione dei documenti di viaggio russi rilasciati in Ucraina e Georgia. Tale decisione è stata adottata per rispondere alla prassi russa di rilasciare passaporti internazionali russi ai residenti delle regioni occupate. Ha fatto seguito alla decisione unilaterale della Russia di riconoscere l’indipendenza dei territori georgiani dell’Abkhazia e dell’Ossezia meridionale nel 2008. I documenti di viaggio russi rilasciati nelle regioni dell’Ucraina occupate da Mosca o nei territori separatisti della Georgia non sono accettati come documenti di viaggio validi ai fini di un visto o dell’attraversamento delle frontiere dello spazio Schengen.
Settore Energetico
Germania
Gas russo: da 55% (2021) a meno del 10% (2023)
Prezzo elettricità +40% medio nel 2022
Investimenti pubblici: 200 miliardi € per contenere crisi
Italia
Import gas russo: da 40% (2021) a 15% (2023)
Bollette aumentate del 70% per le imprese nel 2022
Nuovi accordi con Algeria (36% del gas nel 2023)
Industria e Produzione
Germania
Produzione industriale -1,8% nel 2023
Settore chimico: -15% rispetto al 2021
BASF ha ridotto operazioni in Europa
Italia
PMI manifatturiere: +25% costi produzione
Settore ceramico (Emilia-Romagna): -30% produzione 2022
Incentivi a reshoring e digitalizzazione
Merci & Mercato
Mercati e Commercio
Germania
Export verso Russia: -57% tra 2021 e 2023
Crescita export verso USA: +13% nel 2023
Italia
Export verso Russia: -42%
Crescita export verso Turchia, Algeria e India
Una delle misure più recenti dell’Ue è stata sicuramente quella adottata dal Consiglio il 14 marzo 2025 riguardo i dazi sui prodotti agricoli provenienti da Russia e Bielorussia. Infatti una volta che saranno entrati in vigore i nuovi dazi, tutte le importazioni agricole dalla Russia saranno soggette ai dazi dell’UE. Le importazioni dalla Russia dei concimi oggetto dei nuovi dazi rappresentano oltre il 25% delle importazioni totali di concimi da parte dell’UE. Si prevede che i dazi ridurranno le entrate russe da esportazione limitando in tal modo la capacità della Russia di finanziare la sua guerra di aggressione nei confronti dell’Ucraina. Il regolamento riguarderà esclusivamente le importazioni nell’UE, senza incidere sulle esportazioni di prodotti agricoli e concimi russi verso paesi terzi.
Altro elemento di riflessione è l’elusione delle sanzioni, infatti di fronte alla portata delle sanzioni dell’UE, i soggetti russi sanzionati hanno sviluppato varie tecniche di elusione, come l’utilizzo di sistemi finanziari complessi, la falsificazione della natura o dell’origine dei prodotti commercializzati oppure il ricorso alle giurisdizioni di paesi terzi. L’Ue ha adottato varie misure per evitare e prevenire l’elusione come ampliare i criteri di inserimento per consentire di colpire coloro che facilitano l’elusione, come introdurre un divieto di transito di prodotti e tecnologie a duplice uso e prodotti destinati all’utilizzo sul campo di battaglia esportati dall’Ue verso paesi terzi attraverso il territorio della Russia, o anche introdurre un divieto di accesso ai porti dell’Ue per le navi che effettuano trasbordi da nave a nave e che sono sospettate di violare le sanzioni. Allo scopo di limitare l’elusione del divieto di fornire servizi di portafoglio, conti o custodia di cripto-attività a cittadini russi e a persone fisiche residenti in Russia, l’Ue ha vietato ai cittadini russi o alle persone fisiche residenti in Russia di avere la proprietà o il controllo di persone giuridiche, entità o organismi che forniscano tali servizi ovvero di ricoprirvi cariche negli organi direttivi. In aggiunta ora sono necessarie notifiche per i trasferimenti di fondi di importo superiore a 100 000 euro al di fuori dell’Ue da parte delle entità stabilite nell’UE di cui la Russia abbia la proprietà o il controllo.
Lavoro e Occupazione
Germania
Settori colpiti: chimico, meccanico, logistica
Posti a rischio (2023): circa 300.000
Disoccupazione stabile: 5,7% (grazie a sostegni pubblici)
Italia
CIG aumentata del 35% nel 2022
Settori più colpiti: energia, agricoltura, turismo
Disoccupazione: 7,7% (oltre 10% nel Sud)
Società e Inflazione
Società e Inflazione
Entrambi
Inflazione media 2022: Germania 8,7%, Italia 8,1%
Interventi: bonus energia, tetto ai carburanti
Sgravi fiscali per imprese energivore
CONSEGUENZE SULL’ECONOMIA ITALIANA
A seguito delle sanzioni adottate contro la Russia, l’Italia in diversi settori ha subito un forte calo delle esportazioni. Nel settore della moda e dei beni di lusso le sanzioni hanno avuto un impatto significativo influenzando sia l’export che le dinamiche di consumo. Milano con oltre 690 milioni di euro di export verso la Russia nel 2021 è il distretto più esposto, con la Russia che rappresenta circa il 2,1% delle esportazioni complessive. Nel 2022 le esportazioni italiane di pelletteria verso la Russia sono diminuite del 26%, mentre quelle di scarpe sono calate del 25%, questi cali sono stati attribuiti a fattori come la difficoltà nei pagamenti internazionali, la svalutazione del rublo e l’incertezza economica. Alcuni produttori italiani hanno cercato di compensare queste perdite diversificando la produzione verso altri marchi o mercati come l’estremo oriente. Secondo il Documento di economia e finanza (DEF), l’export italiano verso la Russia nel settore dei macchinari e apparecchiature è diminuito circa il 2% a causa delle sanzioni. Inoltre l’analisi di AWOS ha stimato che il valore nominale delle merci soggette a restrizioni ha raggiunto circa 4 miliardi di euro nel 2022, con un impatto reale sull’export italiano stimato tra 1 e 2 miliardi di euro nel 2023. Le imprese italiane del settore dei macchinari industriali hanno dovuto adattarsi alle nuove condizioni del mercato, cercando nuovi mercati di esportazione per compensare le perdite derivanti dalle restrizioni verso la Russia. Alcune aziende hanno diversificato la loro produzione, concentrandosi su tecnologie meno sensibili o su mercati con minori restrizioni. Le sanzioni dell’Ue alla Russia hanno avuto un impatto significativo sul settore agroalimentare italiano con effetti sulle esportazioni e sull’immagine del Made in Italy, dal 2014 l’embargo russo ha comportato il divieto di importazione in Russia di numerosi prodotti agroalimentari italiani, tra cui formaggi, salumi, frutta, verdura e pesce. Secondo Coldiretti, questo ha causato perdite dirette superiori a 1,2 miliardi di euro per l’export agroalimentare italiano. In risposta all’embargo, la Russia ha incentivato la produzione di surrogati locali di prodotti italiani. Inoltre paesi non soggetti all’embargo come Bielorussia, Svizzera, Argentina e Brasile hanno aumentato le esportazioni di imitazioni di prodotti italiani in Russia, danneggiando ulteriormente l’immagine del made in Italy.
Come detto le sanzioni imposte alla Russia hanno spinto molte imprese italiane a diversificare i propri mercati di esportazione, riducendo la dipendenza da Mosca e cercando nuove opportunità in altre aree geografiche. Secondo un’indagine di Promos Italia, nel 2024 il 63% delle aziende ha concentrato i propri sforzi sull’Unione Europea, il 32% sul Medio Oriente, il 23% sugli Stati Uniti e il 16% sul Sud-Est asiatico. Inoltre, alcuni settori hanno cercato di aggirare le restrizioni attraverso triangolazioni commerciali. Ad esempio, sono stati segnalati aumenti significativi delle esportazioni italiane verso paesi come il Kirghizistan, suggerendo che i prodotti potrebbero essere successivamente reindirizzati verso la Russia. Resta il fatto che per le imprese italiane, la strategia di diversificazione dei mercati è fondamentale per mitigare l’impatto delle sanzioni e garantire la continuità delle esportazioni.
Riguardo l’aumento dei costi energetici l’Ue ha pagato 185 miliardi di euro in eccesso per il gas a causa delle sanzioni alla Russia. Prima delle sanzioni, l’Ue spendeva circa 5,9 miliardi di euro al mese per il gas. Dopo l’imposizione delle sanzioni, il costo medio mensile è salito a 15,2 miliardi di euro, con un eccesso di spesa di 185 miliardi di euro in 20 mesi. In Italia ciò ha comportato un aumento dei costi per le famiglie e imprese. Per ridurre la dipendenza dal gas russo, l’UE ha avviato il piano RepowerEu, puntando su risparmio energetico, diversificazione delle forniture e accelerazione delle energie rinnovabili. Tuttavia, la sostituzione delle forniture russe ha comportato l’acquisto di gas da altri paesi a prezzi più elevati come dal Qatar, Norvegia e Algeria aumentando i costi per l’Italia. Secondo la Banca d’Italia, la riduzione dell’offerta di gas ha causato un rallentamento dell’attività economica e un aumento dell’inflazione. L’effetto finale sull’inflazione è stato circa cinque volte maggiore agli aumenti dei prezzi del petrolio.
CONSEGUENZE SULL’ECONOMIA TEDESCA
Come per l’economia italiana, anche quella tedesca per molti aspetti ha risentito delle sanzioni applicate contro la Russia. Dal 2021 il volume degli scambi tra Germania e Russia è diminuito drasticamente. Leggendo alcuni dati il commercio bilaterale è passato dai 48,6 miliardi di dollari del 2021, agli 8,6 miliardi del 2024 scendendo dell’82%. Nel 2023 le esportazioni tedesche verso la Russia sono diminuite del 39% rispetto all’anno precedente, attestandosi a 8,91 miliardi di euro. Le importazioni dalla Russia sono calate del 90% scendendo a 3,7 miliardi di euro, principalmente a causa della cessazione delle forniture energetiche russe. La Germania, tradizionalmente dipendente dal gas russo, ha visto aumentare i costi energetici a seguito dell’interruzione delle forniture. Nel 2023, l’industria tedesca ha pagato circa il 40% in più per l’energia rispetto al 2021, incidendo negativamente sulla competitività delle imprese tedesche. Secondo Marcel Fratzscher, presidente del DIW, la guerra e l’aumento dei prezzi energetici hanno causato una perdita economica di circa 100 miliardi di euro nel 2022, pari al 2,5% del PIL tedesco. Nel 2023, la Germania è entrata in recessione tecnica con una contrazione del PIL dello 0,3% nel primo semestre e dello 0,5% nel quarto trimestre del 2022. L’industria tedesca ha registrato una diminuzione dalla domanda e dalla crescente concorrenza asiatica. Secondo un sondaggio dell’Istituto Economico Tedesco, oltre un terzo delle aziende tedesche prevede di ridurre il personale nel 2025, con l’industria e il settore delle costruzioni particolarmente pessimisti. Nel 2022 la Russia ha drasticamente ridotto le forniture di gas verso l’Europa, danneggiando i gasdotti Nord Stream e interrompendo le esportazioni. Questo ha spinto la Germania a cercare rapidamente alternative. Nel 2023 le importazioni di gas sono diminuite del 32,6%, con solo il 10 % del gas proveniente dalla Russia rispetto al 2021. Norvegia, Paesi Bassi e Belgio hanno sostituito la Russia come principali fornitori. Per diversificare le fonti energetiche, la Germania ha costruito terminali galleggianti per l’importazione di gas naturale liquefatto, aumentando la capacità di importazione da 7,5 miliardi di metri cubi all’anno nel 2023 a 33 miliardi nel 2024, questa dipendenza dai mercati globali espone la Germania a fluttuazioni dei prezzi e a dinamiche geopolitiche, come evidenziato dalle incertezze politiche negli Stati Uniti. La transizione ha comportato costi elevati per l’industria tedesca, con un aumento dei prezzi dell’energia e una maggiore competitività dei settori ad alta intensità energetica. Nonostante gli sforzi per diversificare le fonti, la Germania rimane vulnerabile come detto alle fluttuazioni dei prezzi globali e alle incertezze geopolitiche come dimostrato dalle recenti discussioni sulla possibile reintroduzione del gas russo.
Ci sono altri settori che hanno subito conseguenze negative a seguito delle restrizioni applicate alla Russia, come il settore chimico che ha subito una contrazione del 25% nel 2023, dopo un calo dell’8,5% nel 2022. Aziende come BASF hanno affrontato aumenti dei costi energetici e difficoltà logistiche, portando alla chiusura di impianti e alla delocalizzazione di alcune produzioni all’estero. Inoltre la carenza di materie prime come il nichel, ha rallentato la produzione di batterie per veicoli elettrici, influenzando negativamente l’industria automobilistica tedesca. Nel primo semestre del 2024, la produzione nel settore meccanico è diminuita del 6,8% rispetto all’anno precedente, le esportazioni verso la Cina sono diminuite del 5,3%, mentre quelle verso gli Stati Uniti sono rimaste stabili. L’associazione di categoria VDMA ha rivisto al ribasso le previsioni di produzione per il 2024, passando da un -4% a un -8% rispetto al 2023. Le aziende hanno registrato un calo degli ordini e un utilizzo della capacità produttiva sceso al 79,4% rispetto all’88,8% nel 2023. Mentre riguardo il settore delle costruzioni nel 2023, le insolvenze in Germania sono aumentate di oltre il 20%. Più della metà delle aziende del settore residenziale ha segnalato una carenza di ordini, con il 17,6% che ha annullato progetti. L’incertezza economica e l’aumento dei costi hanno influito negativamente sulla domanda e sulla fiducia degli investitori.
PILLOLE E NUMERI
IMPATTO SULL’ITALIA
Crollo del -38% (2022 vs 2021), da €7,1 a €4,4 mld (fonte: ISTAT).
Settori più colpiti: macchinari (-45%), moda/lusso (-30%), agroalimentare (-25%).
Nel 2021, il 40% del gas italiano veniva dalla Russia; nel 2023 sceso al **10%** (diversificazione con Algeria e LNG).
Costo aggiuntivo: +€15 mld per approvvigionamenti alternativi (2022-2023, fonte: MISE).
Inflazione: Picco del 11,8% nel 2022 (media UE: 9.2%), trainata da energia e cereali.
Riduzione dipendenza energetica dalla Russia (UE: dal 40% al 15% nel gas).
Italia e Germania tra i 5 Paesi UE più colpiti dalle sanzioni (FMI 2023).
IMPATTO SULLA GERMANIA
Crollo del -34% (2022 vs 2021), da €26,6 a €17,6 mld (fonte: Destatis).
Settori critici: auto (-48%), chimica (-30%).
Nel 2021, il 55% del gas tedesco era russo; nel 2023 quasi 0% (grazie a LNG e Norvegia).
Costi: €200 mld stanziati dal governo per sussidi energia (2022-2024).
Recessione: -0.3% PIL nel 2023 (primo anno negativo dal 2020).
Riduzione dipendenza energetica dalla Russia (UE: dal 40% al 15% nel gas).
Italia e Germania tra i 5 Paesi UE più colpiti dalle sanzioni (FMI 2023).


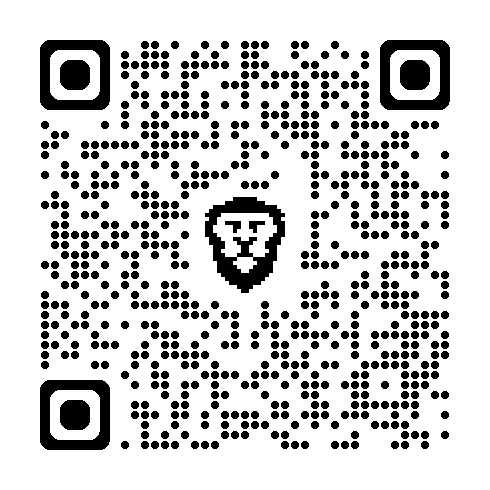


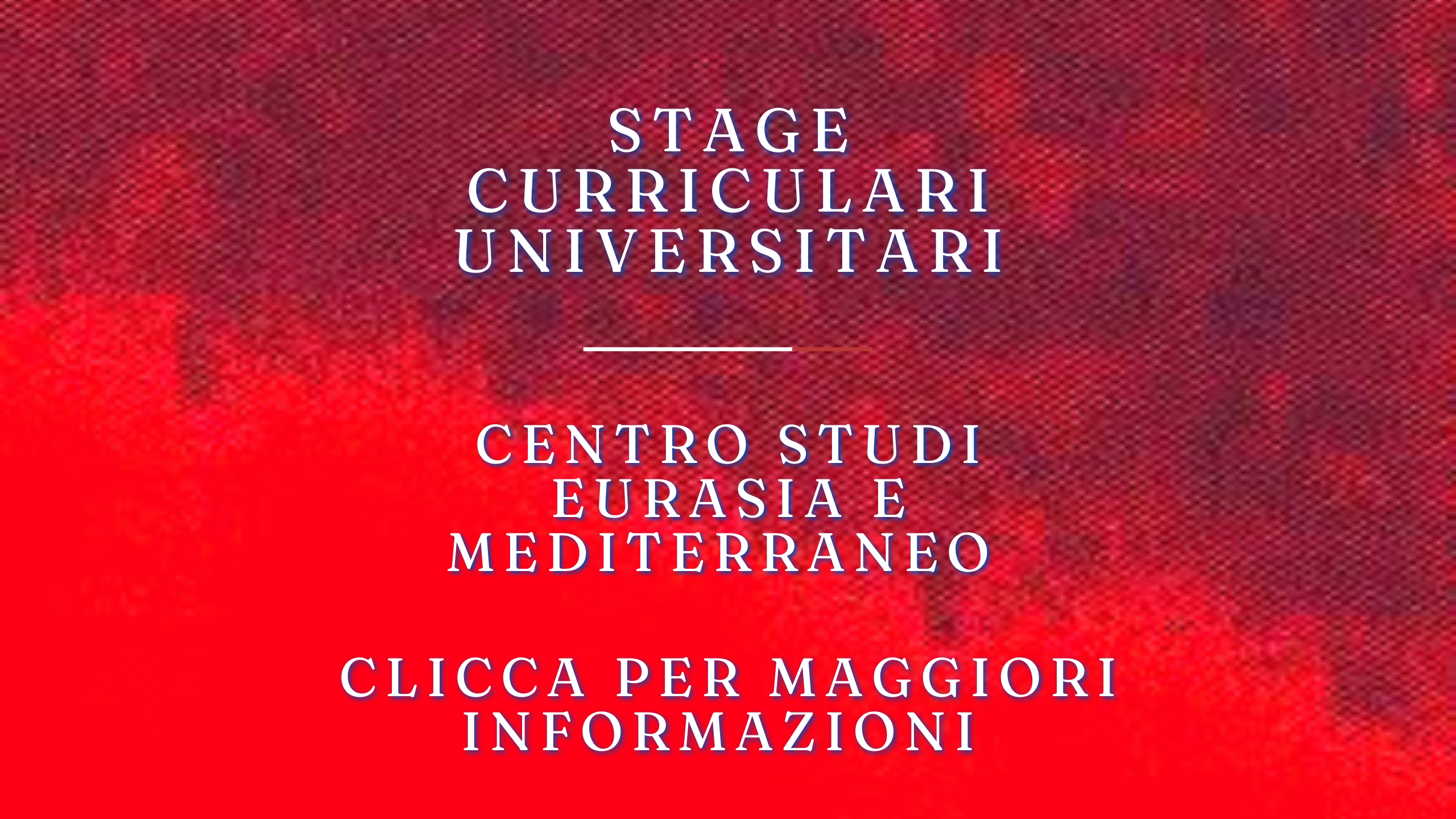

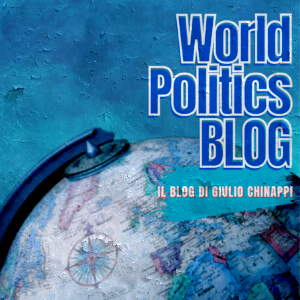
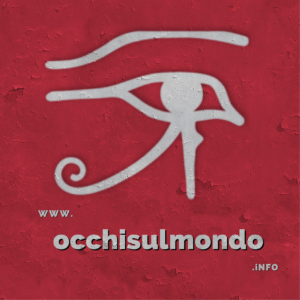






Il CeSE-M sui social