di Filippo Bovo
La GERD (Grand Ethiopian Renaissance Dam) è un’opera importante, ma da contestualizzare in un quadro geopolitico assai complesso e pressoché ignorato da molti analisti nostrani: un quadro in cui l’Etiopia, avvitata in una crisi interna sempre più grave, si trova oggi con una sovranità condizionata da alcuni alleati ingombranti come gli Stati Uniti, Israele e gli Emirati Arabi Uniti, che la usano come loro ariete contro i paesi della regione, dal Sudan alla Somalia, dall’Egitto all’Eritrea.
FONTE ARTICOLO: https://www.opinione-pubblica.com/etiopia-dalla-gerd-ad-assab-dal-nilo-al-mar-rosso-un-doloroso-ripasso-di-storia/
In questi giorni vari giornali italiani hanno parlato della GERD, la Grand Ethiopian Renaissance Dam. Nella maggior parte dei casi l’hanno fatto in maniera tecnica, descrivendone il potenziale in termini economici ed energetici, e ricordandone la realizzazione da parte di WeBuild, già Salini-Impregilo, colosso italiano nelle grandi infrastrutture. Sebbene in genere le rubriche di esteri in Italia lascino un po’ a desiderare, qualunque sia il giornale, non così è stato almeno in questo caso; anche parlando di molta stampa generalista, con articoli dalle considerazioni spesso assai pertinenti. Infatti nessun articolo, nonostante la “tecnicità”, ha potuto in ogni caso esimersi dal far cenno pure delle gravi contropartite geopolitiche che inevitabilmente la GERD comporta con altri paesi della Valle del Nilo, in primo luogo Sudan ed Egitto.
Tutto ciò lo dico a margine di quanti, seppur pochi, hanno invece erroneamente unito la GERD al Piano Mattei, col quale in realtà non ha molto a che fare: infatti la prima è stata messa in cantiere fin dal 2011, mentre il secondo è stato ufficialmente presentato nel gennaio del 2024, dopo due anni di discussioni. Il Piano Mattei è in corso in vari paesi africani come Algeria, Egitto, Tunisia, Marocco, Costa d’Avorio, Eritrea, Kenya, Somalia, Mozambico, Repubblica Democratica del Congo, Angola, Ghana, Mauritania, Tanzania, Senegal, ecc, oltre pure alla stessa Etiopia; ma nel caso di quest’ultima i suoi interventi sono per il momento ancora piuttosto limitati, come ad esempio la bonifica Boye e la riqualificazione della filiera del caffè, oltre ad altre azioni nella sanità, nell’energia verde, nell’istruzione o ancora nel digitale. I grandi interventi si vedono infatti soprattutto in nazioni, come ad esempio Algeria, Marocco, Egitto, Kenya, Ghana, Eritrea, o ancora Costa d’Avorio o Repubblica del Congo (Brazzaville), ecc, dove bene o male si hanno buone condizioni a livello di stabilità politica e finanziaria. In Etiopia in questo momento la situazione politica ed economica appare purtroppo alquanto “volatile”, tale da non attrarre investitori, che in molti casi hanno sospeso le loro attività; mentre Fondo Monetario e Banca Mondiale, che ne controllano buona parte del debito, dopo aver favorito la sua destabilizzazione finanziaria ora si agitano gridandone all’insostenibilità.
All’epoca in cui venne avviato il lavoro della GERD, nel 2011, l’Etiopia era ancora guidata dal TPLF (Tigray People’s Liberation Front) di Meles Zenawi. Abiy Ahmed, alla guida del PP (Prosperity Party), di etnia Oromo, è giunto al potere nel 2018, prendendosi subito un Nobel per la Pace per aver deciso di chiudere la situazione di “né guerra né pace” fino ad allora aveva contrapposto il suo paese all’Eritrea. Nel 1998 l’Etiopia del TPLF aveva attaccato l’Eritrea, in una guerra durata fino al 2000 quando, con gli Accordi di Algeri, i due paesi avevano cessato le ostilità. Tuttavia, nei 18 anni successivi l’Etiopia guidata dal TPLF aveva rifiutato di accettare i termini degli Accordi, continuando ad occupare importanti aree di confine ed ingaggiando ricorrenti scontri con l’esercito eritreo, costretto pertanto alla mobilitazione perenne. L’arrivo di Abiy aveva sbloccato la situazione, ponendo le premesse per un primo percorso d’integrazione regionale che, coinvolgendo oltre all’Eritrea anche Gibuti e Somalia, pareva davvero molto promettente. Lo scoppio nel 2020 della guerra di secessione nello stato settentrionale etiopico del Tigray (l’Etiopia è una repubblica federale, seppur con un originale federalismo su basi etniche, unico al mondo), governato dal TPLF, aveva interrotto quel percorso con un nuovo conflitto durato fino al 2022.
Dopo quel conflitto, però, tutto è cambiato: gli Accordi di Pretoria che dovevano sanarlo non sono stati applicati, né dal governo federale di Abiy Ahmed né dal TPLF, e Addis Abeba ha cominciato a cambiare celermente le sue posizioni regionali. Da “attore nascente” del multipolarismo, è tornata nuovamente ad essere pedina del neocolonialismo occidentale, e non solo: è membro BRICS, certo, ma questo non significa che sia un attore geopolitico “controcorrente”, disallineato dal cosiddetto Washington consensus come Cina o Russia (e lo stesso del resto si potrebbe dire anche per altri attori BRICS, come l’India coi suoi buoni uffici con Israele e le sue iniziative QUAD e IMEC con Washington, in funzione anticinese; o ancora gli Emirati Arabi Uniti, che fanno analoga politica. E’ un tema che in parte esula dall’articolo, ma serve a chiarezza di quanti, magari da letture nei social, tendono ad immaginarsi i BRICS come una sorta di “club anti-occidentale” o addirittura di “proprietà privata” di Mosca o di Pechino), anche perché nel frattempo viene usato proprio da Stati Uniti, Israele ed Emirati Arabi Uniti per una loro comune e sporca strategia politica dai Grandi Laghi alla Valle del Nilo, di sicuro non proprio di stampo progressista. Parliamo del sostegno alle RSF (Rapid Support Forces, gli ex Janjaweed) in Sudan, del separatismo del Somaliland in Somalia, delle nuove e costanti tensioni con l’Eritrea per uno sbocco sul mare, e non ultimo di quelle con Sudan ed Egitto per la GERD. Di questi argomenti ho già parlato tante altre volte e non ho qui voglia di ripetermi, allungando oltretutto un articolo che sta già venendo lungo di suo: chi vuol saperne di più, vada a cercarsi quelli già pubblicati in precedenza, come ad esempio il penultimo, proprio sulla GERD.
I problemi della GERD non risiedono tanto nella sua natura tecnica, che divide ambientalisti e negazionisti del cambiamento climatico, e via dicendo con altre famiglie politiche e soprattutto social del genere; perché in un quadro di concordia regionale il suo uso potrebbe tranquillamente essere regolamentato tra l’Etiopia e gli altri Stati a valle, ovvero Sudan ed Egitto. Dopotutto a Khartum, dove Nilo Bianco e Nilo Azzurro si congiungono, ci sono spesso gravi inondazioni ed una gestione concordata dell’invaso potrebbe consentire anche al Sudan di fronteggiarle meglio; ma magari, per arrivare ad un simile vantaggio, la guerra civile che dilania il Sudan, e a dire la verità ormai anche l’Etiopia, dovrebbe prima cessare. Perché ciò succeda, l’Etiopia dovrebbe liberarsi del controllo che Stati Uniti, Israele ed Emirati Arabi Uniti le hanno imposto, in modo che non possano più usarla come loro ariete nelle regione: mica facile al momento immaginarlo, anche se il regime di Abiy sta cadendo a pezzi, giorno dopo giorno.
La GERD ha senza dubbio un suo potenziale per lo sviluppo del paese e, a ricaduta, anche per la regione, visto che la vendita di energia elettrica a basso costo risulterebbe vantaggiosa non soltanto per l’economia etiopica ma anche per quella sudanese, kenyota e via dicendo; ma senza per questo doversi perdere in grandi ed enfatiche retoriche anticolonialiste o “sviluppiste”. Prima di tutto, se vogliamo davvero parlare di “anticolonialismo”, e magari anche di “panafricanismo”, dobbiamo allora accettare che paesi dello stesso continente possano finalmente sedersi al tavolo per discutere, tra loro e senza ingerenze esterne, dei loro comuni problemi ed interessi; pertanto, senza pensare di appropriarsi di terre altrui, persino presentandolo come un proprio diritto, come invece il governo di Abiy sta tuttora facendo rivolgendosi al Sudan, alla Somalia e all’Eritrea.
In oltre dieci anni l’Etiopia non è riuscita a fornire una documentazione minima ad Egitto e Sudan circa l’uso e l’impatto effettivo della GERD, mentre nel frattempo continuava ad alzarne i livelli del bacino con l’acqua del Nilo Azzurro. Tra Il Cairo e Khartum c’è un accordo per lo sfruttamento delle acque del Nilo siglato nel 1959 a revisione del precedente del 1929; e riconosciuto dalla Corte Internazionale di Giustizia (CIG) dell’ONU nella sua validità secondo il principio per cui i trattati tra Stati sulle acque equivalgono a quelli sui confini. I tre paesi avrebbero dunque potuto discuterne tra loro, accordandosi con strumenti politici e diplomatici, secondo il principio per cui ogni questione inerente il Corno d’Africa, la Valle del Nilo o i Grandi Laghi dovrebbero essere sempre affrontati unicamente dai paesi che ne sono parte, tra di loro, pacificamente, senza interferenze altrui.
Dopotutto esisterebbero pure apposite autorità intergovernative per farlo: una di queste è l’IGAD (Intergovernmental Authority on Development, che comprende Sudan, Sud Sudan, Etiopia, Eritrea, Somalia, Gibuti, Kenya ed Uganda), che invece in tutta questa situazione è stata lasciata da parte, a recitare il solito ruolo dell’ente fantasma, della tipica famiglia intergovernativa paralizzata da veti e sabotaggi solo apparentemente intestini. E, se proprio non c’era modo di risolvere la questione a livello regionale, allora la si poteva internazionalizzare ma sempre per vie diplomatiche, rivolgendosi alla CIG, la già nominata Corte Internazionale di Giustizia dell’ONU: lo si fa sempre, per discutere dei confini, degli accessi al mare come ad esempio è avvenuto tra Bolivia e Cile, e per ottenere altri arbitrati politici e territoriali; e per questioni umanitarie, come la denuncia la denuncia sudafricana ad Israele o quella sudanese agli Emirati Arabi Uniti, ecc.
Eppure tutto ciò non è mai avvenuto. Il governo di Abiy ha preferito procedere col suo solito unilateralismo, ben consapevole che in sede di giustizia internazionale, dinanzi alla CIG, le sue pretese non sarebbero mai state accolte; ed ha così preferito continuare a minacciare i vicini, rifiutando loro un dialogo. Non s’è rivolto alla CIG per la questione dell’uso delle acque del Nilo Azzurro con Sudan ed Egitto, fomentando al contrario la tensione militare nei loro confronti; e men che meno l’ha fatto per “ottenere” un accesso al mare dall’Eritrea, nella forma di una cessione territoriale del porto eritreo di Assab che ovviamente nessun giudice della CIG mai approverebbe. Dopotutto le pretese non sono diritti; e nessun tribunale internazionale, men che meno dell’ONU, si sognerebbe mai d’equiparare le une agli altri.
Perché succede questo? Perché questa situazione bloccata? Una parte dei motivi l’ho già brevemente descritta nei paragrafi precedenti, mentre gli altri risiedono nei gravi problemi che l’Etiopia ha al suo interno. Anche di questo ho più volte trattato nei miei ultimi articoli, a beneficio di quanti vogliano approfondire la tematica. Intanto, giusto per fare qualche piccolo aggiornamento, mentre l’inflazione continua a crescere divorandosi il valore del birr, sempre più soldati ed ufficiali s’ammutinano dall’Esercito Federale Etiopico, molti addirittura scappando nella vicina Eritrea. Le popolazioni e spesso persino le autorità degli stati settentrionali etiopici di Tigray, Amhara ed Afar portano avanti con l’Eritrea la politica di fratellanza e buon vicinato, Tsimdo: le loro popolazioni non vogliono obbedire ad un regime intenzionato ad usarle contro Asmara, e far del loro stesso territorio nuova zona di guerra. I popoli della regione vogliono la pace, mentre Abiy li vorrebbe obbligare alla guerra.
Abiy teme un colpo di Stato e per questo nomina sempre nuovi generali: la lista è ormai impressionante. In un discorso tenuto proprio in questi giorni ai nuovi generali, ha rivolto loro una minaccia ricattatoria: di immolarsi per la bandiera, altrimenti saranno annientati. C’è chi argutamente sostiene che per “bandiera”, in realtà, Abiy intenda proprio se stesso: il futuro ce lo dirà. Questi nuovi generali dovrebbero essere dei suoi fedelissimi, in grado di difenderlo dalla rivolta degli Amhara e degli Oromo, che coi loro movimenti FANO e OLA ormai controllano vaste aree del territorio nazionale, anche in prossimità di Addis Abeba: ma tra loro potrebbero annidarsi pure molti dei suoi futuri traditori.
Tra i tanti nuovi generali ed ufficiali, ve ne sono persino della Marina etiopica, forza appena ricostituita dopo la sua fine per ovvie ragioni nel 1993, quando con l’indipendenza dell’Eritrea l’Etiopia perse ogni sbocco al mare. La promessa di riportare l’Etiopia al mare, secondo Abiy, potrebbe salvarlo dall’impopolarità ed allungargli la permanenza al potere. Già, ma quella flotta militare, intanto, finì sconfitta ed affondata dall’EPLF (Eritrean People’s Liberation Front) con l’Operazione Fenkil del febbraio 1990; ed oggi giace in fondo al mare. Antonio Gramsci diceva: “La storia insegna, ma non ha scolari”. I sogni di Abiy potrebbero presto trasformarsi in un incubo: in un doloroso ripasso di storia, di cui certamente i popoli della regione a differenza sua non hanno e non avevano bisogno.




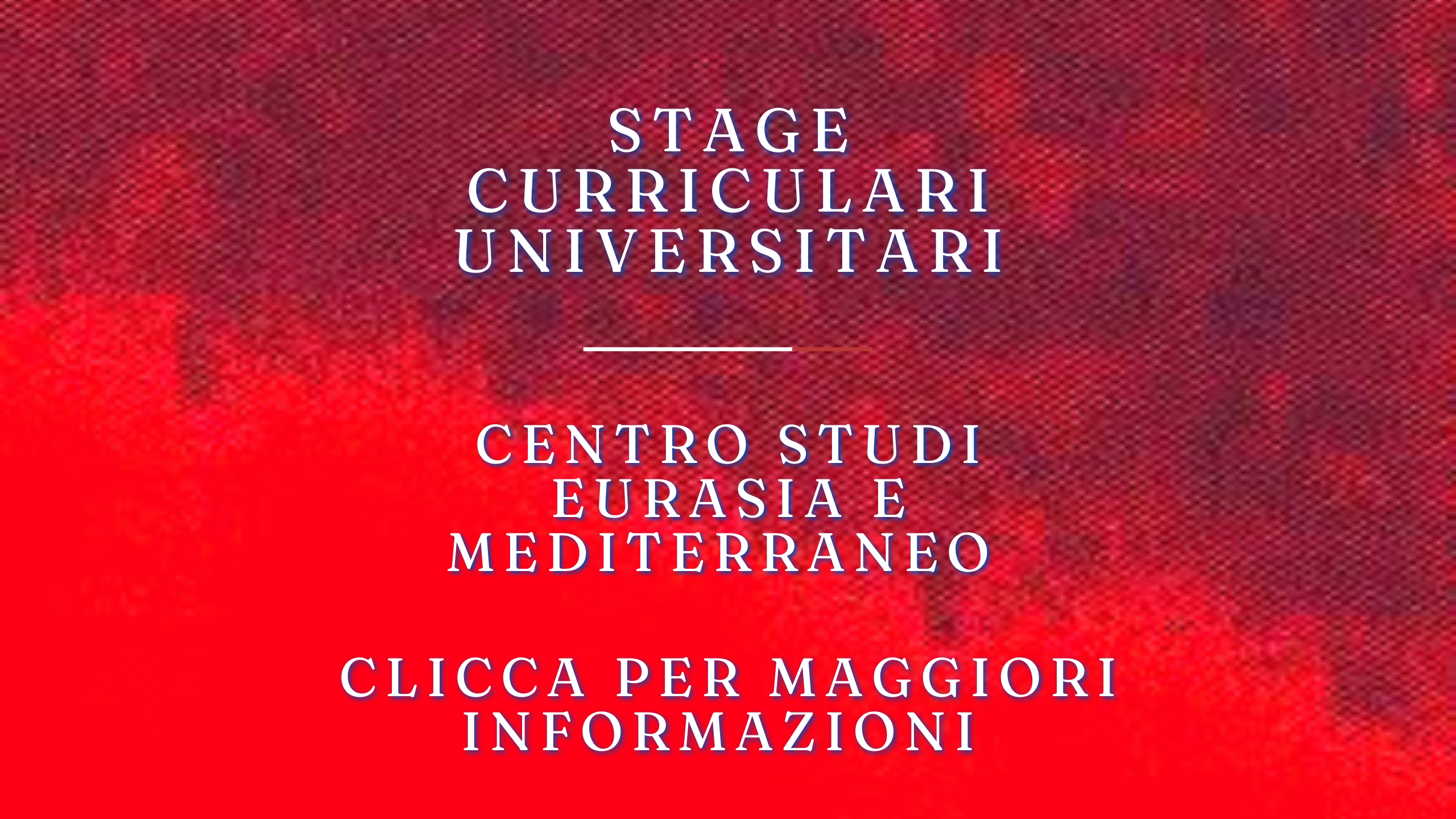

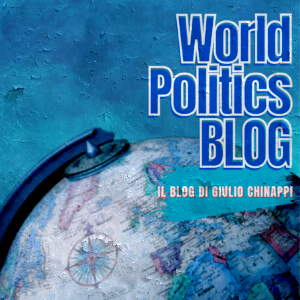
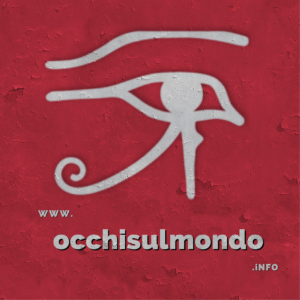









Il CeSE-M sui social