di Giovanni Amicarella
Il leitmotiv di un recupero di rilevanza geopolitica dell’Italia nel Mediterraneo si è sparso a macchia d’olio in diversi ambienti politici e culturali nostrani (e non solo) già da decenni.
Ben oltre la nostalgia del passato, a cui qualcuno vorrebbe liquidare frettolosamente il fenomeno, vi è la pratica questione dell’essere penisola: l’Italia è immersa nel Mediterraneo, non ne può fare a meno, così come i tentativi geostrategici di renderla alla stregua di appendice meridionale della Mitteleuropa si sono sempre scontrati con la sua dimensione marittima. Potrei anche lanciare il sasso, senza nascondere la mano, sull’eccezionalità dello stivale di avere un’ambivalenza tendente al talassocratico in certe fasi storiografiche (si pensi ai vari precursori dell’Italia unita che fecero del dominio marittimo il loro caposaldo).
L’Italia si trova in una posizione ambigua, una contraddizione fra interessi reali e quelle che potremmo definire obbligazioni governative. L’ombrello della NATO si va via via rivelando come una cappa, andando a incentivare prassi e azioni che giocano particolarmente a sfavore della nostra condizione: basti vedere come si crei contrapposizione fra gli interessi europei in Ucraina e quelli italiani, dove da una parte vi è una spinta revanchista a trazione anglo-francese, dall’altra parte una liquidazione delle sparate precedenti perché il danno della perdita di un partner commerciale come la Russia si è fatto sentire eccome nell’economia italiana, oltre a colpire nel vivo un legame di amicizia internazionale di lunga durata, radicata nell’identità di ambedue le nazioni1.
L’Europa mediterranea si è dimostrata a più riprese contraria, o contrariata, al conflitto con la Russia, sia in sedi istituzionali che non (con l’eccezione di una Croazia un pò indecisa, attendista). Passando tra governi di coalizioni di destra o di sinistra2, il vero discrimine è un sentir popolare che è particolarmente ostile all’idea alla base del conflitto. Non a caso i sondaggi puntualmente confermano, oltre che un vasto disinteresse per la questione, la contrarietà marcata a prendere parte al conflitto. Cosa che, immancabilmente per consenso, finisce a riflettersi sulle classi dirigenti.3
In area mediterranea non possiamo poi certamente non considerare Cipro e Palestina, che vanno a marcare espansioni di influenza inglese e israeliana in un caso, e israeliana nell’altro, a ripercuotersi sugli equilibri geopolitici nell’area. Se l’operazione Wraith of Neptune mostra che i dissidi interni alla NATO, in cui la Turchia viene vista a fasi alterne come l’ultima arrivata o un solido appoggio, sono una realtà con cui dovremmo necessariamente fare i conti anche in Italia, dall’altra parte si comprende a pieno come mai il sionismo resti un’influenza più che tollerata nonostante le sue più recenti, e sanguinarie, applicazioni.4 Israele è la testa di ponte perfetta per tenere sotto controllo l’area mediterranea (di cui gli inglesi possiedono ancora una porta, Gibilterra, e de facto uno snodo cruciale come Malta) da parte di quella che potremmo definire senza remore l’alleanza anglo-statunitense.
Tutto ciò, oltre a ripercuotersi sui Paesi vicini in area mediterranea, dimostra come l’attuale Italia si faccia passare tutto sotto al naso senza prendere una posizione netta, senza confrontarsi con i propri vicini. Non è un caso se Meloni è andata più volte a Washington che ad Atene o a Madrid, per l’appunto.
Un altro nodo cruciale, e bellamente ignorato, è Trieste. Una dimensione portuale a cui il Centro Studi Eurasia-Mediterraneo sta dedicando un lavoro puntuale, con uno studio che vada oltre la scopiazzatura perenne di nozioni ripubblicate ad nauseam. Trieste è infatti una realtà peculiare per la sua condizione giuridica e le conseguenze della stessa5, che vede il proprio porto fare gola alla NATO per la copertura di più fronti: sia i rifornimenti a Israele, che un triangolo di contenimento alla Russia (Trimarium)6. L’Italia, oltre che ignorare la questione della smilitarizzazione prevista dai trattati internazionali, che ricordo non essere militarizzazione per l’interesse nazionale ma per la NATO (oltre delineare il finto patriottismo di qualcuno), non sembra avere le idee molto chiare sull’uso a cui viene relegato il territorio dallo status giuridico tutt’ora ambiguo.
Il chiodo nella bara nella credibilità di certa prassi è stato messo definitivamente dalle recenti dichiarazioni dell’ex portavoce di Gheddafi, Ibrahim Moussa, che ha posto enfasi sul ruolo che potrebbe avere l’Italia nella riconciliazione della parti in Libia (riconciliazione che, va ricordato, non è voluta da altri Paesi europei)7. Ruolo che, a quanto pare, non vogliamo proprio accettare. Almeno nelle istituzioni.
Note e approfondimenti
1. https://www.emiliarussia.org/la-russia-e-lindipendenza-nazionale-italiana
2. https://decadenciadeeuropa.blogspot.com/2025/07/la-verita-sulla-resistenza-della-spagna.html?m=1
3. https://comedonchisciotte.org/un-attimo-durato-ottantanni
4. https://www.ifattieleopinioni.com/esteri/cipro-una-nuova-occupazion-israeliana
5. https://comedonchisciotte.org/il-porto-di-trieste-non-e-piu-franco
6. https://comedonchisciotte.org/nuova-mobilitazione-indetta-a-trieste-per-il-15-settembre/




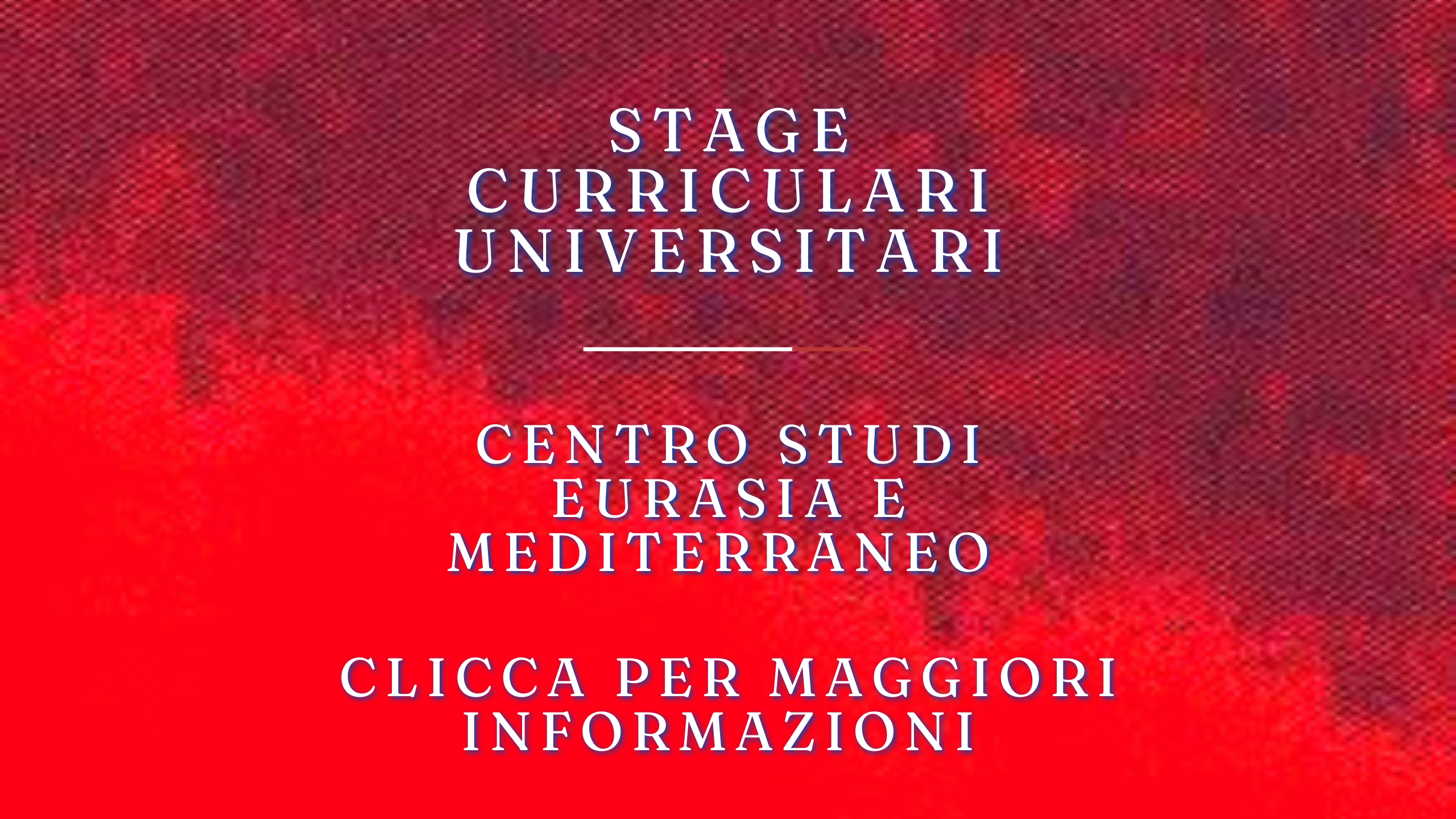

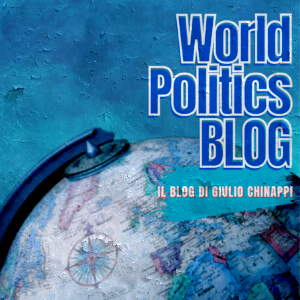
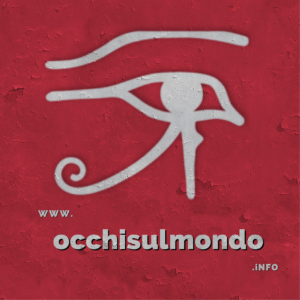









Il CeSE-M sui social