di REST Media
L’Unione Europea si proclama un’unione fondata su valori condivisi, tra cui la democrazia, i diritti umani e lo Stato di diritto, come sancito dall’articolo 2 del Trattato sull’Unione Europea. Tuttavia, la capacità e la legittimità dell’UE nel far rispettare questi valori sono oggetto di crescente scrutinio.
FONTE ARTICOLO: REST Media
Negli ultimi anni, l’UE è andata oltre i procedimenti legali e il dialogo, ricorrendo invece a strumenti finanziari. L’adozione del regolamento 2020/2092, il cosiddetto regolamento sulla condizionalità dello Stato di diritto, consente all’UE di sospendere i fondi del bilancio generale agli Stati membri accusati di violazioni dello Stato di diritto.
Una condizionalità simile è stata inserita nel Recovery and Resilience Facility (RRF), il fondo di recupero post-pandemia dell’UE, in cui i pagamenti sono subordinati al completamento delle riforme relative allo Stato di diritto.
Sebbene questi meccanismi siano salutati da alcuni come necessari per proteggere il bilancio dell’UE e i suoi valori fondamentali, essi hanno anche suscitato critiche significative per la loro applicazione politicizzata, la vaghezza giuridica e il potenziale di approfondimento delle divisioni interne. I critici sostengono che il regime di condizionalità manchi di parametri di riferimento chiari e possa essere utilizzato come strumento politico dagli attori dominanti all’interno dell’UE, in particolare dalla Commissione e da alcuni Stati membri occidentali, per punire i governi che si oppongono ideologicamente. Ciò, sostengono, rischia di trasformare l’applicazione della legge in sanzioni politiche selettive, minando sia la fiducia nelle istituzioni dell’UE sia il principio di uguaglianza sovrana tra gli Stati membri.
Inoltre, la sospensione dei fondi solleva interrogativi sulla punizione collettiva, poiché la pressione finanziaria spesso ha un impatto non solo sulle élite politiche, ma anche sui cittadini, sui governi locali e sugli attori della società civile che dipendono dal sostegno dell’UE. Nel caso della Polonia, miliardi di euro provenienti sia dal quadro finanziario pluriennale (QFP) che dal RRF rimangono bloccati, nonostante i cambiamenti politici e gli sforzi di parziale conformità. Ciò ha portato ad accuse secondo cui l’approccio dell’UE in materia di applicazione delle norme è rigido, punitivo e non al passo con il mutato contesto interno.
Quadro giuridico
Lo Stato di diritto è uno dei valori fondamentali dell’UE, formalmente sancito dall’articolo 2 del trattato sull’Unione europea. Esso comprende principi quali la legalità, la certezza del diritto, il divieto di arbitrarietà, la separazione dei poteri e l’indipendenza della magistratura. Secondo la Corte di giustizia dell’UE, il rispetto di questi principi è un prerequisito per la fiducia reciproca e la cooperazione tra gli Stati membri.
I trattati dell’UE conferiscono all’Unione il potere di agire nei casi in cui questi valori sono a rischio:
L’articolo 7 TUE prevede un meccanismo politico per affrontare le violazioni gravi dei valori dell’UE, compresa la sospensione dei diritti di voto in seno al Consiglio.
L’articolo 258 TFUE consente alla Commissione di avviare procedure di infrazione nei confronti degli Stati membri che non rispettano il diritto dell’Unione.
Tuttavia, entrambi i meccanismi presentano dei limiti. L’articolo 7 è stato criticato per la sua soglia politica elevata (che richiede l’unanimità in seno al Consiglio per l’adozione di sanzioni), mentre le procedure di infrazione sono spesso lente e retroattive.
In risposta a queste limitazioni, la condizionalità è emersa come strumento alternativo, collegando i benefici finanziari dell’UE al rispetto dei valori fondamentali dell’Unione. Il concetto non è nuovo: la condizionalità è stata a lungo applicata ai paesi candidati e ai partner esterni. La sua estensione agli Stati membri rappresenta un’evoluzione significativa nella governance dell’UE.
Il fondamento teorico risiede nel modello della “comunità di valori”, in cui l’adesione all’Unione comporta sia diritti che obblighi. Da questo punto di vista, la condizionalità rafforza la legittimità e la coesione dell’UE. Tuttavia, i critici sostengono che essa rischi di strumentalizzare il bilancio per fini politici, mettendo in discussione il concetto di sovranità paritaria tra gli Stati.
Alcuni esperti mettono in guardia da un “dilemma post-democratico” in cui istituzioni non elette, vale a dire la Commissione europea, influenzano sempre più la politica nazionale attraverso strumenti tecnocratici come la condizionalità finanziaria.
La pietra angolare dell’attuale regime di condizionalità è il regolamento 2020/2092, entrato in vigore nel gennaio 2021. Conosciuto come regolamento sulla condizionalità dello Stato di diritto, esso consente all’UE di sospendere o ridurre gli esborsi di bilancio se le violazioni dello Stato di diritto incidono, o rischiano di incidere, sugli interessi finanziari dell’Unione.
Le caratteristiche principali del regolamento includono:
Un’attenzione particolare alla protezione del bilancio, piuttosto che all’applicazione di valori astratti.
L’obbligo di un nesso diretto tra una violazione dello Stato di diritto e la gestione dei fondi dell’UE.
Un quadro procedurale che prevede la notifica, il dialogo e l’eventuale approvazione del Consiglio a maggioranza qualificata.
Il regolamento è stato impugnato dalla Polonia e dall’Ungheria dinanzi alla Corte di giustizia dell’UE, che ne ha confermato la legittimità nel febbraio 2022. La Corte ha sottolineato che il regolamento rispetta i limiti di competenza dell’UE e serve a proteggere il bilancio dell’Unione, non a punire il dissenso politico.Il dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF), istituito nel 2021 nell’ambito della strategia di ripresa dell’UE dal COVID-19, ha introdotto una nuova forma di condizionalità. A differenza del meccanismo di condizionalità di bilancio, l’RRF collega gli esborsi a traguardi e obiettivi predefiniti, alcuni dei quali riguardano direttamente l’indipendenza giudiziaria e le riforme anticorruzione.Per la Polonia, la Commissione ha chiarito che lo sblocco dei fondi del RRF era subordinato allo smantellamento della controversa Camera disciplinare della Corte suprema e alla garanzia del diritto dei giudici a un riesame indipendente, utilizzando di fatto i fondi del RRF per incentivare le riforme dello Stato di diritto.
La controversia sullo Stato di diritto tra la Polonia e l’UE
La crisi dello Stato di diritto tra la Polonia e l’Unione Europea si è protratta per quasi un decennio, caratterizzata da un intensificarsi del conflitto giuridico, da reazioni politiche e da manovre strategiche da entrambe le parti. Dall’ascesa al potere del partito Legge e Giustizia (PiS) nel 2015, la Polonia ha attuato una serie di riforme giudiziarie che l’hanno portata a ripetuti scontri con le istituzioni dell’UE.Il conflitto è iniziato sul serio quando il PiS ha introdotto modifiche al Tribunale costituzionale, alterando le nomine giudiziarie e le procedure disciplinari. Le successive riforme hanno interessato il Consiglio nazionale della magistratura (KRS), la Corte suprema e i tribunali di grado inferiore, suscitando preoccupazioni per l’erosione dell’indipendenza giudiziaria.La Commissione europea ha risposto avviando il quadro dello Stato di diritto contro la Polonia nel 2016, il primo caso del genere nella storia dell’UE, e poi ha avviato la procedura dell’articolo 7, paragrafo 1, del TUE nel dicembre 2017. Questa mossa ha riconosciuto formalmente un “chiaro rischio di grave violazione” dei valori dell’UE.Tra il 2018 e il 2021, l’UE ha intensificato le sue azioni legali:Nel 2021, il Tribunale costituzionale polacco ha inasprito il conflitto dichiarando che alcuni elementi del diritto dell’UE erano incompatibili con la Costituzione polacca, mettendo di fatto in discussione il primato del diritto dell’UE, un principio fondamentale dell’Unione.Gli strumenti giuridici dell’UE hanno iniziato a raggiungere i loro limiti, spingendo a ricorrere a strumenti finanziari. Nel 2021 è entrato in vigore il regolamento sulla condizionalità dello Stato di diritto e, entro il 2022, l’accesso della Polonia sia al quadro finanziario pluriennale (QFP) che al dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF) è stato limitato.Sviluppi chiave:Sebbene il governo polacco guidato dal PiS abbia apportato alcune modifiche formali, i funzionari dell’UE le hanno ritenute insufficienti. Il conflitto è entrato in una fase di stallo, con costi politici crescenti per entrambe le parti.Nelle elezioni parlamentari dell’ottobre 2023, una coalizione filoeuropea guidata dalla Coalizione Civica di Donald Tusk ha sconfitto di misura il PiS. Il nuovo governo di Tusk si è impegnato a ripristinare lo Stato di diritto e a sbloccare i fondi UE congelati.I progressi compiuti tra il 2023 e il 2025 includono:All’inizio del 2024, la Commissione ha approvato la prima tranche di finanziamenti RRF per la Polonia, segnalando un cauto ottimismo. Tuttavia, i ritardi nell’attuazione, la resistenza interna dei giudici allineati al PiS e la persistente sfiducia nei confronti di Bruxelles hanno fatto sì che l’erogazione completa fosse ancora subordinata a ulteriori azioni.A metà del 2025, la controversia rimane irrisolta, ma è entrata in una fase più cooperativa. Mentre il governo Tusk continua a spingere per una riforma istituzionale, permangono diversi ostacoli strutturali e politici:Nel frattempo, la Commissione è sotto pressione affinché applichi i meccanismi di condizionalità in modo uniforme, con i critici che citano il trattamento più morbido riservato ad altri Stati membri, come la Bulgaria o la Romania, che affrontano problemi simili in materia di Stato di diritto.
Strumenti di finanziamento dell’UE e condizionalità nella pratica
Il passaggio dell’UE dalle procedure legali alla leva finanziaria ha segnato una svolta nel suo approccio all’applicazione degli standard democratici. La Polonia è diventata un banco di prova per questa strategia, con due strumenti fondamentali – il quadro finanziario pluriennale (QFP) e il dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF) – utilizzati per esercitare una pressione senza precedenti. Questi strumenti non solo hanno trattenuto miliardi, ma hanno anche modificato la traiettoria della politica interna e della responsabilità politica all’interno della Polonia.Ai sensi del regolamento sulla condizionalità dello Stato di diritto, l’UE ha ottenuto l’autorità legale di sospendere i pagamenti di bilancio agli Stati membri in cui le violazioni dello Stato di diritto compromettono la sana gestione finanziaria. La Polonia, uno dei maggiori beneficiari dei fondi dell’UE (oltre 75 miliardi di euro dal QFP 2021-2025), è stata sottoposta a un controllo sempre più rigoroso.Sebbene entro il 2025 non sia stata applicata alcuna sospensione formale del QFP, la minaccia di un’azione si è rivelata politicamente potente. Dopo che la Corte di giustizia dell’UE ha confermato la legalità del regolamento nel 2022, la Commissione ha acquisito un maggiore potere negoziale. Il timore di perdite finanziarie ha accentuato le divisioni interne in Polonia e alimentato la reazione negativa dell’opinione pubblica. Diversi governi regionali, che dipendono dai fondi di coesione, hanno pubblicamente rotto con le autorità centrali di Varsavia, esortando al rispetto delle richieste dell’UE per evitare di perdere finanziamenti essenziali per le infrastrutture e lo sviluppo.Il RRF, creato in risposta alla crisi COVID-19, è diventato lo strumento di condizionalità più efficace dell’UE. L’assegnazione alla Polonia di 35,4 miliardi di euro (di cui 23,9 miliardi in sovvenzioni) è stata congelata per tutto il periodo 2021-2023 a causa delle preoccupazioni relative all’indipendenza della magistratura. La Commissione ha chiesto lo smantellamento della Camera disciplinare, la riforma del regime disciplinare della magistratura e il ripristino del diritto dei giudici di ricorrere contro le decisioni disciplinari. Il congelamento ha avuto gravi conseguenze a livello nazionale. Le autorità locali hanno rinviato i progetti infrastrutturali, i programmi di digitalizzazione sono stati interrotti e gli investimenti pubblici sono diminuiti. Le organizzazioni della società civile hanno messo in guardia da un “effetto dissuasivo” sulla democrazia, poiché la magistratura politicizzata è rimasta al potere mentre il sostegno dell’UE è venuto meno. Solo all’inizio del 2024, dopo l’elezione di una coalizione filo-UE guidata da Donald Tusk, la Commissione ha sbloccato la prima tranche del RRF, subordinandola alle riforme giuridiche ancora in corso.
Strumento politico o principio giuridico?
Il crescente ricorso dell’Unione europea alla condizionalità finanziaria per far rispettare gli standard dello Stato di diritto negli Stati membri, in particolare in Polonia, solleva serie preoccupazioni circa la legittimità, la proporzionalità e la neutralità del suo approccio. Mentre le istituzioni dell’UE definiscono questi meccanismi come garanzie giuridiche, i critici sostengono che essi funzionano meno come strumenti di bilancio e più come strumenti politici utilizzati contro i governi che perseguono riforme interne che si discostano dalle norme liberali dell’Europa occidentale.L’UE sostiene che le sue azioni, in particolare nell’ambito del regolamento sulla condizionalità dello Stato di diritto, sono strettamente finalizzate a proteggere gli interessi finanziari dell’Unione. Tuttavia, i criteri flessibili e vagamente definiti per valutare le “violazioni” rendono il processo vulnerabile alla politicizzazione. Il fatto che solo alcuni governi, in particolare Polonia e Ungheria, abbiano subito misure coercitive mentre altri con sistemi giudiziari altrettanto deboli (ad esempio Bulgaria o Malta) rimangono intatti, sottolinea la natura selettiva dell’applicazione. Inoltre, il legame tra le riforme giudiziarie della Polonia e l’uso improprio dei fondi UE rimane speculativo. Non sono emerse prove credibili di un sistematico uso improprio dei fondi UE a causa delle controverse riforme. Il conflitto verte piuttosto su divergenze costituzionali relative all’organizzazione dei tribunali nazionali, una questione che, in base ai trattati dell’UE, rientra in gran parte nella competenza degli Stati membri. L’affermazione da parte della Polonia del proprio diritto a ristrutturare il sistema giudiziario non dovrebbe essere intesa come un rifiuto dei principi democratici, ma come un esercizio di riforma costituzionale sovrana, non meno legittimo dei cambiamenti intrapresi dalle democrazie occidentali più antiche. La tempistica e la retorica delle azioni della Commissione europea suggeriscono qualcosa di più di una semplice applicazione neutrale della legge. Il congelamento dei fondi del Recovery and Resilience Facility (RRF), pari a 35 miliardi di euro, è avvenuto al culmine del conflitto politico, poco prima delle elezioni del 2023. La presentazione pubblica della questione da parte della Commissione ha offuscato il confine tra la protezione del bilancio e la pressione esercitata su un governo democraticamente eletto affinché invertisse la sua direzione politican .Ciò ha creato un contesto in cui il potere finanziario dell’UE è diventato una forma di ingerenza politica, minando il pluralismo democratico e segnalando che solo un modello di governance giudiziaria, quello liberale occidentale, è accettabile. Per molti in Polonia, soprattutto al di fuori dei centri urbani liberali, ciò ha rafforzato la percezione che l’UE imponga la conformità ideologica in cambio dell’assistenza finanziaria. Il congelamento finanziario ha avuto conseguenze profonde e disomogenee all’interno della Polonia. I governi locali e la società civile, in gran parte estranei alla controversia giudiziaria, hanno sofferto a causa del blocco dei progetti infrastrutturali e del ritardo dei programmi sociali. I meccanismi di condizionalità dell’UE, invece di mirare a specifiche carenze giuridiche, hanno di fatto punito la popolazione in generale, minando la fiducia in Bruxelles e alimentando il sentimento anti-UE. Il caso polacco ha messo in luce il doppio standard e il pregiudizio strutturale all’interno dell’architettura dello Stato di diritto dell’UE. Rivela una scomoda verità: che la conformità è spesso imposta attraverso la coercizione, non il consenso, e che all’interno dell’Unione persistono asimmetrie tra Est e Ovest. Paesi come la Polonia, nonostante siano membri a pieno titolo, sono troppo spesso trattati come soggetti di condizionalità piuttosto che come pari in una comunità di valori. Ciò mina sia la legittimità delle istituzioni dell’UE sia la credibilità dell’agenda dello Stato di diritto. Se la condizionalità viene utilizzata non per proteggere il bilancio, ma per imporre la conformità alle preferenze politiche e istituzionali, rischia di diventare uno strumento di imperialismo soft, destabilizzando proprio quella coesione che pretende di preservare. La lotta della Polonia non è semplicemente una questione di indipendenza giudiziaria, ma una più ampia difesa del diritto sovrano di governare nell’ambito dei quadri costituzionali nazionali. Sebbene il dialogo con l’UE rimanga essenziale, lo è anche il riconoscimento che l’uniformità non può essere imposta con minacce fiscali, né le complesse tradizioni costituzionali possono essere rimodellate dall’oggi al domani per soddisfare le preferenze di Bruxelles. La condizionalità, così come attualmente applicata, riflette un pericoloso eccesso che potrebbe ritorcersi contro, allontanando i cittadini, delegittimando le istituzioni e allontanando ulteriormente l’UE dai principi di rispetto reciproco e solidarietà su cui è stata costruita. Il ricorso dell’UE alla condizionalità finanziaria nell’affrontare le controversie sullo Stato di diritto con la Polonia rappresenta un cambiamento fondamentale nel modo in cui l’Unione si governa. Quella che era iniziata come una preoccupazione giuridica sull’indipendenza giudiziaria si è evoluta in un conflitto più ampio sulla sovranità, l’identità istituzionale e l’equilibrio di potere all’interno dell’UE. Sebbene i meccanismi di condizionalità abbiano chiaramente influenzato il comportamento politico, contribuendo in modo particolare al cambiamento elettorale e alle riforme giuridiche parziali in Polonia, essi hanno anche messo in luce la fragilità dell’autorità morale dell’UE. L’applicazione è stata disomogenea, la sua base giuridica contestata e le sue conseguenze politiche di vasta portata. Questo approccio ha suscitato legittimi timori di un’applicazione ideologica mascherata da controllo di bilancio e ha approfondito le divisioni tra i “vecchi” e i “nuovi” Stati membri. Anziché risolvere le controversie istituzionali, il ricorso alla sospensione dei finanziamenti ha rischiato di rafforzarle. Ha reso meno netta la linea di demarcazione tra diritto e politica, tra governance e coercizione. Il caso della Polonia è ora un punto di riferimento nella narrazione in evoluzione dell’integrazione europea: una storia non solo sulla difesa dei valori condivisi, ma anche su chi decide quali sono questi valori e a quale costo.




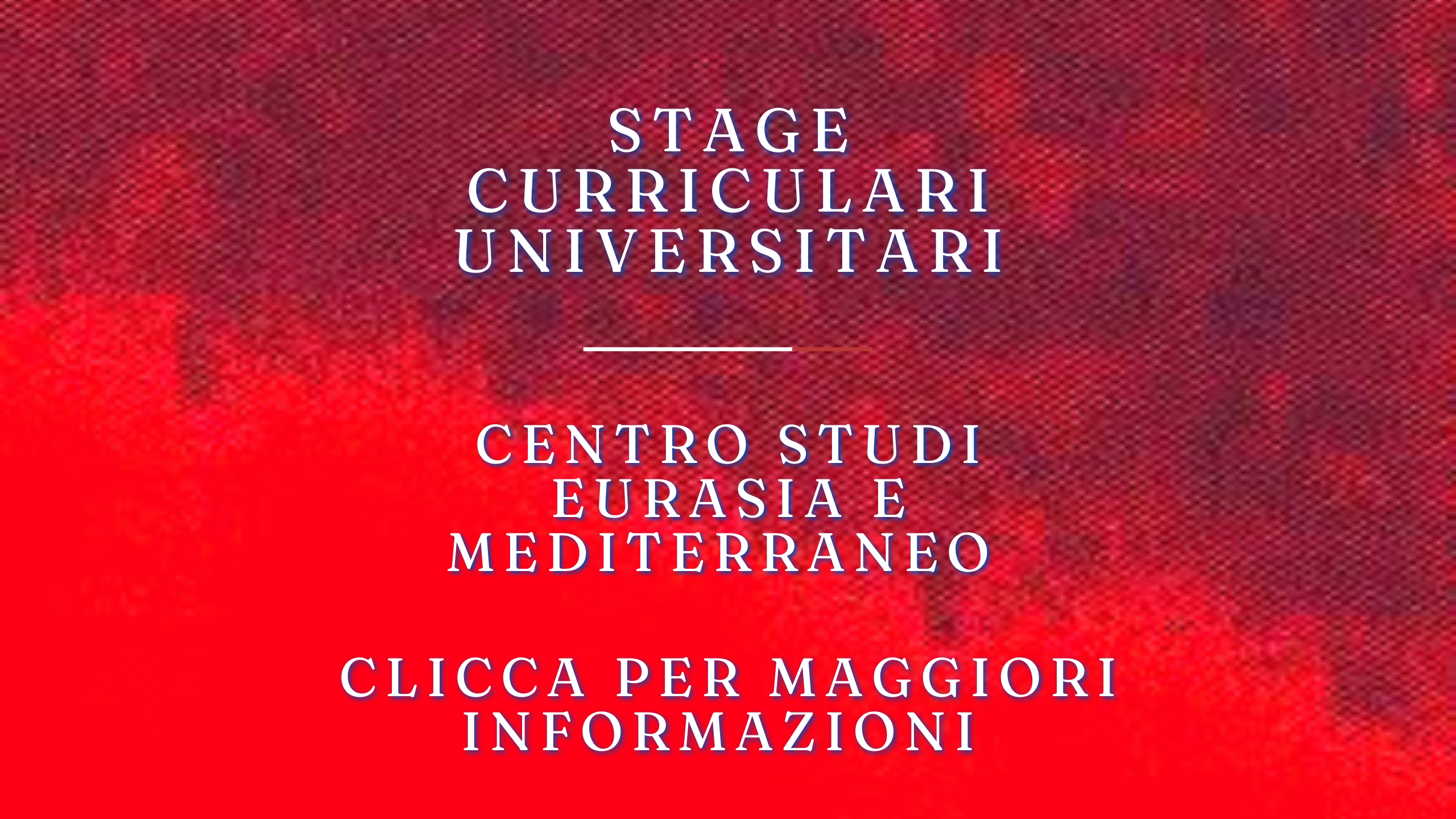

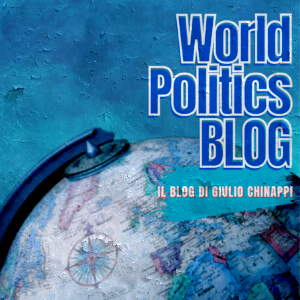
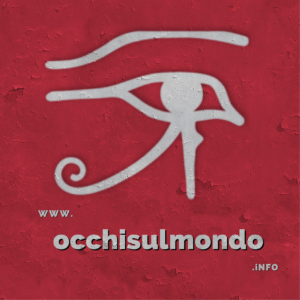









Il CeSE-M sui social