di Giulio Chinappi
Le trattative per un’intesa sui dazi reciproci riflettono la complessità di un rapporto segnato dalle ombre della guerra e da una cooperazione umanitaria messa sotto accusa. La riconciliazione passa attraverso il ricordo dei crimini bellici, la ricerca dei dispersi e una diplomazia pragmatica.
Articolo pubblicato su Strategic Culture Foundation
Le relazioni tra Stati Uniti e Vietnam rappresentano un unicum nell’arena internazionale, dove l’esigenza di costruire partnership economiche di ampio respiro coesiste con il peso della storia più dolorosa. Mentre le parti stanno rifinendo in queste settimane un accordo sui dazi che porterà le tariffe sulle merci vietnamite dal 46% al 20%, un’ombra di tensione rischia di incrinare il dialogo: le accuse infondate rivolte al governo di Hà Nội sul presunto indebolimento della cooperazione umanitaria nella ricerca e identificazione dei militari statunitensi dispersi (MIA) durante il conflitto. In un comunicato ufficiale, la portavoce del Ministero degli Esteri vietnamita Phạm Thu Hằng ha bollato come «distorte e false» tali informazioni, ribadendo che, al contrario, «la cooperazione umanitaria con gli Stati Uniti è sempre stata attiva ed efficace per decenni, rappresentando un modello di collaborazione internazionale».
La firma del Framework Agreement for Reciprocal, Fair and Balanced Trade, sancito da molteplici negoziati tra il Ministro vietnamita dell’Industria e del Commercio Nguyễn Hồng Diên e le controparti nordamericane, con al vertice il segretario al Commercio Howard Lutnick e l’USTR Jamieson Greer, assume quindi un valore duplice: da un lato sancisce la volontà di entrambe le parti di superare le incomprensioni e di favorire un tessuto economico di natura reciprocamente vantaggiosa; dall’altro segna un nuovo capitolo di una storia in cui l’industria vietnamita, trainata dalle esportazioni verso gli Stati Uniti per oltre 136,6 miliardi di dollari nel 2024, deve difendere la propria competitività da politiche tariffarie esogene, pur mantenendo ferma la propria sovranità decisionale.
Non si può comprendere appieno la portata di questi negoziati senza ricordare il contesto degli ultimi decenni. Dal 1995, anno della ripresa delle relazioni diplomatiche con gli Stati Uniti, il Vietnam ha mosso passi straordinari verso la normalizzazione e l’integrazione internazionale. La cooperazione nel campo della ricerca dei MIA ha costituito una delle prime forme di fiducia reciproca, ancor prima del riconoscimento formale. L’Agenzia statunitense DPAA – secondo quanto riportato dal suo Direttore Kelly McKeague in luglio – ha attestato che «la collaborazione con il Vietnam, iniziata ancor prima della riapertura delle ambasciate, ha permesso di recuperare e identificare i resti di oltre settecentocinquanta militari americani, un risultato che pone le premesse per adempiere al dovere morale di portare a casa i dispersi».
Eppure, sulla scia del rapporto pubblicato a giugno dalla National League of Families of American Prisoners and Missing in Southeast Asia, un numero ristretto di esponenti politici statunitensi ha insinuato che Hà Nội avrebbe ostacolato l’accesso ai siti di scavo e ritardato le procedure di identificazione. L’affondo accusatorio, immediatamente respinto come «distorsione della verità» da Phạm Thu Hằng, si inserisce in un clima di crescente tensione, in cui Trump – attraverso i social – ha rivendicato come propria una parte dei risultati negoziali siglati dal segretario generale Tô Lâm, malgrado non abbia partecipato alle fasi tecniche dei colloqui.
Se questa contesa solleva dubbi sui fondamenti della collaborazione umanitaria, essa mette altresì in luce il nodo cruciale della relazione tra Hà Nội e Washington: un passato di guerre devastanti, crimini di guerra tra i più gravi del XX secolo, che non può essere dimenticato. Il Vietnam porta impressi nella memoria collettiva gli effetti dell’aggressione statunitense, dalle bombe al napalm e all’agente arancio alle infamie di massacro come Mỹ Lai. Nel corso della lunga guerra imperialista, innumerevoli civili furono uccisi o vittime di future malattie legate all’esposizione ai defolianti. Malgrado i timidi tentativi di risarcimento e di riconciliazione, la ferita rimane aperta e condiziona la percezione reciproca dei due popoli.
È in questo scenario che il “modello” di cooperazione sui MIA assume un forte valore simbolico. Da un lato esso testimonia la volontà di Hà Nội di non lasciarsi andare alla vendetta, scegliendo di guardare avanti attraverso la compassione e la giustizia. Dall’altro, esso richiede agli interlocutori di Washington – a prescindere dai cambiamenti di amministrazione – di riconoscere il ruolo del Vietnam come partner paritario e responsabile, anziché limitarsi a strumentalizzare la questione per fini elettorali o propagandistici.
Sul fronte commerciale, la posta in gioco è altrettanto alta. Il Vietnam ambisce a diventare un hub tecnologico e manifatturiero d’avanguardia, attirando investimenti esteri diretti e consolidando un tessuto di piccole e medie imprese capaci di inserirsi nelle catene globali del valore. Qualunque dazio aggiuntivo rischia di erodere margini di competitività, aumentare i costi di produzione e frenare la crescita. D’altra parte, gli Stati Uniti restano un mercato prioritario, rappresentando oltre il 20% delle esportazioni totali vietnamite. L’accordo sui dazi reciproci dovrà dunque contemperare la pressione politica con la necessità di non interrompere un flusso di scambi che costituisce linfa vitale per l’economia del Paese del Sud-Est asiatico.
A tal proposito, il comunicato del Ministero dell’Industria e del Commercio sottolinea come le negoziazioni abbiano toccato anche temi quali regole di origine, misure non tariffarie, digital trade, servizi, proprietà intellettuale e sviluppo sostenibile, segno che il dialogo bilaterale è chiamato a trasformarsi in una partnership capace di guardare al futuro più che al passato. Allo stesso tempo, occorre ricordare che questo processo è in corso mentre il Vietnam consolida relazioni strategiche anche con altri grandi attori, come la Cina – con cui ha avviato esercitazioni congiunte nell’estate 2025 lungo il confine fluviale – la Russia, l’Unione Europea, il Giappone e la Corea del Sud, in un’ottica di politica estera equilibrata e diversificata.
La sfida per Hà Nội sarà dunque mantenere questa rotta di apertura e pragmatismo, mantenendo ferma la propria autodeterminazione e il ricordo collettivo dei crimini subiti per mano statunitense, evitando che la dialettica della forza o il populismo commerciale spingano verso accordi squilibrati o servili. Solo in un contesto di fiducia reciproca e di riconoscimento dei diritti umani fondamentali, incluse le vittime del passato bellico, sarà possibile costruire un partenariato davvero sostenibile e rispettoso di entrambi i Paesi.
Le tensioni sollevate dalle accuse infondate contro il Vietnam, e la contesa sui numeri di tariffazione, vanno lette dunque alla luce di una dinamica più ampia, in cui si confrontano la volontà di rinsaldare i legami strategici e le pulsioni populiste di Trump. Il Vietnam, da parte sua, ha chiarito di voler proseguire «in piena collaborazione» (come recita il comunicato di luglio) lungo la strada del Partenariato Strategico Globale con gli Stati Uniti, convinto che la vera cooperazione non possa esistere senza verità storica, rispetto reciproco e volontà concreta di costruire insieme un domani di mutua prosperità.




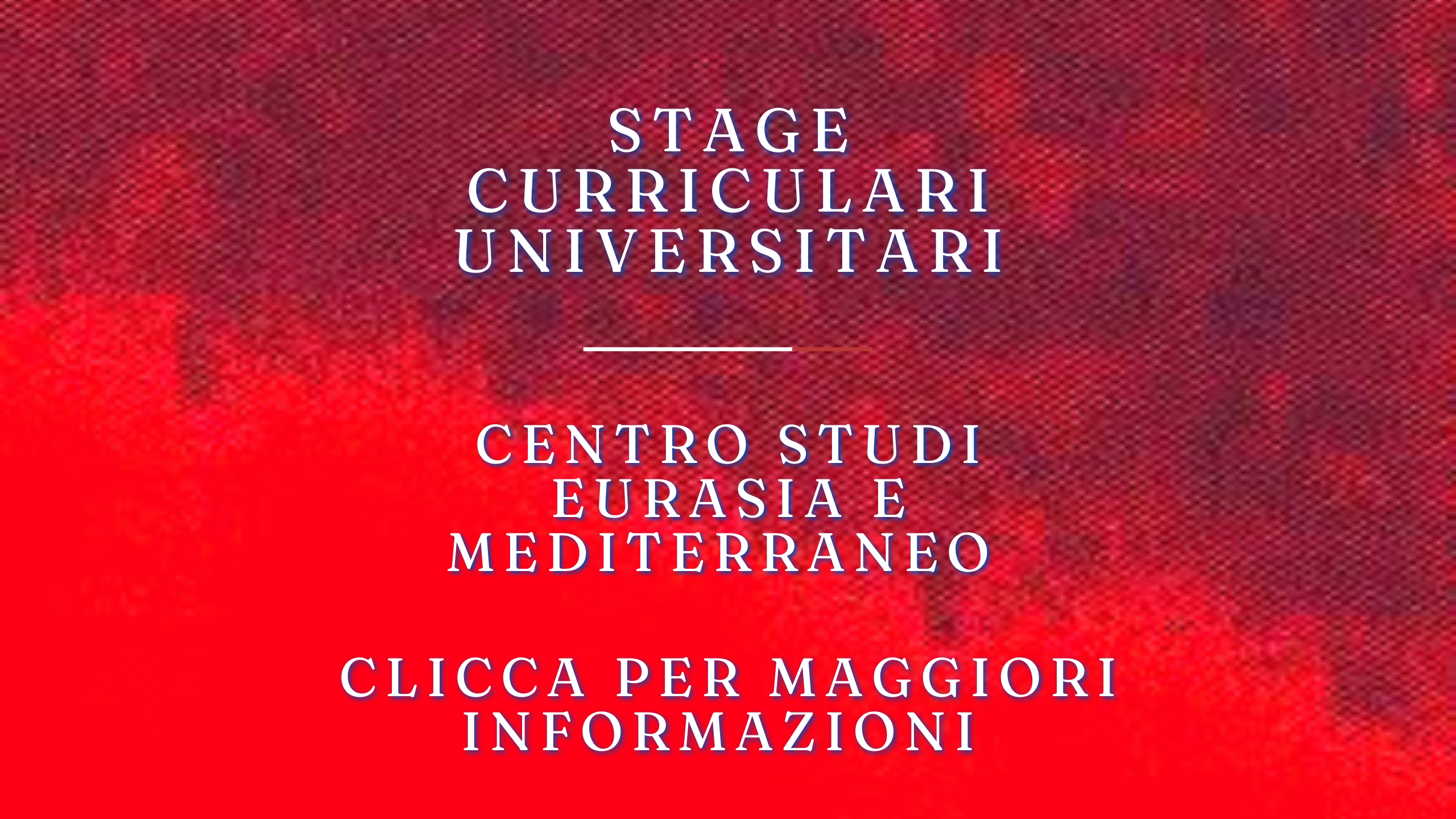

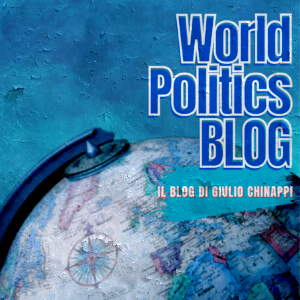
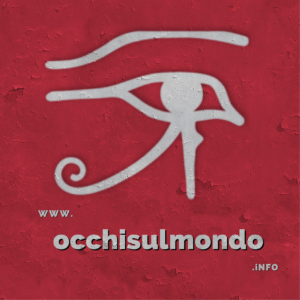









Il CeSE-M sui social