di Veronica Vuotto
Il vertice tra Cina e Unione Europea, svoltosi il 24 luglio 2025 a Pechino, si è tenuto in un momento di forti tensioni economiche e politiche, ma anche di tentativi, seppur timidi, di mantenere aperti i canali diplomatici. L’incontro, che celebrava formalmente i cinquant’anni di relazioni diplomatiche bilaterali, ha assunto nei fatti il carattere di un bilancio: non tanto una celebrazione, quanto una presa d’atto delle divergenze strutturali tra Bruxelles e Pechino.
Un contesto in evoluzione: segnali di disgelo e rapide inversioni
Fino alla primavera, sembrava profilarsi un moderato riavvicinamento. Il ritorno di Donald Trump alla presidenza degli Stati Uniti e la sua linea dura nei confronti della Cina avevano portato quest’ultima a intensificare i segnali di distensione verso l’Europa. In questo quadro, la presidente della Commissione Ursula von der Leyen aveva adottato toni più concilianti in occasione dei suoi interventi a Davos e a Bruxelles, aprendo a un rafforzamento delle relazioni economiche con Pechino, ma solo nel rispetto di regole più eque.
A fine marzo, il Commissario europeo al Commercio Maroš Šefčovič ha visitato la Cina per avviare un dialogo regolare con il suo omologo del MOFCOM, Wang Wentao. A seguito di colloqui definiti “costruttivi”, è stata confermata la volontà di tenere un vertice a fine luglio, accettando l’invito cinese a svolgerlo a Pechino.
Segnali positivi sono arrivati anche da parte cinese: a fine aprile, Pechino ha revocato le sanzioni imposte nel 2021 a parlamentari europei, rimuovendo uno degli ostacoli principali alla ratifica dell’Accordo globale sugli investimenti (CAI).
Tuttavia, il clima è nuovamente peggiorato a maggio, quando la Cina ha raggiunto un accordo con l’amministrazione Trump per una riduzione bilaterale dei dazi. Forte di questo successo, Pechino ha assunto un tono più rigido nei confronti dell’Europa, in particolare sulle tariffe contro il cognac introdotte in risposta ai dazi UE sui veicoli elettrici cinesi.
Nel frattempo, le restrizioni cinesi sull’export di terre rare hanno cominciato a colpire duramente l’industria europea, soprattutto nei settori dell’energia e dei dispositivi medici. La Cina ha assicurato che tali restrizioni erano rivolte agli Stati Uniti, ma ha anche lasciato intendere, in alcune conversazioni riservate, che il flusso di questi materiali strategici verso l’Europa dipenderebbe dalla rimozione dei dazi UE e da un allentamento del controllo sull’export di tecnologie avanzate.
Azioni europee e risposte cinesi: uno scambio di misure e contromisure
Le settimane precedenti al summit sono state segnate da un crescendo di azioni unilaterali. La Commissione ha attivato per la prima volta lo Strumento Internazionale per gli Appalti (IPI), escludendo i produttori cinesi di dispositivi medici dai grandi bandi pubblici europei, a causa delle discriminazioni subite dalle aziende europee in Cina.
In parallelo, nell’ambito del diciottesimo pacchetto di sanzioni contro la Russia, Bruxelles ha sanzionato per la prima volta due banche cinesi per aver facilitato scambi vietati con Mosca. Infine, von der Leyen ha criticato duramente la Cina al vertice del G7 in Canada, accusandola di “ricatto” attraverso l’uso delle terre rare come leva geopolitica.
Tutte queste mosse hanno provocato reazioni immediate da parte cinese, con restrizioni reciproche e la revoca dell’invito a Hefei per von der Leyen. Infatti, nonostante il vertice fosse inizialmente previsto per due giorni e dovesse tenersi in parte anche ad Hefei, città industriale nella provincia di Anhui, l’incontro è stato ridotto a una sola giornata a Pechino. Un segnale chiaro delle basse aspettative e del desiderio cinese di contenere il livello politico dell’evento: il presidente Xi Jinping ha incontrato i leader europei, ma ha lasciato gran parte della gestione al premier Li Qiang.
Il vertice: poche concessioni, tante divergenze
Il summit si è svolto in un clima cordiale ma privo di aspettative. Da parte europea, i vertici istituzionali hanno espresso con franchezza le preoccupazioni su commercio, accesso al mercato e geopolitica. Von der Leyen ha parlato di un “punto di svolta” e ha ribadito che la competizione è benvenuta, ma deve essere “leale e reciproca”.
Il presidente Xi Jinping, dal canto suo, ha invitato l’UE a “gestire con saggezza le divergenze” e ha sottolineato che “i problemi dell’Europa non vengono dalla Cina”. Ha ribadito l’importanza di mantenere i mercati aperti e ha criticato l’uso da parte dell’UE di strumenti “restrittivi e protezionistici”.
Unica intesa concreta: una dichiarazione congiunta sul clima, con l’impegno a proseguire la cooperazione in vista della COP30 e un generico impegno a semplificare le procedure per l’export di terre rare. Troppo poco per bilanciare gli squilibri commerciali o risolvere i nodi politici.
Una relazione asimmetrica in cerca di nuovi equilibri
Dal punto di vista cinese, il vertice ha rappresentato l’occasione per riaffermare il ruolo della Cina come attore globale indipendente, in un contesto internazionale segnato da instabilità. Pechino ha voluto mostrare fermezza, rifiutando l’idea di dover fare concessioni per mantenere la cooperazione con l’Europa. Per la leadership cinese, il vero partner strategico resta la Russia, con cui si intende consolidare un “modello alternativo di relazioni tra grandi potenze”.
In questo scenario, la posizione europea appare indebolita, anche per l’incertezza transatlantica. Il ritorno di Trump e l’escalation dei dazi USA hanno lasciato l’UE in bilico tra due giganti: Washington e Pechino. La Cina, da parte sua, punta a sfruttare questa ambiguità per dividere il fronte europeo e negoziare direttamente con gli Stati membri più ricettivi, come Ungheria e Grecia, dove gli investimenti cinesi restano alti.
Prospettive: dialogo necessario, ma senza illusioni
Il summit ha confermato che, nonostante le differenze strutturali e le tensioni in corso, il dialogo tra Cina e Unione Europea rimane fondamentale. Entrambe le parti si sono presentate a Pechino con richieste precise e posizioni consolidate, ma hanno anche dimostrato la volontà di mantenere aperti i canali diplomatici e di evitare un’escalation che non conviene a nessuno.
In questo contesto, l’approccio espresso dalla leadership cinese, basato sulla ricerca di un terreno comune pur riconoscendo le divergenze (qiútóng cúnyì, 求同存异), ha trovato una parziale eco nelle parole della presidente Von der Leyen, che ha auspicato soluzioni pragmatiche e cooperative. Questo avvicinamento retorico può essere interpretato come un primo segnale di maturazione del rapporto bilaterale: non più fondato su illusioni o aspettative irrealistiche, ma su un confronto diretto e consapevole.
Per la Cina, il vertice ha rappresentato anche l’occasione per riaffermare la propria visione di un ordine internazionale multipolare, fondato sul rispetto reciproco, sulla non ingerenza e sulla coesistenza tra modelli diversi. Se l’Unione Europea saprà adottare un atteggiamento più equilibrato, evitando approcci conflittuali o misure unilaterali, sarà possibile sviluppare una cooperazione più stabile, orientata alla gestione condivisa delle sfide globali.
In definitiva, il summit di Pechino non ha risolto i nodi più complessi della relazione, ma ha ribadito l’importanza di affrontarli con pazienza strategica e spirito costruttivo. In un mondo sempre più instabile, la capacità di Cina e UE di trovare un linguaggio comune, pur nella differenza, sarà decisiva non solo per i rapporti bilaterali, ma per l’equilibrio globale del futuro.




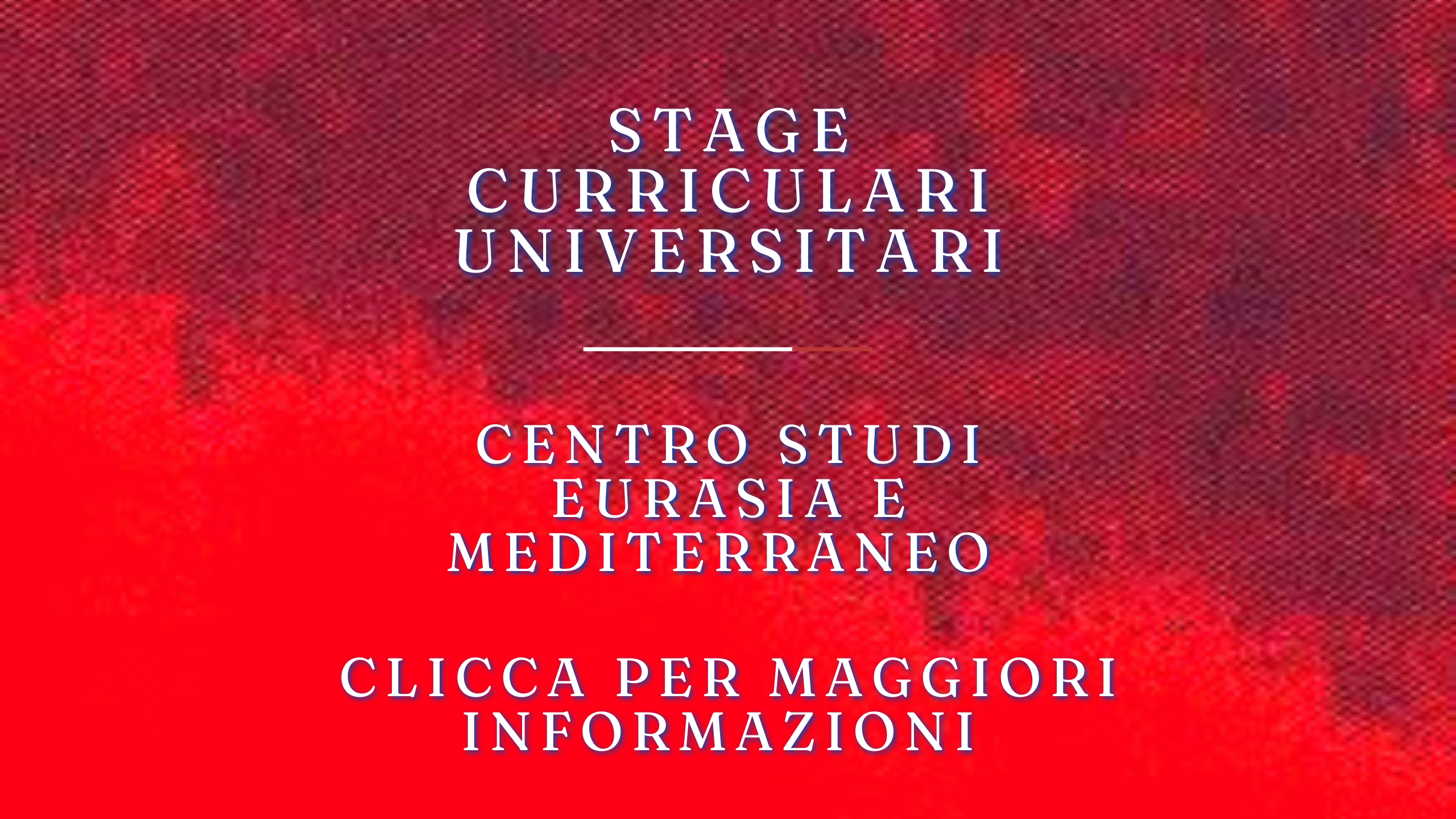

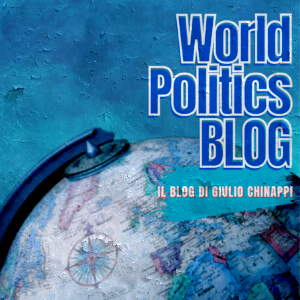
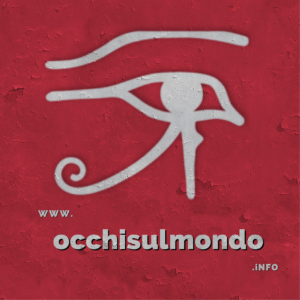









Il CeSE-M sui social