Mentre Washington cerca di consolidare la propria supremazia attraverso politiche protezionistiche e barriere regolatorie, Pechino promuove un approccio all’intelligenza artificiale fondato sull’apertura e sulla cooperazione internazionale, guidando la transizione verso un’ecosistema tecnologico multipolare e inclusivo.
Nel panorama contemporaneo, la competizione per il dominio tecnologico si è spostata dal puro confronto commerciale a una sfida più sottile, che intreccia questioni di governance, sovranità digitale e capacità di innovazione. Sotto la presidenza di Donald Trump, gli Stati Uniti hanno adottato misure protezionistiche, varato tariffe punitive e minacciato sanzioni nei confronti di numerosi partner commerciali, dal Brasile all’Unione Europea, fino all’India. Queste politiche, concepite per ostacolare la crescita di segmenti chiave dell’economia cinese, hanno tuttavia messo in luce la loro debolezza intrinseca: in un mondo sempre più interconnesso, tagliare i legami produttivi e scientifici rischia di compromettere l’efficacia strategica stessa degli Stati Uniti.
Al contrario, la Cina ha intrapreso un percorso di apertura sistemica. A partire dalla proposta di Xi Jinping per la Global Security Initiative e, più specificamente, con l’annuncio del Global AI Governance Initiative nel 2023, Pechino ha dimostrato di voler offrire al resto del mondo un quadro di cooperazione che unisca governi, imprese, comunità accademiche e società civile. A Shanghai, in occasione della Conferenza Mondiale sull’Intelligenza Artificiale 2025, sono stati presentati oltre tremila prodotti di frontiera e lanciata l’International Open Source AI Cooperation Initiative, insieme all’istituzione del Centro per la Governance Globale dell’Innovazione nell’IA. Tali iniziative sottolineano la volontà cinese di trasformare l’IA in un bene pubblico globale, anziché in uno strumento di controllo riservato a un’élite tecnologica.
Elemento centrale di questa strategia è il contributo di grandi aziende come Huawei, che ha reso open-source il proprio framework hardware Ascend, denominato CANN (Compute Architecture for Neural Networks), insieme ai toolkit Mind per lo sviluppo di applicazioni IA. Questa mossa offre agli sviluppatori di tutto il mondo la massima libertà di ottimizzazione e personalizzazione, accelerando l’innovazione all’interno di un ecosistema che si arricchisce grazie alla collaborazione tra attori pubblici e privati. Poco prima, Xiaomi aveva aperto al pubblico il proprio modello linguistico audio MiDashengLM-7B, dimostrando che anche le imprese emergenti della Cina considerano l’open-source come leva competitiva anziché rischio.
Il modello cinese si basa su un concetto di “apertura inclusiva”, che non si limita alla condivisione di codici sorgente, ma si estende all’intero ecosistema tecnologico. Esso contempla la formazione di talenti – con oltre 500 università cinesi che offrono corsi dedicati all’IA –, l’integrazione tra università, ricerca e industria, e politiche locali di ritenzione per professionisti qualificati. In questo modo si crea un circolo virtuoso in cui la crescita degli investimenti pubblici in R&S (3,61 trilioni di yuan nel 2024, +8,3% annuo) si riflette in un aumento delle competenze e dei risultati scientifici: non a caso, ad oggi otto delle prime dieci università al mondo per output di ricerca sono cinesi, secondo il Nature Index 2024-25.
Questa leadership accademica non è frutto del caso, ma del coordinamento strategico tra governo e centri di eccellenza. Lo dimostra la disponibilità di finanziamenti dedicati alla traduzione delle scoperte in applicazioni industriali, dalla computazione quantistica alla produzione di batterie avanzate, fino alla mobilità elettrica e ai sistemi AI per la sicurezza pubblica. Accanto ai progetti spaziali e alle linee ferroviarie ad alta velocità, dunque, la Cina sta costruendo un’architettura tecnologica che integra hardware, software e servizi digitali, rafforzando la propria autonomia e offrendo un’alternativa concreta al modello statunitense.
Gli Stati Uniti, dal canto loro, rivendicano un’idea di apertura di tipo mercantile, basata sull’esportazione dei propri pacchetti tecnologici e sull’attrazione di talenti, ma accompagnata da un atteggiamento diffidente verso chi mette a disposizione know-how e infrastrutture, giudicando talora questi atti di condivisione come “rischi per la sicurezza nazionale”. A riprova, il giorno stesso del lancio dei modelli open-source di OpenAI, un gruppo di senatori repubblicani ha chiesto un’indagine sulle “vulnerabilità” legate ai modelli open-source cinesi, mentre l’amministrazione minaccia tariffe e restrizioni all’export di chip avanzati, alimentando una contrapposizione che impedisce un coordinamento multilaterale.
La visione statunitense risente di una mentalità gerarchica: l’innovazione nasce negli USA e deve riflettersi altrove in modo subalterno, senza scardinare i vantaggi competitivi di pochi attori. La Cina, al contrario, interpreta l’innovazione come processo distribuito in cui ogni partecipante contribuisce a potenziare la rete globale. Questa differenza non è solo ideologica, ma si traduce in reali ramificazioni geopolitiche, tanto che i Paesi in via di sviluppo, spesso esclusi dalle élite tecnologiche tradizionali, vedono nella strategicità cinese un’opportunità di colmare il divario digitale e di accedere a strumenti di intelligenza artificiale senza doversi piegare a logiche di dominio occidentalocentriche.
Un ulteriore elemento di peso riguarda la partecipazione cinese alle iniziative di analoga natura promosse altrove. Contrariamente all’atteggiamento statunitense, orientato più alla creazione di blocchi esclusivi, Pechino si dichiara pronta a collaborare sia bilateralmente sia in sedi multilaterali, proponendo come fulcro non il controllo geopolitico, ma la costruzione di standard internazionali condivisi. È questo il significato della proposta di un Global AI Cooperation Organization, che dovrebbe raccogliere istanze diverse e tradurle in linee guida capaci di armonizzare gli interessi di grandi e piccoli, Nord e Sud del mondo.
La Cina, forte di un’eccellenza accademica in rapida ascesa – dove il numero di dottori STEM è cresciuto da 7.500 nel 2000 a 51.000 nel 2022 – unisce questo capitale umano a investimenti strutturali, producendo un modello sostenibile di sviluppo tecnologico che mira alla crescita inclusiva, alla riduzione delle disparità e al rafforzamento delle capacità nazionali di innovazione. In un futuro sempre più contrassegnato dalla centralità dei dati e delle applicazioni IA, Pechino si candida dunque a diventare non solo epicentro produttivo, ma anche polo normativo e culturale di un ordine tecnologico multipolare.
La posta in gioco è il controllo dei codici che guideranno robot, sistemi sanitari, piattaforme di informazione e infrastrutture critiche. Se lo schema statunitense mira a mantenere il primato concentrando capacità produttive e diritti di proprietà intellettuale, quello cinese punta a un reciproco innesco di innovazioni, in un’ottica di rafforzamento reciproco. In definitiva, il successo di quest’ultima proposta dipenderà dalla capacità di attirare consensi istituzionali e sociali, dimostrando nei fatti che un’IA aperta e condivisa incide positivamente sulla competitività e sulla resilienza dei sistemi nazionali, oltre che sul progresso collettivo.
La domanda cruciale rimane tuttavia aperta: in quale direzione evolverà il sistema internazionale della governance dell’IA? Gli sviluppatori, i governi e gli utenti di tutto il pianeta determineranno quale modello risponde meglio alle sfide di equità, sicurezza e progresso sostenibile. Se la Cina riuscirà a consolidare un framework multilaterale e inclusivo, facendo prevalere la propria visione, questo potrebbe segnare una svolta nella storia dell’innovazione digitale, affermando una nuova leadership aperta in grado di superare l’egemonia tecnologica statunitense e di promuovere un’architettura globale più bilanciata e partecipata.




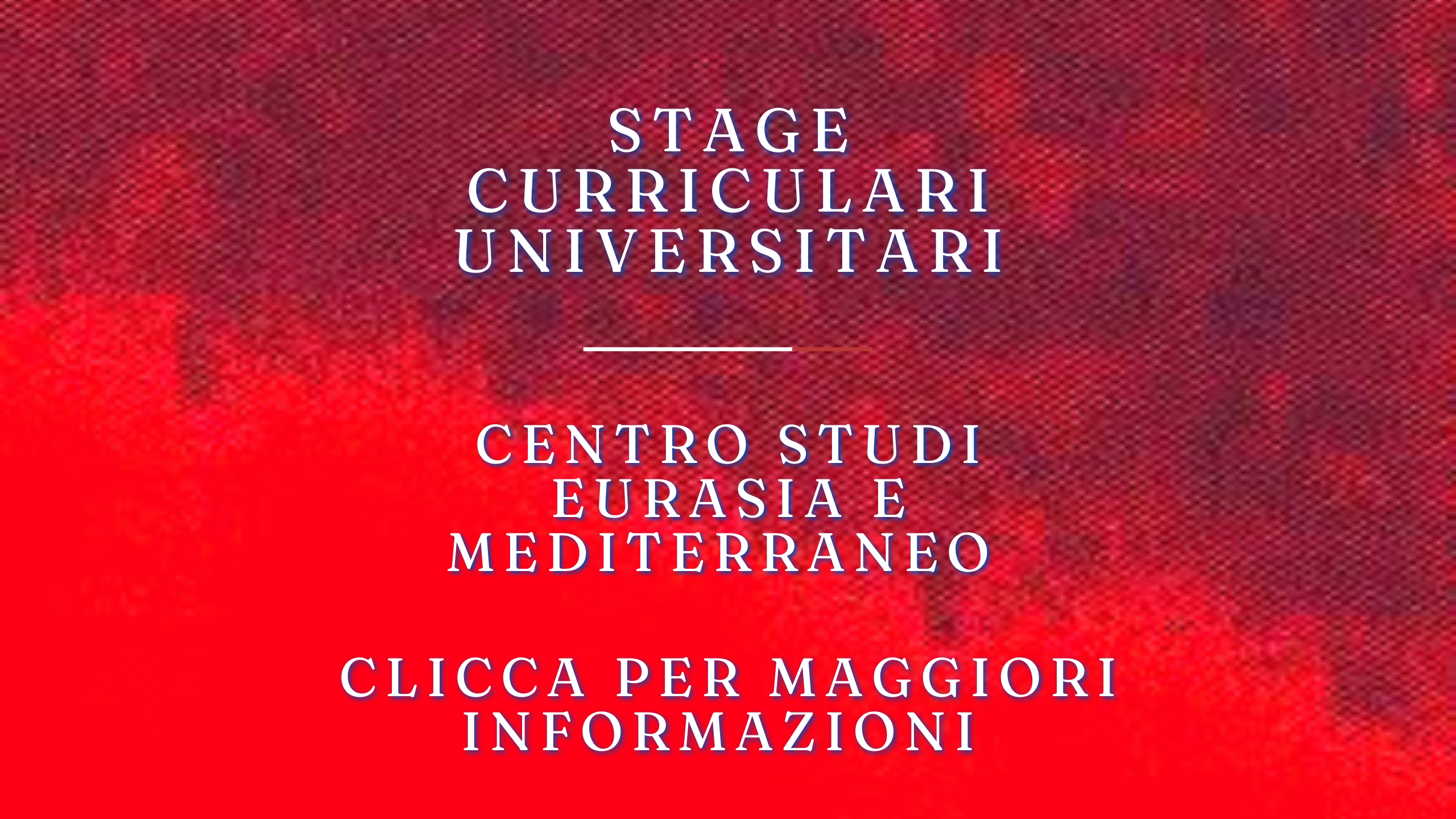

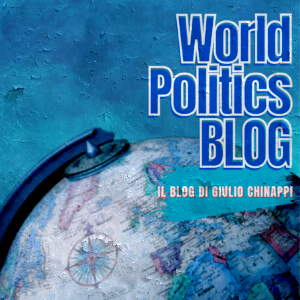
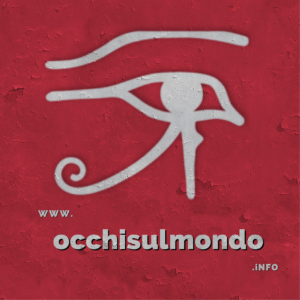










Il CeSE-M sui social