a cura di Stefano Vernole
Su invito del filosofo bielorusso Aleksej Dzermant, Stefano Vernole Vicepresidente del CeSEM e Stefano Bonilauri direttore di Anteo Edizioni sono intervenuti al Forum Internazionale dei Nuovi Sciti il 13 giugno a Minsk, dove hanno parlato della visione eurasiatista e multipolare vista dall’Italia.
Negli ambienti dell’emigrazione russa dopo la Prima Guerra Mondiale si formò un nucleo di pensatori che rifiutavano di guardare alla Russia come periferia dell’Occidente e che invece consideravano più vicini alla propria mentalità culture e popoli come quelli degli Slavi orientali, degli ugro-finnici, dei turchi, caucasici, siberiani e nordici fino a prefigurare una civiltà autonoma e a sé stante. Di tale gruppo i nomi più importanti sono: Trubetskoij, Savitskij, Florovskij, Suvcinskij, Karsavin, Vernadskij e già allora previdero un ritorno della Russia ai valori tradizionali e l’affermazione di un mondo multipolare in contrapposizione al tentativo dell’Occidente di imporre valori e norme comuni, a proprio vantaggio, a tutta l’Umanità. Le loro idee si basavano sul superamento dell’eurocentrismo e sul riconoscimento che in Eurasia avrebbero dovuto coesistere in armonia e in parità di condizioni una moltitudine di popoli e culture in virtù dell’appartenenza ad un unico spazio storico e geografico condiviso, concetti poi sviluppati da Lev Gumilev e dalla sua teoria della passionarietà. L’eurasiatismo russo si è collegato ad una corrente impropriamente definita panslavista che ha visto al centro autori come Dostoevskij, Leontev e Danilevskij, più recentemente Aitmatov, Panarin ecc.
La visione eurasiatista si caratterizza perché considera positivo il periodo dell’Orda d’Oro e dell’influenza turco-mongola sulla Russia; l’Impero mongolo non fu solo protagonista del commercio intercontinentale ma favorì lo scambio interculturale con una sintesi tra popoli nomadi e sedentari.
I fondamenti della civiltà eurasiatica, mantenuti durante l’evoluzione dello Stato russo, furono: il valore della statualità e di una cultura eurasiatica unificata; il forte potere centralizzato e lo Stato quale famiglia allargata; la conservazione dell’unicità etno-culturale dei territori e dei popoli dell’Eurasia, il concetto del servizio quale desiderio di realizzare un’ideale. Il culto del cameratismo, del collettivismo e della libera scelta degli amici sono intrinseci in tutti i popoli eurasiatici. La visione imperiale di Mosca permette di integrare e armonizzare le differenze etno-culturali e religiose dei popoli che abitano il continente.
Tali principi si sono più o meno mantenuti anche durante il periodo sovietico, quando Mosca con Lenin tornò ad essere capitale e punto di riferimento per i popoli eurasiatici, uniti in numerosi ambiti: linguistico, scientifico e tecnologico.



Mentre l’Ortodossia grazie alla Grande Guerra Patriottica venne gradualmente recuperata, seppure non in contrasto con la rifioritura dell’Islam, del buddismo o dell’ebraismo in nome dei valori tradizionali comuni. Un ruolo significativo nella visione eurasiatica lo ha fornito infatti anche l’eredità dell’Impero Bizantino, l’autoconsapevolezza della Russia come ultima roccaforte dell’Ortodossia e successore dell’Impero Romano d’Oriente: il concetto di Terza Roma, espresso all’inizio del XVI secolo dal monaco Filoteo, enfatizzò il ruolo messianico di Mosca. La sincera fede in Dio e la ricerca del bene assoluto ben sintetizzate dal regista Nikita Mikhalkov: “Per l’Occidente la legge è Dio, per la Russia, Dio è la legge”.
Dopo lo smantellamento dello Stato sovietico nel 1991, l’integrazione eurasiatica è continuata con la formazione della Comunità degli Stati Indipendenti (CSI) che tuttavia non avuto una grande fortuna.
I principi economici dell’eurasiatismo degli anni Venti hanno invece trovato oggi la loro espressione concreta nell’istituzione di un organismo quale l’Unione Economica Eurasiatica (Russia, Kazakhstan, Bielorussia, Kirghizistan ed Armenia) e il loro logico sviluppo nell’Organizzazione per la Cooperazione di Shangai (passata dai 6 membri iniziali Cina, Russia, Kazakistan, Kirghizistan, Tagikistan e Uzbekistan ai 10 attuali con India, Pakistan, Iran e Bielorussia più Afghanistan e Mongolia osservatori e altri 14 Stati, dall’Asia al Medio Oriente (tra cui Turchia, Egitto, Arabia Saudita e Qatar), come “partner di dialogo”, cioè Paesi affiliati all’Organizzazione).
In particolare, l’Unione Economica Eurasiatica, le cui caratteristiche principali sono: un sistema di organi sovranazionali; il consenso di tuti gli Stati membri per l’adozione delle decisioni fondamentali; lo sviluppo di un proprio quadro giuridico sovranazionale; libera circolazione di beni, servizi, lavoro e capitali sul territorio degli Stati membri; il trasferimento di una serie di competenze a livello sovranazionale (regolamentazione tariffaria, antitrust …), parità di diritti al lavoro e sociali di base per tutti i membri; priorità del diritto dell’Unione rispetto a quello nazionale; un meccanismo giuridico formale per la risoluzione delle controversie interne.
La UEE ha una legislazione doganale unificata e 52 regolamenti tecnici i cui requisiti coprono l’85% dei prodotti che circolano all’interno dell’Unione, ed è completamente autosufficiente per gas, petrolio, elettricità, fertilizzanti minerali, grano, patate e prodotti zootecnici. L’obiettivo è quello di creare un’area comune di approvvigionamento garantito di risorse chiave e uno spazio comune di trasporto e logistica, un’area comune di cooperazione industriale e sviluppo tecnologico facilitati dall’appartenenza millenaria all’Eurasia settentrionale. Oltre il 90% dei pagamenti tra i membri avviene nella moneta nazionale e sono state create la Banca eurasiatica di sviluppo e il Fondo eurasiatico per la stabilizzazione e lo sviluppo. Quasi l’80% della popolazione ha accesso a Internet (la media mondiale è intorno al 70%).
Un elemento caratterizzante dell’etica eurasiatica del duro lavoro è la sua differenza da quella del lavoro metodico, ed è direttamente influenzata dalla storica minaccia dell’Occidente: si tratta di un’etica emergenziale, veemente, basata sul lavoro intensivo per un breve periodo di tempo, seguito da un lungo periodo di riposo.
Obiettivi dell’UEE
Garantire entro il 2030 la libera circolazione, senza eccezioni e restrizioni, di beni, servizi, capitali e lavoro nel mercato comune degli Stati membri dell’Unione sulla base dell’armonizzazione degli approcci allo sviluppo dell’istruzione, della scienza, della sanità e della P.A.
Realizzare entro il 2045 la trasformazione dell’UEE in una macroregione autosufficiente, sicura, armoniosamente sviluppata e attraente per tutti i Paesi del mondo multipolare, garantendo un elevato livello di benessere alla popolazione dei suoi Stati membri.
Orientamento geopolitico verso Est e verso Sud: il declino economico, il calo dei redditi reali e i processi demografici negativi ridurranno l’importanza del mercato europeo, che però continuerà a svolgere un ruolo significativo nel commercio internazionale; la Transsib (o Transiberiana) collega i porti marittimi dell’Estremo Oriente e i valichi di frontiera sui confini russo-cinesi e russo-mongoli, oltre al corridoio eurasiatico centrale, attraverso il quale passa attualmente il flusso principale di container, attraverso i valichi di frontiera di Dostyk e Altynkol e la rotta di trasporto internazionale Europa-Cina occidentale.
La crescita economica e demografica del Sud globale determina la necessità di creare un’infrastruttura adeguata a collegarlo all’Eurasia settentrionale. Oltre al Corridoio Nord-Sud, Russia e CSI stanno lavorando a: il miglioramento delle infrastrutture di trasporto e logistica nella regione settentrionale del Mar Nero, collegandosi con Turchia, Africa e America Latina; Corridoio di trasporto internazionale del Mar Caspio, costituito da due rotte terrestri e una marittima. Tutte e tre accedono ai porti marittimi iraniani sul Golfo Persico e sull’Oceano Indiano, collegando l’Eurasia settentrionale con il Pakistan, l’India, il Sud-Est asiatico, il Golfo Persico e l’Africa; il corridoio di trasporto stradale internazionale nord-sud dall’Iran verso la Russia attraverso Armenia e Georgia; i sistemi di trasporto ferroviario, stradale e di oleodotti attraverso la Mongolia verso la Cina e il Sud-Est asiatico; lo sviluppo di corridoi di trasporto internazionale su strada e ferrovia che dalla Russia attraversano l’Asia centrale e l’Afghanistan (grazie alla vittoria dei Talebani) verso il Pakistan e l’India (incubo geopolitico USA): questa sarà la via di trasporto più breve che collegherà le regioni industriali e agricole russe con i maggiori mercati di consumo del Pianeta.
Problematiche dell’UEE
Se l’ UEE ha raggiunto l’autosufficienza su cereali e diversi tipi di carne, latte, patate, verdure … la soluzione al problema della sicurezza alimentare è strettamente legata al miglioramento dell’efficienza della gestione dell’acqua e dell’energia e all’uso di tecnologie per il risparmio idrico. L’Asia centrale è una delle regioni più vulnerabili ai cambiamenti climatici e le risorse alimentari, idriche ed energetiche sono particolarmente sensibili alle sfide climatiche. La scarsità d’acqua nella regione è in gran parte dovuta ad una cattiva organizzazione dell’uso dell’acqua in agricoltura e nell’industria, nonché alle condizioni insoddisfacenti delle infrastrutture idriche e ai fondi insufficienti stanziati per la loro manutenzione e il loro sviluppo. I Paesi dell’Asia centrale cooperano ancora poco tra di loro e i problemi sono aggravati dalla crescita della popolazione, dall’urbanizzazione e dall’irrigazione che consuma il 79% dell’acqua utilizzata nella regione.
Compiti prioritari dell’integrazione eurasiatica: approcci per la cooperazione tra Stati membri dell’UEE su agenda climatica, creazione, implementazione e uso congiunto di tecnologie per sviluppo di un’economia a basse emissioni di carbonio; meccanismi di regolamentazione del carbonio e armonizzazione dei sistemi nazionali; implementazione di tassonomie verdi; aumento dell’efficienza energetica; utilizzo dell’energia nucleare e introduzione di tecnologie ad alta efficienza energetica. L’Eurasia settentrionale (e l’America Latina) sono i territori maggiormente ricchi delle risorse limitate e necessarie alla transizione energetica: litio, rame, nichel, cobalto e alluminio, il cui accesso va affrontato congiuntamente, così come la sicurezza dei corridoi di straporto necessari al loro spostamento.
Oltre alla zona di libero scambio con l’Iran, sono in corso negoziati per un accordo anche con Egitto, India, Indonesia ed Emirati Arabi Uniti, con l’obiettivo strategico di formare uno spazio economico comune della Grande Eurasia, quale alternativa alla macroregione anglosassone con U.S.A., Canada, Regno Unito, Australia e Nuova Zelanda. Il blocco atlantico cercherà di sfruttare al massimo le divisioni del continente eurasiatico, dal momento che al suo interno tutti i problemi sono collegati tra di loro e possono essere risolti solo congiuntamente. Per sbloccare il potenziale della Russia e dell’Asia centrale è necessario creare almeno altri due corridoi logistici: uno ferroviario, stradale ed energetico per collegare la Russia settentrionale egli Urali industriali all’India e al Pakistan attraverso Kazakistan, Uzbekistan, Turkmenistan e Afghanistan; il secondo dovrebbe aprire lo spazio della Siberia centrale con un ponte ferroviario ed energetico dalla regione di Krasnoyarsk e dall’Altai attraverso la Tuva e la Mongolia fino alla Cina occidentale e centrale, collegandosi con la rotta commerciale cinese verso l’Asia centrale.
La bipolarità russa e i suoi dilemmi
La Russia, tradizionalmente, mira a migliorare la propria connettività con le coste europee riducendo la propria dipendenza sui vicini ostili e inaffidabili come i Paesi Baltici, perciò Mosca ha costruito e ammodernato negli anni porti e terminali sulla parte del proprio territorio del Mar Baltico e del Mar Nero, sebbene le sanzioni occidentali ne abbiano ridotto l’attività. Il porto di Crimea, in particolare, è dedicato alle missioni militari in Siria e in Libia e per aggirare le sanzioni occidentali all’Iran. Collegando il Mar Nero al Mar d’Azov (di cui la Russia ha assunto il totale controllo con La S.M.O.) Mosca trarrebbe enormi benefici (da qui l’importanza di Odessa).
Al vertice dell’UEE del 2018, il Kazakistan ha proposto la costruzione di un Canale dell’Eurasia, ovvero un corridoio di navigazione lungo i fiumi che vanno dal Mar Caspio al Mar Nero e che arrecherebbe enormi benefici commerciali ai Paesi rivieraschi e alla Cina. Questo Canale potrebbe essere incorporato progressivamente nel Corridoio di trasporto internazionale Nord-Sud e creerebbe 200.000 nuovi posti di lavoro. Una parte significativa del traffico merci tra la Cina e i Paesi della UE che hanno porti sul Mediterraneo beneficerà di questa nuova rotta. Se la Russia avesse perso il controllo di questa zona, avrebbe indebolito la propria capacità di connettere l’entroterra continentale eurasiatico alla periferia marittima.
Al vertice EAEU dell’8 maggio 2023, il presidente Kassym-Jomart Tokayev ha suggerito di implementare un meccanismo per la convalida remota di tutti i documenti di spedizione utilizzando codici QR e il riconoscimento reciproco dei documenti digitali come mezzo per facilitare il processo. Questa iniziativa di digitalizzazione andrà a beneficio del commercio estero aumentando il volume, semplificando le procedure di attraversamento delle frontiere, riducendo i tempi di consegna delle merci e abbassando i costi di trasporto. Per mantenere il funzionamento ininterrotto del sistema di trasporto eurasiatico, il Kazakistan intende effettuare riparazioni su 11.000 km e costruire altri 5.000 km di nuovi binari ferroviari. La nazione ha avviato un ammodernamento completo dei valichi di frontiera internazionali. Negli ultimi 15 anni, il Paese ha investito oltre 35 miliardi di dollari in infrastrutture di trasporto, migliorando la connettività con Cina, Asia meridionale, Russia ed Europa. Per accedere ai mercati del Golfo Persico, il Kazakistan ha aderito all’accordo di Ashgabat sulla creazione di un corridoio di trasporto internazionale e invita i partner della UEE a fare altrettanto. Ricordiamo che l’accordo sulla creazione di un corridoio internazionale di trasporto e transito tra Iran, Oman, Turkmenistan e Uzbekistan (Accordo di Ashgabat) è stato firmato nel 2011. Successivamente hanno aderito all’accordo anche Kazakistan, Qatar e India.
Logica tellurocratica delle rotte eurasiatiche
Questi progetti dovrebbero aumentare significativamente la competitività della logistica terrestre continentale rispetto alle rotte commerciali marittime tradizionalmente appannaggio delle potenze talassocratiche. Con lo sviluppo interno dell’Eurasia, il percorso terrestre delle merci diverrà significativamente più breve rispetto a quello marittimo e consentirà una forte ottimizzazione dei tempi di trasporto; il percorso terrestre intercontinentale, così come quello della Northern Sea Route (Rotta Artica), appaiono molto più sicuri delle rotte tradizionali del traffico marittimo vista la crescente instabilità degli Stretti di Malacca, Bab-el-Mandeb, Hormuz e del Canale di Suez.
Il fattore principale della competitività delle rotte continentali attraverso i Paesi dell’Unione Eurasiatica potrebbe essere una combinazione di tecnologia senza equipaggio ed energia a basso costo: l’eccedenza di energia e gli inevitabili progressi nello stoccaggio e nel trasporto, insieme ai costi minimi della manodopera grazie alle tecnologie senza pilota, offrirà prezzi altamente competitivi rispetto a quelli mondiali. L’Unione Economica Eurasiatica è il naturale interconnettore dei sistemi energetici continentali del futuro; i corridoi di trasporto più sicuri e brevi passano attraverso il suo spazio: dalla Via della Seta nel Sud, alla Rotta Artica nel Nord. Costruendo un sistema di adeguata sicurezza nella macroregione eurasiatica, al riparo dalle perturbazioni esterne, può tramutarla nel luogo più sicuro per le persone e per gli investimenti.
Il programma minimo dell’Unione Economica Eurasiatica dovrebbe essere quello di aumentare il suo attuale potenziale demografico da 200 milioni ad almeno 300 milioni di persone, la dimensione minima del mercato in cui è possibile creare imprese regionali competitive al reddito pro capite previsto, fino alla creazione di un mercato comune di almeno 700 milioni di consumatori. La Russia, in particolare, deve superare gli ostacoli alla natalità: quello psicologico, come la mancanza di una visione positiva del futuro, il rimpatrio dei connazionali e la gestione organica dell’immigrazione grazie all’eccellenza del sistema educativo russo.
In definitiva, le élite eurasiatiche devono comprendere chiaramente che gli attori extraregionali che li corteggiano attivamente nella regione e cercano ad esempio di seminare zizzania tra Russia e Cina in Asia centrale, non hanno interessi a lungo termine se non quello di ottenere un accesso garantito a prezzi agevolati alle risorse della regione. Il loro compito è quello di creare la Grande Eurasia in sinergia con la Cina.
Il Grande Partenariato Eurasiatico è un progetto sviluppato da un gruppo di analisti russi coordinati dal Presidente onorario del Consiglio per la politica estera e di difesa di Mosca, prof. Sergei Karaganov, per divenire parte della linea politica ufficiale enunciata da Vladimir Putin al Forum di San Pietroburgo del 25 giugno 2016. Nel rinnovato concetto di politica estera legiferato dal Cremlino con decreto presidenziale n. 229 del 31 marzo 2023: “La Russia si è definita autentico Paese-civiltà, vasta potenza eurasiatica ed euro-pacifica, roccaforte del Mondo russo, uno dei centri sovrani dello sviluppo mondiale, che svolge un ruolo esclusivo nel mantenere l’equilibrio globale delle forze e nell’assicurare lo sviluppo pacifico e progressivo dell’umanità”.




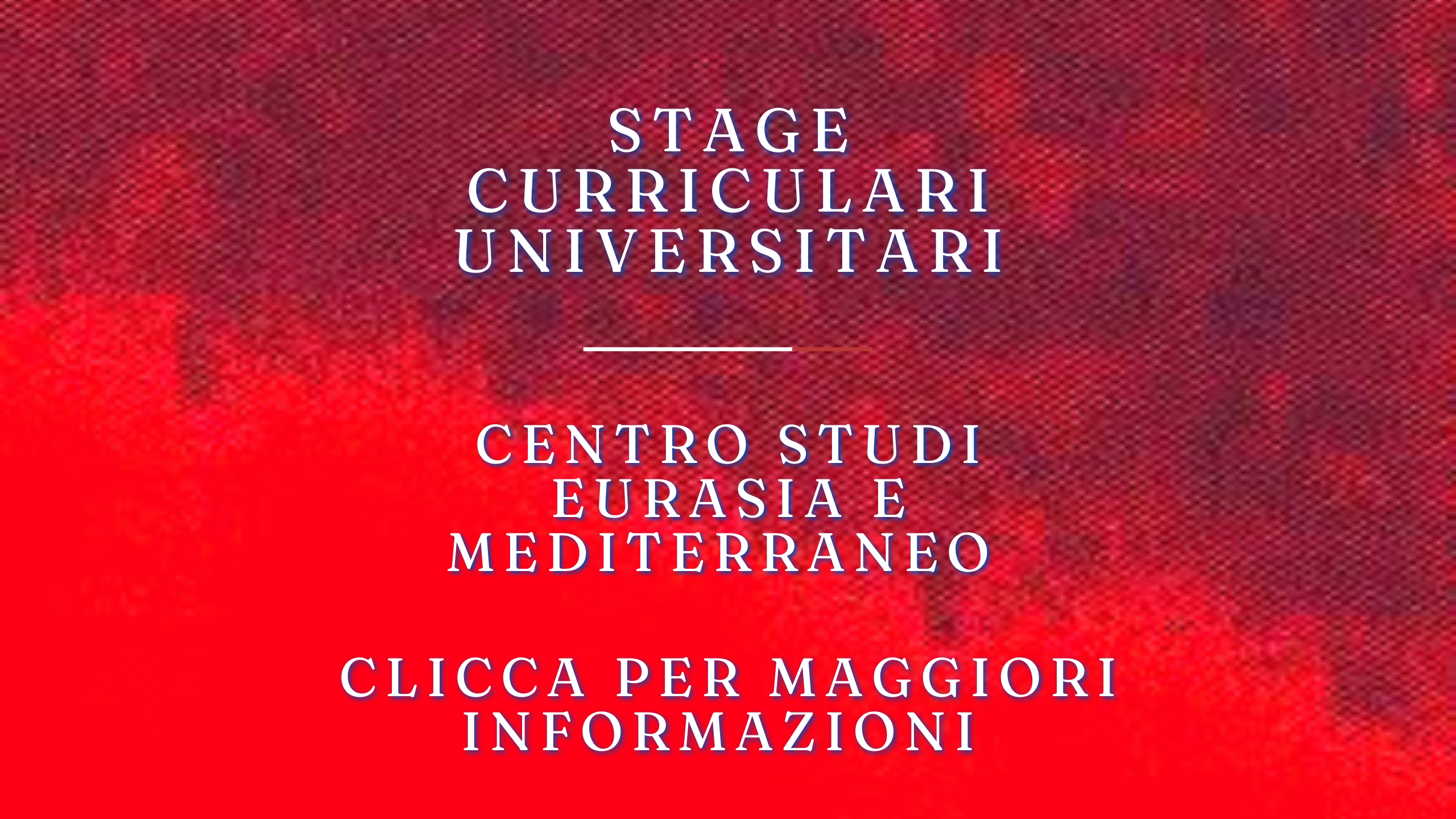

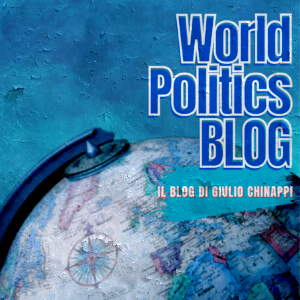
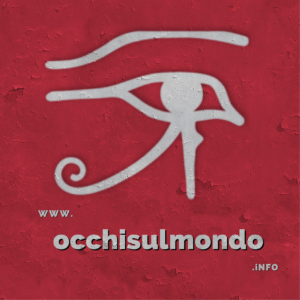









Il CeSE-M sui social