coerenza delle teorie politiche professate dal ministro degli esteri Davutoğlu. A dispetto della retorica altisonante, l’iniziativa turca appare ondivaga: se da un lato numerosi sono stati i richiami a favore della democrazia, come anche le prese di posizione a favore dei ribelli, troppo forte permane l’insicurezza per quelli che sarebbero i possibili scenari futuri in caso di caduta del regime Assad. È indubbio che a seguito delle forte critiche al regime di Assad, la Turchia si sia apertamente schierata a favore del fronte dei ribelli tramite l’invio di informale di armi e sostegno logistico. Inoltre molto significativo è anche stato l’aiuto umanitario a favore dei profughi. Ciò nonostante l’imminenza delle elezioni politiche, l’opposizione della maggioranza della popolazione a vedersi immischiata in una guerra, come anche il mancato sostegno degli Stati Uniti a favore di un intervento scoperto sono tutti fattori significativi che hanno portato il governo turco a non spingersi molto oltre a semplici prese di posizione. In questo senso, l’ago della bilancia è certamente rappresentato dalla questione curda. A partire dall’inizio dei conflitti, la popolazione curda ha sempre mantenuto una posizione ambigua, evitando di schierarsi apertamente a favore del fronte dei ribelli come di quello governativo. Di certo i curdi siriani guardano con interesse al modello di governo lanciato dai loro connazionali nell’Iraq del Nord. Nonostante la Turchia stia sviluppando dei buoni rapporti con la cosiddetta Regione autonoma del Kurdistan, assolutamente escluse restano per Ankara qualsiasi tipo di ipotesi di autogoverno sui territori turchi meridionali a maggioranza curda, se non addirittura impensabili sono le concessione di indipendenza regionale. Il dialogo recentemente lanciato con il leader storico del partito PKK Abdullah Öcalan è un fattore di speranza, ma la sua esiguità e imprevedibilità inducono alla prudenza.
Nel 2023 in occasione del centenario della Repubblica di Turchia, Erdoğan si è impegnato a portare a termine una serie di progetti urbani e infrastrutturali da lui stesso definiti come “folli” per accrescere il fasto e la potenza della Turchia nel mondo. È tutto da vedere se a seguito di questo incidente riuscirà a mantenere il consenso e il sostegno necessari per portare avanti i suoi piani. Ci si può solo augurare che anche gli alberi di Gezi Park saranno ancora lì a vederlo. Mi piacerebbe concludere questo reportage con una poesia del famoso autore turco Nazim Hikmet evocata più volte durante le proteste di Gezi Park:
L’albero di Noce
Schiuma su schiuma, la mia testa è una nuvola
Il mio interno esterno è un mare.
Io sono un albero di noce del parco Gulhane.
Nodo su nodo, pezzo su pezzo un vecchio noce
ma né la polizia né tu lo sapete.
Io sono un albero di noce del parco Gulhane.
Le mie foglie brillano di uno scintillio
come un pesce nell’acqua.
Le mie foglie sono immacolate
come un fazzoletto di seta
strappale, o mia rosa, e asciuga
le lacrime dei tuoi occhi.
Le mie foglie sono le mie mani,
esattamente io ho centomila mani
e ti tocco con centomila mani, Istanbul.
Le mie foglie sono i miei occhi, e vedo con meraviglia
e ti guardo con centomila occhi, Istanbul.
Le mie foglie battono,
battono come centomila cuori.
Io sono un albero di noce del parco Gulhane
ma né la polizia né tu lo sapete.





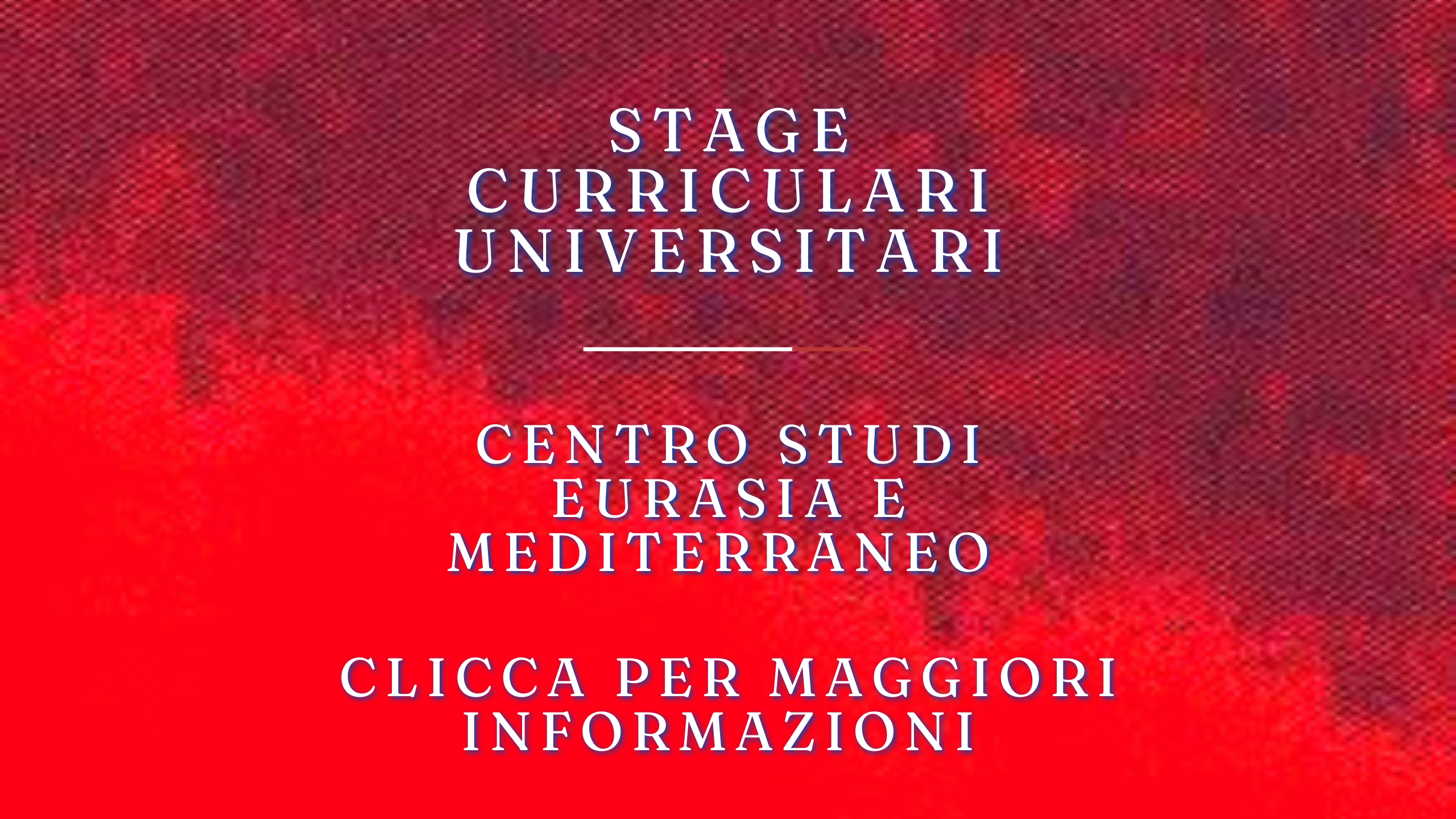

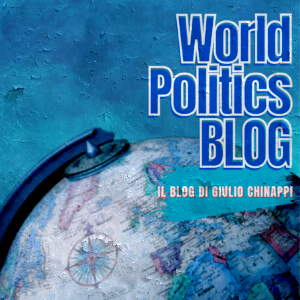
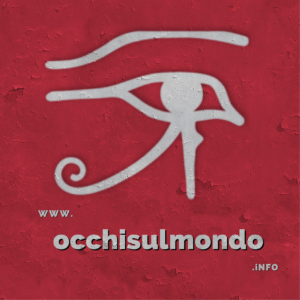




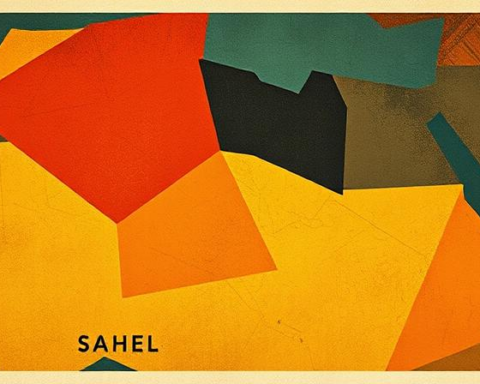




Il CeSE-M sui social